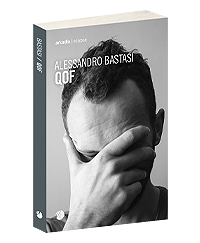Xaimaca Jarama
DA ARKADIA EDITORE “CARIBE” DI FERNANDO VELÁZQUEZ MEDINA
Non mi considero più da parecchio tempo “ispanista militante”, ma ho mantenuto il gusto per alcuni libri di qualità che ci arrivano dall’America Latina o dalla Spagna. È il caso di “Caribe”, del cubano Fernando Velázquez Medina (titolo originale: El mar de los caníbales): romanzo sfavillante, pieno di umori e di ammicchi, anche ironici, eccellentemente reso in un italiano fluido e impeccabile da Riccardo Ferrazzi e Marino Magliani. I traduttori sfoderano una terminologia tecnica assai precisa, per indicare il tipo di nave, le sue varie parti e le attività della navigazione, le armi (da fuoco e da taglio), gli esemplari di flora e fauna, ecc… Efficace anche la resa di una diffusissima imprecazione di lingua spagnola, “Porco dieci!” (per “Me cago en diez!”). L’ambientazione della vicenda è “storica”, collocandosi 150 anni dopo la conquista spagnola di quelle terre, ossia verso la metà del XVII secolo. E il libro mostra la stessa impostazione dei grandi (anche come mole…) testi di quel periodo, destinati ad alleviare, con le loro accattivanti vicende, il tedio delle lunghe navigazioni transoceaniche a vela – il Don Chisciotte, per esempio. Innanzitutto, perché questo è il primo volume di una trilogia, in cui vengono narrate (un po’ in terza, e il resto in prima persona) le complesse andanzas di un contrabbandiere mulatto che opera sulla costa di Cuba. Poi perché nella narrazione principale sono inserite (come avviene per il Cuento del Cautivo, il “Racconto del Prigioniero”, nel Chisciotte) digressioni diegetiche relative ad altri personaggi: vedi, qui, il “racconto del soldato meticcio” (pag. 178). Se la vicenda è storica, le allusioni sono però anche contemporanee. Oltre al pirata Francis Drake e a William Shakespeare, del quale il protagonista si dichiara “amico” (quasi fosse una prefigurazione di Forrest Gump, egli sembra aver incontrato tutta una serie di “vip” dell’epoca…), compaiono, per esempio, frate Uberto Eco di Alessandria (che ricorda il personaggio principale del libro principale del mio illustre concittadino, ed altrove è denominato anche “Uberto da Bologna, perché aveva insegnato in quella Università”) e “uno scrittore, forse americano, forse francese, chiamato Alejandro Carpintero”: ossia, Alejo Carpentier, autore del magnifico Los pasos perdidos, “magistrale relazione di un’altra spedizione nelle selva”, come viene qui definito. A quanto avviene nel racconto di Carpentier (uno dei libri a me più cari, tra l’altro) rimanda anche la lettura dell’Odissea, evocata in più punti. E che dire dei richiami a I tre moschettieri di Dumas padre (“uno per tutti e tutti per uno, anche se non ricordo dove ho sentito questa frase”), all’Inferno di Dante (“un gran verme”), a Francisco de Quevedo (“come scrisse un poeta che conobbi più tardi, ‘potente cavaliere è il signor Denaro’” –poderoso caballero es don Dinero) e persino a Roberto Vecchioni (“Su, su, cavallo, corri verso la morte”)? Anche il duplice nome della collana in cui il romanzo è uscito suscita cortocircuiti letterari: Xamaica è un titolo di Ricardo Güiraldes, autore argentino del celebre Don Segundo Sombra sulla vita dei gauchos, mentre El Jarama era un romanzo neorealista (un po’ tedioso, a dire il vero) dello scrittore italo-spagnolo Rafael Sánchez Ferlosio. Ma altre associazioni mi corrono alla mente, risfogliando le pagine a lettura terminata. L’episodio in cui la comitiva di indios e negros cimarrones raggiunge, attraversando un lungo tunnel, la città nascosta fra i monti si situa in un territorio letterario prossimo al fantasy, qualcosa tra Il Signore degli Anelli e la favolosa Shangri-la del romanzo di James Hilton (con pluripremiata trasposizione cinematografica di Frank Capra) Orizzonte perduto. La navigazione caraibica, l’aggressione degli indigeni e la descrizione delle loro piroghe mi fanno pensare al poema Omeros, di Derek Walcott: “Poi i tronchi, impazienti di diventare canoe,/ararono i frangenti di cespugli, scavando solchi/nei massi, non sentivano dentro la morte, ma lo scopo:/fare da tetto al mare, essere scafi. Poi, sulla spiaggia,/stesero le braci nelle cavità scalpellate con l’ascia”. E le rovine rinvenute nella selva rimandano a una strofa del Canto general di Neruda: “Maya, voi avevate rovesciato/l’albero della conoscenza./Con effluvio di razze frumentarie/si innalzavano le strutture/dell’esame e della morte,/e, gettandovi spose d’oro,/scrutavate nelle cisterne (cenotes, termine che viene illustrato nel romanzo: n.d.r.)/la permanenza dei germi”. Fernando Velázquez Medina (non posso far a meno di notare, en passant, che Fernando Medina è il nome del Sindaco di Lisbona, mentre al pittore Velázquez è dedicata un’altra nota canzone di Vecchioni, poc’anzi citato) è anche critico cinematografico – si vedano i richiami filmici ipotizzati in precedenza. Da Jurassic Park sembra aver fatto uscire il rettile gigantesco che a un certo punto aggredisce il gruppo di avventurieri, e da certe pellicole d’azione ha senz’altro mutuato (con intenti parodistici, tuttavia) l’’mprovvisa comparsa del “cattivo”, che viene a minacciare il protagonista dove e quando questi meno se lo aspetta… Non trascrivo, stavolta, brani del libro, e del resto non saprei quali scegliere, dato il livello costante della sua prosa. Ma ne raccomando di cuore la lettura. Vi garantisco che sarà davvero tempo ben impiegato.
Marco Grassano
Buona lettura 21: “Caribe”, di Fernando Velázquez Medina
Vicende sconvolgenti, episodi affascinanti, personaggi coraggiosi, irrequieti e ingegnosi che non sempre riescono a smascherare il loro lato più oscuro: ecco Caribe di Fernando Velázquez Medina, nella limpida traduzione di Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi (Arkadia edizioni).
Un romanzo picaresco dove il protagonista, Diego, si muove su e giù tra L’Avana del XVI secolo, le diverse zone delle Indie occidentali, il mare dei cannibali, le paludi e le terre di indios pervase da segreti e storie avvincenti. A passo veloce, la storia di Diego cambia e continuamente si rinnova tra sorprese e capovolgimenti, affidati dapprima all’incontro con la giovane Hortensia e poi a quello con fra Uberto Eco, frate francescano legato all’Inquisizione. Un percorso di cambiamento che lo porterà a diventare “Diego il terrore dei mari”, discepolo del tanto temuto Francis Drake. Il linguaggio piano e preciso, così come ci viene restituito da Magliani e Ferrazzi, crea il clima necessario a farci scivolare nel bel mezzo di una trama che prende linfa pagina dopo pagina e che conduce sulle tracce di peripezie dai tratti spesso trasognati.
Avventure slabbrate nascoste tra montagne, selve e paludi dove pullulano racconti di cannibali, tesori di giada, grotte piene di diamanti, barche di pietra e montagne d’oro, rumori assordanti e incontri inquietanti, lasciano intravvedere le tracce di un destino e trovano altri varchi di acuta sensibilità. E in ogni caso si avverte la naturalezza della scrittura che accompagna le vicissitudini del “guerriero” Diego e dei suoi compagni di viaggio, lesti di parola e di mano, desiderosi di godersi il sogno della conquista di altri paesi, della conoscenza e dell’incontro con il misterioso mondo degli indios. Lo stupore inquieto e vibrante del protagonista percorre tutto il romanzo e si sofferma su ogni aspetto, sempre sottolineato dallo smalto solido della lingua: dai piatti che si cucinano nei vari regni dell’impero, ai pericolosi affari contro la legge, alla sinfonia della vita silvestre tropicale. L’uomo “dalle molte vite” ci regala una storia che si dispiega da sola, aromatizzata da cieli stellati e selve ostili, in un mix di avventure senza fiato.
Mara Pardini
I rifugi della memoria – José Luis Cancho
José Luis Cancho è uno scrittore spagnolo che alle sue spalle ha un vissuto intenso. Aveva solo 22 anni quando quattro poliziotti al servizio del regime di Franco lo buttarono giù dalla finestra del commissariato di Valladolid.
Oppositore del franchismo, ha conosciuto la tortura e la galera. Membro di un partito di estrema sinistra con la militanza politica nel cuore negli anni è diventato scrittore. È alla letteratura ha affidato la sua testimonianza di uomo che fa i conti con la sua esperienza. Ha pubblicato quattro libri. Adesso I rifugi della memoria, uscito in Spagna nel 2017, viene pubblicato in Italia da Arkadia. In appena settantacinque pagine siamo davanti a un piccolo gioiello, oserei dire un grande capolavoro. Come Stig Dagerman, Cancho cerca, o almeno ci prova, nella scrittura il suo personale bisogno di consolazione. Affida alla memoria per scrivere il suo autoritratto frammentario: «Il mio proposito è andare in fondo quell’io segreto nel quale neppure a me stesso risulta facile penetrare. In parte perché, alla mia età, credo di averlo perduto». Una passeggiata nella memoria e nei ricordi con l’intento di svelare ciò che nella sua vita è occulto, con il cuore sempre nella realtà. Così José Luis Cancho si è fatto scrittore e attraverso la scrittura è riuscito a riconciliarsi con tutti i mondi che si era lasciato alle spalle, come se la scrittura fosse il punto d’incontro fra tutto ciò che è stato e quello che è oggi. I rifugi della memoria è un libro di poche e sorprendenti pagine in cui il suo autore si attraversa (ricorrendo anche alle parole della poesia), si affida ai ricordi per aprire i cassetti della memoria e mettere nero su bianco con una prosa senza filtri, senza artifici, senza travestimenti, senza retorica per cercare la traccia perduta della sua esistenza, l’orma che si era lasciato alle spalle, il luogo delle origini, la terra primigenia. La scrittura non come vocazione ma come la decisione consapevole di imparare a vivere dentro la finzione della letteratura e soprattutto scavare senza fare sconti nel proprio io che attende sempre di essere rivelato. La memoria è il motivo dei quattro romanzi che Cancho ha pubblicato. «La maggior parte dei miei ricordi li affido alla memoria. Ogni volta che ho cambiato casa mi sono disfatto di ciò che avevo accumulato: lettere, libri, vestiti, mobili…
La povertà è in intimo rapporto con l’oblio. Non esistono oggetti che aiutino a contrastarlo. Mi piace essere inafferrabile. Mi piacerebbe sparire in un paese dove nessuno mi conosce. Di tanto in tanto divento cupo».
Nella brevità di queste poche pagine intense troviamo le intuizioni di uno scrittore autentico che giustamente non sopporta le persone incapaci di esprimersi in modo sintetico e quando parlano non distinguono ciò che è importante da ciò che è secondario.
I rifugi della memoria è un piccolo libro che contiene tutta la grande letteratura. Ci auguriamo anche noi che questo piccolo gioiello riceva l’accoglienza che merita.
Nicola Vacca
Laura Freixas è scrittrice, critica letteraria e traduttrice. È cresciuta in Catalogna, ma ha profondi legami in Castiglia, ha vissuto in Francia e Inghilterra, e dal 1991 si è trasferita stabilmente a Madrid. Responsabile della collezione letteraria “El espejo de tinta”, ha portato in Spagna le opere di Amos Oz e Elfriede Jelinek. Attiva sostenitrice della letteratura femminile, è fondatrice dell’associazione “Clásicas y Modernas” per la parità di genere nel settore della cultura. Dopo una prima raccolta di racconti con la quale si fa notare già nel 1988, pubblica nel 1997 il suo primo romanzo, Último domingo en Londres, seguito l’anno dopo da Entre amigas e da Amor o lo que sea nel 2005. Gli altri sono più felici è il romanzo che le ha dato notorietà e prestigio, ora tradotto per la prima volta in italiano – da Francesca Mantura e Alessandro Gianetti – per la collana Xaimaca Jarama, curata da Marino Magliani, Luigi Marfè e Alessandro Gianetti.
I rifugi della memoria. José Luis Cancho e la scrittura come sottrazione
Può sembrare insolito che Arkadia Editore abbia deciso di pubblicare, per la prima volta in Italia, I rifugi della memoria, cioè l’ultimo libro di José Luis Cancho, scrittore spagnolo, nato a Valladolid nel 1952. Perché non pubblicare prima i suoi precedenti romanzi, dando così modo, ai lettori italiani, di avvicinarsi e scoprire questo scrittore da noi sconosciuto? A questa domanda risponde, come è giusto che sia, la lettura stessa delle pagine de I rifugi della memoria.
Opera autobiografica che, diciamolo subito, va ben al di là di un “semplice” diario o di una “semplice” autobiografia a posteriori, con gli inevitabili inciampi o bugie della memoria. Qui, storia personale e letteratura si mescolano in modo tanto inestricabile da trasformare le memorie in un romanzo. Da trasformare Cancho nel personaggio di un romanzo. Ma andiamo con ordine.
Cosa leggiamo in questo I rifugi della memoria? La storia di un giovane che, a soli 22 anni, viene arrestato e torturato dalla polizia politica spagnola e buttato fuori dalla finestra del commissariato di Valladolid. Questo inizio, che a noi italiani di una certa età, non può non richiamare la storia di Pinelli, è solo il punto di partenza per ascoltare una storia, forse uguale a tante altre, fatta di impegno politico, la prigionia, poi la libertà, l’insegnamento, i viaggi e la scrittura, la vita e la ricerca della solitudine. Tutto sorretto da una scrittura che funziona per sottrazione e che, proprio come la memoria, per sottrazione, si aggrappa all’essenziale. Che per Cancho, a un certo punto, sembra essere l’inevitabile ritorno, ai ricordi d’infanzia.
Ma perché dovrebbe interessare l’autobiografia di un uomo, di uno scrittore a noi, lettori italiani, sconosciuto? Perché tra queste pagine sembra esserci, non solo un compendio della sua attività di scrittore (che per sua stessa ammissione torna spesso sugli stessi temi, soprattutto la prigione) ma anche un interessantissimo lavorio di scrittura, di scavo psicologico, di lealtà, verso sé stesso e verso i lettori.
Il poeta è un fingitore, diceva Pessoa. Lo scrittore è un bugiardo, ci dice Cancho. E ce lo dice proprio partendo da sé stesso, dalla sua giovinezza che, caratterizzata dalla lotta politica, ne fa un personaggio abituato a dissimulare, a fingere, a inventare. Da qui la consapevolezza che l’affabulazione e la capacità di raccontare bugie (nel caso specifico per salvarsi durante gli interrogatori) sono il vero punto di partenza per scrivere. Anche se lui esordirà tardi nel mondo delle lettere.
Ma la sua intera vita sarà, lo scopriamo leggendo, un sentirsi fuori posto, un abbandonare progetti, donne e lavoro. Sarà una continua domanda su sé stesso, per diventare ciò che è senza nemmeno sapere cosa volesse dire davvero.
Scrive Andrés Barba nella prefazione al libro: “ […] l’autore è capace di dire cose obiettivamente difficili da articolare senza uscirne a pezzi, ma anche perché dimostra di avere riflettuto con equanimità, distanza e perfino disinteresse di sé e sulle persone che hanno fatto parte della sua vita. Cancho dice di voler scrivere come un morto, e accipicchia se ci riesce.”
Ecco, scrivere come un morto. Questa sarà la chiave di lettura di questo libro. E lo dice chiaramente lo stesso Cancho in apertura quando scrive: “Invecchio e il mio vocabolario si impoverisce. Mi sento come se stessi imparando una lingua straniera. Mi consolo pensando a Beckett che scelse il francese come lingua letteraria e diceva – Scrivo in francese per rendere ancor più povera la mia scrittura, per lavorare a partire dall’impotenza -.
Impotenza e sottrazione. Questo è ciò che si avverte leggendo queste memorie. Impotenza e sottrazione che sono uno sforzo, una fatica. Perché questo è la scrittura. Che per Cancho sembra approdare alla “passione per l’indifferenza” che lo porterà, in queste pagine, a scrivere “dal punto di vista di un morto” ma non per tacere, quanto semmai, per scrivere una lingua altra, per scrivere nella lingua dell’Altro. Ecco perché I rifugi della memoria, pur essendo un’autobiografia, è opera letteraria, è romanzo a tutti gli effetti.
Ci sono parole che tornano spesso in queste pagine, parole come assenza, mistificazione, finzione. Parole chiave per una scrittura in cui Cancho si muove in un continuo ribaltamento, in un continuo cambio di prospettiva. Attorno al nucleo narrativo della prigione che diventa, anche, la metafora di altri confinamenti (mentali e lavorativi, politici a sentimentali) che, quando finiscono, provocano gli stessi improvvisi vuoti, le stesse improvvise paure di affrontare nuove libertà.
Cancho, in questo libro, sembra guardarsi come un entomologo guarda gli insetti al microscopio. E sembra fare lo stesso con la sua scrittura. Ecco perché poter leggere per primo quello che è il suo ultimo libro diviene, più che una forzatura, quello che appare come un viatico per leggere, speriamo, anche gli altri suoi precedenti libri. Come se questo “compendio” fosse, in realtà, una chiave per aprire la porta della sua letteratura.
Geraldine Meyer
Un'estate ospite dai parenti in Costa Brava, cambierà completamente la vita dell'adolescente Àurea.
Caribe, le meravigliose avventure tra mari e indios
Non c’è bisogno di essere appassionati di storie di mare per provare un piacere quasi fisico nel leggere questo Caribe dello scrittore cubano Fernando Velazquez Medina, da poco mandato in libreria dalla sarda Arkadia Editore. Basta mettersi comodi e decidere di disporre di un po’ di tempo durante il quale niente e nessuno verrà a disturbare la lettura. E immergersi, è il caso di dirlo, nella storia di Diego, protagonista e voce narrante di queste avventure caraibiche.
Siamo attorno alla metà del ‘500 e il piccolo Diego, figlio di una modesta famiglia, divenuto un uomo potente, racconta la sua storia al maggiore dei suoi figli. Per lasciargli un’eredità che, oltre che di ricchezze, sia fatta, appunto, di parole e memoria.
Sotto il sole de L’Avana, tra mare e libertà, il piccolo Diego, abitante di quello che era un avamposto del potente impero coloniale spagnolo, vive tra animali marini, giochi e avventure. Fino a quando, uno sguardo di troppo a una donna, un equivoco e la longa mano dell’inquisizione, nella persona di un esagitato francescano, non lo costringerà a lasciare la sua isola e darsi alla fuga.
Compagno di viaggio, mentore e maestro, sarà un monaco italiano, studioso e uomo dalla vasta cultura ma dalla ancor più vasta curiosità. Quell’Uberto Eco da Bologna (chissà se l’autore voleva fare un sotterraneo omaggio) che lo porterà con sé a conoscere il mondo, gli uomini e altre culture, sulla scia di una volontà di scoperta: stabilire se tra maya e egizi, entrambi costruttori di piramidi, ci fosse qualche legame.
Comincia così, per Diego, un viaggio alla scoperta del mondo, magico, misteriosi e violento, degli indios. Viaggio di formazione, si può dire, durante il quale il ragazzo vivrà avventure di ogni tipo, tra corsari, mercanti senza scrupoli, navi negriere, animali feroci e sconosciuti. Un mondo in cui alla ricchezza e ubertosità della natura si affiancano pericoli di ogni sorta, un mondo in cui, che si sia uomini o animali, è un attimo passare dall’esser cacciatore all’esser preda.
Tra dispute teologiche, Diego imparerà sulla sua pelle, e dalle parole di Uberto, quanto possa essere potente la fame di conoscenza, di scoperte ma anche, e soprattutto, quanto la conoscenza possa far paura al potere, soprattutto quello ecclesiastico. E quanto il denaro e l’ingordigia della politica, siano in grado di far girare il mondo e di seppellire e bruciare uomini e libri.
Sono quasi trecento pagine di puro godimento, di storia, geografia, zoologia, arte marinara e arte dei combattimenti per mare. Citazioni colte e citazioni da libri antichi si mescolano ad avventure che da drammatiche sanno, in un attimo, divenire quasi comiche.
Insieme alle pagine di Caribe anche il lettore viene letteralmente condotto per mare e tra i rumori e gli agguati delle foreste tropicali, nei misteri delle antiche città maya, nella cultura degli indios, tra le onde dei mari delle Americhe, quel nuovo mondo che andava facendosi e che stava diventando emblema e metafora di una “modernità” non esente da contraddizioni e violenze.
Diego diventa la voce narrante di una nuova fame di espansione e di scoperte. Quelle scoperte che, come gli ricorderà Uberto, sono possibili solo quando, per ottenerle, si diventa capaci anche di andare contro il potere costituito. Ma tante saranno le cose che il giovane Diego imparerà durante il suo periglioso viaggio. Imparerà che da soli non è possibile fare nulla, imparerà che dovrà essere disposto a tutto per salvare sé stesso, a non consentire a nessuno di essere di ostacolo alla propria sopravvivenza.
Primo volume di quella che sarà una trilogia, Caribe è si un romanzo di avventura ma non solo. Molte sono le tracce sottotesto, molti i sentieri che dipartono dalla strada principale. Proprio come tanti sono i sentieri nascosti nella foresta e tante le onde e gli attacchi che posson capitare in mare. Un libro che è, prima di tutto, un inno alla voglia di conoscere, alla consapevolezza che c’è sempre un altrove verso cui tendere. Costi quel che costi. Diego diventerà grande, molto più grande della sua età durante quel viaggio, scamperà alla morte molte volte, l’inquisizione, incontrata per due volte sulla sua strada, non riuscirà a farne un’altra vittima. E il lettore lo saluterà alla conclusione del libro ma al principio di nuove avventure quando, sulla sua strada, arriverà il più famoso, grande e nobile, in un certo senso, corsaro di tutti i tempi: Francis Drake.
Che dire? Buona lettura.
Geraldine Meyer
La prima opera tradotta in Italia di José Luis Cancho. Il racconto di una vita segnata dalla politica e dal nomadismo
“Caribe” di Fernando Velázquez Medina
Viviamo in un’epoca in cui si è già detto tutto, non ci meravigliamo quindi se in un romanzo affiorano in maniera esplicita o implicita riferimenti, echi e suggestioni che ci riportano ad altre letture, come succede in Caribe di Fernando Velázquez Medina (Arkadia Editore, 17 €), del resto per quanto uno scrittore voglia apparire innovatore o trasgressivo non potrà mai del tutto esimersi o sganciarsi dalla tradizione letteraria e culturale, che attraverso letture ed esperienze dirette o mediate è filtrata e sedimentata in lui.
Dopo questa doverosa premessa, su cui torneremo in seguito con esemplificazioni più chiare ed esatte, va detto che il titolo, Caribe, ci catapulta nel Mar dei Caraibi o dei Cannibali, crogiuolo di razze e di civiltà, in un’epoca, per giunta, la seconda metà del 1500, in cui queste isole e le terre dell’America centro-meridionale, o Indie occidentali come venivano chiamate allora, furono scenario di violenze, saccheggi e uccisioni da parte dei Conquistadores.
Inizialmente Caribe si presenta come un romanzo storico per la felice commistione di elementi, situazioni e personaggi reali con invenzioni di una fervida immaginazione, ma procedendo nella lettura ci si accorge dell’abilità dell’autore, di fondere e rivisitare, nel crogiuolo della sua fantasia, generi e tecniche letterarie differenti: dal romanzo di formazione al pamphlet politico, dal racconto avventuroso (predominante) alla riflessione morale.
Il protagonista Diego Valdes, io narrante oltre che io agente, vive all’Avana, al centro di un arcipelago: “nel Mar delle Antille o delle Lenticchie, come se fosse una minestra o una zuppa che esala un vapore intenso e le isole fossero grani che galleggiano sulla superficie.”
I genitori gestiscono un’osteria e Diego fin da piccolo, oltre ad affinare il palato, rimane incantato ad ascoltare i racconti dei marinai che dinanzi a una pinta di birra o un bicchiere di rhum favoleggiano di mondi lontani, di mostri marini, di leggende meravigliose e terrificanti, che hanno pur sempre un fondo di verità, perché, come dice l’autore: “Mascherare la realtà è più semplice che inventarne una nuova.” Quest’esperienza adolescenziale, corroborata e consolidata dalla lettura di poemi cavallereschi e chanson de geste, fa di lui un vero affabulatore, dote di cui si servirà per placare l’ansia e vincere la paura nei momenti cruciali del suo cammino. La sua vita scorre tranquilla tra lo studio, i giochi e le immersioni in acqua quando l’incontro occasionale con una bella fanciulla non solo mette a repentaglio la sua vita ma rivoluziona tutta la sua esistenza. Accusato ingiustamente di omicidio dall’inquisitore, De Landa, per la falsa testimonianza della stessa ragazza, è costretto a fuggire con l’aiuto e la protezione di un rappresentante di un ordine religioso di Alessandria d’Egitto, Uberto Eco, al cui seguito rimarrà fino alla fine del romanzo.
Il nome stesso di questa singolare figura di pensatore, erudito e condottiero rimanda all’omonimo scrittore e intellettuale italiano e nello specifico a Il nome della rosa; Uberto richiama alla lontana Guglielmo da Baskerville e Diego di conseguenza, che lo segue e lo elegge a suo precettore, Adso da Melk. Anche la polemica implicita tra Francescani e Domenicani ci richiama alla mente quella, all’interno de Il nome della rosa, tra spirituali e conventuali sulla necessità o meno di praticare la povertà.
Inizia a questo punto il viaggio, che – a ben guardare – è il tema di fondo di Caribe e che, a conferma ancora una volta delle tante suggestioni, assimilate anche inconsciamente, ci riporta al viaggio dell’Ulisse dantesco: “Considerate la vostra semenza: // Fatti non foste a viver come bruti, // ma per seguire vertude e canoscenza.”
Uberto, infatti, rivolto a Diego dice testualmente:
“Il nostro viaggio non è di esplorazione, per fondare colonie, commerciare o razziare. È un viaggio in cerca di conoscenze, per ampliare gli orizzonti e la sapienza dell’umanità.”
Il romanzo si divide in due parti, nella prima viene descritto il viaggio per mare attraverso acque burrascose e infide, popolate da mostri marini e dalla terribile balena bianca. Come non vedere in questo episodio un’eco del più vasto poema che sia mai stato scritto sul mare, Moby Dick di H. Melville. Nella seconda parte la vicenda si svolge sulla terraferma, nello Yucatan, laddove la spedizione, in cerca di tracce della civiltà Maya, s’inoltra nella selva oscura, intricata e minacciosa di sapore vagamente dantesco, dove incontra non tre fiere ma tanti animali sconosciuti e pericolosi, vampiri che succhiano il sangue, serpenti grossi come tronchi d’albero e il leggendario serpente piumato della tradizione Maya, ed è questo il momento di massima tensione o spannung che dir si voglia.
Non bisogna credere che Caribe sia soltanto un romanzo di avventure, perché accanto alle disavventure dei protagonisti si possono apprezzare tanti altri motivi: l’amore per il cibo (alcune ricette sono veramente stuzzicanti), l’interesse per l’arte e l’architettura, religiosa, civile o militare, la denuncia della crudeltà del tribunale dell’Inquisizione e la polemica nei confronti dell’oscurantismo della Chiesa di Roma.
Il romanzo, se si escludono i primi due capitoli a focalizzazione zero, in cui si fissano le coordinate spazio-temporali e le atmosfere politiche e culturali del periodo, è una lunga analessi in cui il narratore rievoca, a distanza di anni, le peripezie di cui è stato protagonista al seguito di Uberto Eco. Durante il viaggio, in una sosta notturna intorno al fuoco, il narratore di primo grado cede il posto a un narratore di secondo grado, il cui racconto dura una trentina di pagine, per cui si può parlare di narrazione ad incastro e lo si rileva non per sfoggio di erudizione ma per sottolineare la struttura complessa del romanzo e la sua ben oliata macchina narrativa.
La prosa, merito anche dei traduttori, Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi, è chiara, puntuale e precisa anche nella decodificazione di termini dei linguaggi locali, mentre a livello stilistico e retorico prevalgono due figure, solo in apparenza contrastanti: l’enumerazione, l’elenco, cioè, di oggetti, animali o piante, in un approccio prevalentemente scientifico che bandisca qualsiasi forma di approssimazione e l’iperbole nella ricerca del meraviglioso o terrificante, che esercita un suo indiscutibile fascino.
Vorrei concludere questa mia disamina con una riflessione del maestro Uberto Eco; a pagina 86 si legge testualmente:
“I veri mostri sono quelli che giustificano le loro malefatte con la religione, o la patria o altre stupidaggini, per dissimulare i loro istinti assassini e la loro iniquità. Quelli sono i mostri di cui devi aver paura.”
Francesco Improta