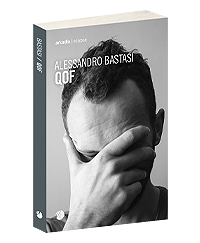I rifugi della memoria
Invecchio e il mio vocabolario si impoverisce. Più smetto di fare (andare al cinema, visitare chiese, viaggiare…) meno parole mi si affacciano in testa.
Queste parole tratte dal libro di Josè Luis Gancho, “I rifugi della memoria”, ci fanno pensare. Una vita senza un minimo di azione è una vita che impoverisce la mente. Gli stimoli bisogna cercarli, perché nulla viene per caso. José Luis Cancho, scrittore spagnolo nato a Valladolid nel 1951, nella traduzione di Marino Magliani per i tipi di Arkadia, ci porge un’opera autobiografica che si sposta un po’ da quella che è la concezione di diario, perché storia personale e letteratura si fondono con ingredienti allo zenzero da trasformare la memoria in un romanzo. L’autore è il protagonista assoluto di questa vicenda e narra in prima persona, dalle pagine iniziali, senza tirarsi indietro perché, se anche le parole vengono meno, se sono passati parecchi anni da quei fatti, la memoria resta viva e vigile nella mente del protagonista. La storia di un giovane che viene arrestato e torturato dalla polizia politica spagnola e poi scaraventato in strada, buttato da una finestra dopo un pomeriggio e una notte trascorsa in una stanza al terzo piano del commissariato di Valladolid, sottoposto a ripetuti pestaggi da parte di quattro sbirri. Prima di essere scaraventato di sotto il protagonista è oggetto di ripetute torture dei poliziotti che si divertono a farlo rinvenire quando perde conoscenza per poi continuare con le percosse, fino alle prime luci del mattino, dove lo invitano con la forza ad avvicinarsi alla finestra per fargli fare un volo dal terzo piano. Segue la travagliata esperienza del carcere, le ore di isolamento immerse nella lettura, disperatamente ancorato a un’idea profonda di libertà. Un essere umano che dopo la detenzione rientra con difficoltà nei binari della società civile. L’esperienza di recluso si accompagna alla scelta di abbandonare la militanza, quella militanza che, però, il protagonista non rinnega. Quando il partito gli aveva assegnato il compito di formare una cellula nella facoltà di Magistero, ecco che il carcere, l’isolamento, lo spingono a un’idea di libertà mettendolo in contrasto con un mondo cui era sempre appartenuto. E allora i lunghi viaggi in America Latina, conducendo una vita da nomade, tra l’Argentina, la Bolivia, l’Equador, il Cile alla ricerca di quella libertà tanto agognata dietro le sbarre. E quel continuo girovagare placa in un certo modo la sua fame di spazio libero. Ho avuto l’impressione leggendo questo libro, con una prosa cristallina, di un io narrante che va a cercare consenso con il lettore, pur mettendo, senza nascondersi, al centro se stesso come il faro di un palcoscenico sul protagonista. In questo accostamento un po’ ruvido, direi positivamente ruvido, Cancho ha la consapevolezza di essere un grande affabulatore, spregiudicato, volgendo al passato non con rancore, malinconia o qualche altro sentimento all’apparenza fragile. Lo fa con decisa fermezza, con vigore, schiacciando l’acceleratore in discesa con il rischio di andare a sbattere. Nulla di religioso, di elegiaco, ma la fermezza del sangue che affonda nelle radici della terra. Sembra facile gettare uno sguardo all’indietro per raccontarsi, ricostruire con la memoria, ricordare, portare in scrittura un passato. Difficile è presentarsi nudi, senza falsificazioni, senza voler nascondere nulla. Volgere lo sguardo all’indietro con questa visione non è semplice e diventa un atto di grande creatività. Se la narrazione vive di immaginazione, si nutre di invenzione, non si può a priori sottovalutare una fedeltà alla memoria, perché quella fedeltà è un’arteria che congiunge e dove fluisce il sangue di chi scrive di chi legge. Un rapporto alla pari con il lettore, quasi la ricerca di una complicità più che un assenso. Cancho riporta sulla pagina la memoria e ci mette l’anima, un mare in burrasca che trova il suo approdo o la sua deriva dall’altra parte della barricata e lo fa scavalcando la storia e il suo carico ideologico. La bellezza di questo breve libro, con poche pagine, racchiude gli ingredienti di un microcosmo bellissimo e di una mente lucida e attenta, dove la tetra realtà del protagonista trova grandi spiragli di luce. C’è la ricostruzione della memoria che trova spazio come un ciuffo d’erba in una colata di cemento, un piccolo mondo che mette in quarantena quanto di bello c’è stato. Un libro da non sottovalutare, ricco di un’umanità con una spudoratezza allo sfinimento. Insomma, non bisogna scavare nei ricordi, la memoria ci accompagna. Sempre.
Giorgio Bona
Il link alla recensione su Lavoro e Salute: https://bit.ly/3olPrrh