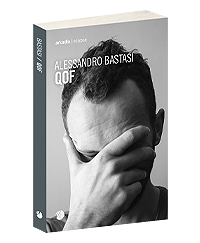SideKar
ELENA RUI ANTEPRIMA. AFFETTI NON DESIDERATI
Contenuti curiosi: “La borsa era talmente piena da rendere difficile la ricerca. E infatti tirò fuori prima un lucchetto, poi tre graffette incatenate, un pettine, due preservativi, un ciuccio, un rossetto, sicura che le chiavi sarebbero apparse per ultime”. Felicità fuggente: “«È come se la gente non lo sapesse ancora dopo millenni… Voglio dire… è strano no? Tutti credono di non essere felici per quella cosa che non hanno avuto. Ma quelli che ce l’hanno mica sono più felici.»”. Che cos’è l’amore: “Pietro aveva teorie precise e inscalfibili sull’amore: biasimava i colleghi, gli amici e i conoscenti che abbandonavano un letto tiepido per uno caldo. Diceva che il tiepido è il destino ineluttabile del caldo e che non ha senso passare la vita a cercare qualcosa di tanto effimero come la passione”.
È in libreria Affetti non desiderati di Elena Rui (Arkadia 2024, pp. 124, € 15).
Elena Rui, scrittrice, con la sua raccolta di racconti Fiale ha vinto il “Premio Malerba” ed è stata pubblicata l’anno successivo dalla MUP di Parma. Nel febbraio del 2021 Garzanti ha pubblicato il suo primo romanzo La famiglia degli altri che ha riscosso un buon successo di pubblico e critica. Miriam ha accettato un appuntamento con un cliente che l’ha corteggiata, sperando che vada bene perché ha lasciato le chiavi di casa. Patrizio è a Nizza per ritrovare l’ispirazione artistica, ma l’aggressività lo tormenta. Anna e François hanno litigato durante una cena romantica. Lidia ha lasciato il marito ma il nuovo monolocale è infestato dai topi. Amina vuole mantenere il lavoro in un hotel parigino ma il marito preferirebbe vederla a casa. Racconti di uomini, di donne e dell’amore come prova che ci svela quanto siamo inadeguati nelle nostre relazioni.
#
Riconosco il dolo, non la premeditazione. Ma mi lasci raccontare la storia dall’inizio. Le cose sono sempre più complicate di quello che sembrano. Non c’è stato nulla di sordido o di… perverso fra me e Tedeschi. Ci siamo scritti per mesi senza mai vederci: messaggi casti, pieni d’imbarazzo e di pudore. E poi guardi che le prime volte non è stato un granché. A letto, intendo. Poi con il tempo abbiamo imparato a conoscerci e alla fine è vero che siamo diventati due ottimi amanti. Ma siamo scivolati prestissimo, senza transizione, in una sollecitudine affettuosa davvero intollerabile, peggio di un matrimonio. Ha presente quel sentimento sciapo, fraterno o addirittura paterno? Una cosa umiliante. Sì, sì, lo scriva, pure. Mi era sembrato – in un primo momento non avevo elementi che mi permettessero altre interpretazioni – che una volta rassicurato sulla sua prestanza, Tedeschi si fosse sentito intralciato dal desiderio che aveva risvegliato. La verità si è rivelata peggiore, come ben sa, ma guardi, fosse stato anche solo il banale voltafaccia di chi si è stancato della solita minestra… beh, insomma, la libido di una donna che si avvicina alla menopausa va trattata con rispetto, non crede? Il mio corpo ha smesso d’interessarlo piuttosto presto… Sta scrivendo? Sì, sì, certo, scriva: è importante.
(incipit del racconto Audiofilia)
Carlo Tortarolo
Il link alla recensione su Satisfiction: https://tinyurl.com/3fzdf8c5
Ariase Barretta, nessun corpo è sbagliato
Nato a Napoli, si è laureato all’Istituto Orientale per poi proseguire gli studi presso le Università di Modena, Barcellona e Madrid, dove ha conseguito un Dottorato in Letteratura ispano-americana. Nel 2009 ha vinto il Premio Letterario “La voce dei sogni” a cui ha fatto seguito la pubblicazione di Litany. Successivamente ha pubblicato i romanzi Darkene (2012), Psicosintesi della forma insetto (2014), H dalle sette piaghe (2015), premiato come miglior noir al Festival “Giallo al centro” di Rieti, e Living Fleshlight (2018), tutti editi da Meridiano Zero. Nel 2018 ha fondato, insieme alla performer Manuela Maroli, il duo di Letteratura performativa Sacrificium Viduae, con cui ha realizzato le opere Luce di carne viva e Le lacrime di Venere. Attualmente si occupa di Queer Art e Transmodernismo, con particolare riferimento all’opera dell’artista e scrittore cileno Pedro Lemebel. Il suo ultimo romanzo, Cantico dell’abisso per Arkadia Editori, tratta di un abisso profondo, nero, apparentemente insuperabile. È l’abisso della paura che diventa normalità.
Chi è Ariase Barretta?
Non lo so. Non ho mai incontrato Ariase, è una entità che si manifesta a tratti. Tra le mie molteplici personalità c’è anche questo signore. Non mi conosco e ne sono contento perché quando ti conosci troppo arrivi a proteggerti ed eviti di sperimentare determinate situazioni. So dove mi trovo, quello sì! Mi riferisco alla mia ubicazione geografica, in senso logistico: per esempio oggi sono a Bologna ma mi muovo continuamente tra Napoli, Madrid e Bologna. In aeroporto hanno pensato di dedicarmi un gate con una targa con il mio nome.
E per quanto riguarda il percorso della tua carriera, in che punto ti trovi?
Posso risponderti che ho la sensazione di essere sempre a zero. Nonostante abbia fatto tante cose nei mie 50 anni, e mi riferisco agli studi, ai libri pubblicati, quelli tradotti e ai progetti culturali, io continuo a concentrarmi sulle cose da fare più che su quelle già fatte. Per esempio, a fine Maggio esce in Spagna il mio saggio di critica letteraria sullo scrittore cileno Pedro Lemebel, e per fine anno uscirà anche in Italia. Per la prima volta mi autotraduco, il saggio è nato in spagnolo perché è parte della mia tesi di dottorato. Nel 2025 uscirà un altro saggio su una tematica completamente diversa. Sono contento dei miei progetti futuri.
Parlando di traduzione, hai trovato qualche differenza tra tradurre ed autotradursi?
Autotradursi è molto più difficile. Quando traduci un altro autore, senti la responsabilità verso quella persona e ciò ha un certo peso. Quando traduci te stesso, in questo senso sei più sereno perché non tradisci te stesso, sai cosa hai scritto. Tuttavia, la difficoltà è dettata dal fatto che ragioni costantemente in due lingue diverse. In questo caso io ho scritto il libro nella mia terza lingua, lo spagnolo, e non nella mia lingua madre, il napoletano. Per me l’italiano è una seconda lingua perché l’ho imparato a scuola; in casa mia si parlava il napoletano, ed io il napoletano lo parlo e lo scrivo, quindi per me è la mia lingua madre. Detto questo, immagina l’arzigogolo mentale in cui mi muovo, tra un po’ il mio cervello andrà in fumo… ho scritto il libro nella mia terza lingua, lo spagnolo; l’ho tradotto all’italiano, la mia seconda lingua e in questi passaggi ho dovuto fare molta attenzione alle interferenze linguistiche.
I tuoi libri spaziano dal genere distopico, al noir, alle tematiche LGTB+ e alla fantascienza…
C’è un po’ di tutto. Per esempio “Litany” è un romanzo lirico, un po’ fiaba dark, gotica con una componente alchemica e dei miei libri è un caso a parte, non ho più scritto nulla di simile. Poi c’è la trilogia ambientata a Napoli “Darkene”, “Psicosintesi della forma insetto” e “H dalle sette piaghe”. Darkene fu definito da Sergio Pent sul Corriere della Sera un romanzo di iperrealismo sociale. Gli altri sono stati poi etichettati come psico noir e, in effetti, “H dalle sette piaghe” ha vinto un premo in un festival noir a Rieti. Io non mi sono mai posto il problema del genere a cui aderire. Il romanzo successivo, “Living Fleshlight”, però, è a tutti gli effetti un romanzo di fantascienza distopica. Mentre “Cantico dell’Abisso” inaugura una trilogia di romanzi ambientati a Bologna. Ha vinto anche un premio di cui vado molto fiero: il Premio DEI (Diversità, Equità e Inclusione), assegnato ogni anno a Perugia. Tratta il tema del transgenderismo, se proprio vogliamo etichettarlo. Ma in realtà ha tante implicazioni psicologiche diverse. Parla della famiglia, dell’ipocrisia, ed è ambientato nella Bologna bene degli anni 80.
Cantico dell’Abisso è considerato un libro sincero e duro come un pugno nello stomaco…
Certo, perché in questo libro si parla di ipocrisia. L’ipocrisia di costruire una facciata che vada bene a tutti. È stato complicato pubblicarlo, così come lo era stato per Living Fleshlight, in cui si parla di una tematica molto forte,ossia l’abuso nei confronti delle donne, donne trasformate in bambole. In “Cantico dell’Abisso” io racconto la storia di un ragazzino che ha 13 anni, nel 1987, che oltre ad avere un’espressione di genere non conforme al sesso che gli è stato attribuito alla nascita – non si sente né uomo né donna, è un soggetto Gender fluid – è anche innamorato di suo padre. Questo amore poi verrà anche vissuto fisicamente. Possiamo dire che è una situazione scabrosa ma non irreale, queste cose avvengono continuamente e questo romanzo, in effetti, è basato su fatti reali. A ogni modo, il vero personaggio negativo di questa famiglia è la madre perché accetta questa situazione per sua convenienza a discapito di tutti coloro che la circondano. Una madre che insieme alla sua amante, ex suora, è capace di atti di puro sadismo. Molte persone, dopo averlo letto, mi hanno detto che una storia del genere non può essere vera, eppure lo è! È reale!
Living Fleshlight, un libro di fantascienza distopica, dove si parla di abuso sulle donne e Cantico dell’Abisso che tocca la tematica del transgenderismo. Due temi in auge ma con una accettazione diversa da parte della società. Credi che ci vorrà ancora del tempo per poter normalizzare la situazione relativa all’espressione di genere in Italia e arrivare a sentirsi veramente liberi?
Penso di sì. Tieni in conto che non solo le case editrici hanno storto il naso di fronte a queste opere – anche in maniera molto violenta – ho ricevuto pesanti critiche anche da parte della stampa. Persone che non hanno voluto nemmeno parlare del libro e che poi in privato mi hanno attaccato perché secondo loro, si tratterebbe di un romanzo “scorretto”. La differenza tra i due libri è che Living Fleshlight ha una componente metaforica, il tutto viene raccontato attraverso una realtà che non esiste, anche se quando parlo di queste donne fatte a pezzi, in realtà sto parlando delle donne reali. Purtroppo, l’idea di fare a pezzi il corpo delle donne e darlo in pasto alla gente è una norma nell’ambito della comunicazione, soprattutto quella pubblicitaria. In “Cantico dell’Abisso”, invece, si rompe un tabù. Agli italiani si può toccare qualsiasi cosa tranne la sacralità della famiglia. La famiglia è l’archetipo su cui si fonda un certo tipo di società. Toccare la famiglia significa rompere un tabù molto forte e per l’italiano medio diventa destabilizzante vedere attaccata una sua certezza. Bisognerebbe iniziare ad accettare che la famiglia non è sempre un luogo di protezione, anzi, spesso è un luogo di distruzione. Personalmente credo più nei rapporti che non sono quelli di sangue perché le persone le scegli in base alle tue affinità. Il rapporto di sangue non lo scegli, ti viene imposto dalle circostanze e dalla natura. Il protagonista del libro, per esempio, a un certo punto incontra una ragazza che si prostituisce insieme a lui e che diventa la sua nuova famiglia.
E tu che rapporto hai avuto con la tua famiglia? Quanto c’è di autobiografico in questo libro?
Ho avuto un rapporto meraviglioso, sono stato fortunatissimo. La mia famiglia io l’avrei scelta. I miei genitori mi hanno dato il massimo dell’amore che si possa dare a un figlio. Mio padre c’è ancora, ha 91 anni ed è ancora meraviglioso; mia madre non c’è più, ma anche lei mi adorava. Leggeva tutti i miei libri, non le piacevano, era il mio peggior critico e diceva che nei miei romanzi c’era troppo sesso e troppa violenza. In “Cantico dell’Abisso”ci sono alcune cose che posso definire autobiografiche: io mi considero un individuo agender, nella misura in cui considero i generi costrutti sociali, convenzioni che rifiuto, quindi non mi sento né uomo né donna, mi sento Ariase Barretta. C’è un altro elemento autobiografico: il fatto che io abbia sempre adorato mio padre. Sì, forse questo complesso di Elettra, di innamoramento nei confronti del padre, potrei dirti che è autobiografico. Per me mio padre è l’uomo più bello del mondo. A parte questo e qualche piccolo episodio, per fortuna di mio non c’è altro.
Visto che la società sembrerebbe non ancora pronta per questi temi, date le critiche, non pensi che quello che scrivi possa limitare la tua carriera di scrittore?
Non riesco a valutarmi come scrittore però, con assoluta certezza, so che per il mio successo sarebbe molto più semplice scrivere su altre cose e andare più facilmente incontro ai gusti dei lettori e alle richieste degli editori. Tuttavia, io sono contento così: non voglio essere più ricco o più famoso di quello che sono. Voglio solo essere Ariase Barretta, amato da quel numero circoscritto di persone che per me contano qualcosa.
Cosa vuoi dire ai tuoi lettori?
Voglio dire loro di non fidarsi del conformismo perché nasconde meccanismi crudeli, perversi e distruttivi. Mi riferisco al conformismo sociale, ma anche a quello letterario, anzi pseudo-letterario, che è l’antitesi della letteratura.
Grazia Giordano
Il link all’intervista su Senza Linea: https://tinyurl.com/5x4rxu7d
Parliamo della raccolta “La forma del desiderio” con Andrea Magno
“Per scrivere ho solo bisogno di vivere, di curiosare, di conoscere, di dialogare e confrontarmi”.
Andrea Magno torna in libreria con una raccolta di poesie dal titolo La forma del desiderio (Arkadia 2024); quando l’ho incontrato, un paio d’anni fa a un festival, Magno non faceva niente per sembrare un poeta, non si atteggiava – come si dice a Roma – e non tentava di sembrare aulico o lirico fuori ordinanza. Ho preso il suo libro e l’ho aperto a caso. Ho letto qualche parola: “– cominciare – / è una parola bellissima”, e mi è venuta voglia di farci quattro chiacchierare su poesie, poesia e poeti.
Buongiorno Andrea, la tua prima raccolta poetica è del 2014 (Sotto falso nome), dieci anni fa. Questo nuovo libro, La forma del desiderio, celebra un anniversario?
Buongiorno e grazie Paolo, e un grazie anche a chi ci leggerà. Anche se può sembrare, a quasi dieci anni esatti dal mio primo libro, non si celebra nessun anniversario, che poi gli anniversari mi sanno anche di commemorazione. In mezzo ce ne sono stati altri due, parlerei di una cadenza quasi triennale, in fondo seguo il consiglio del buon Enrico Nascimbeni. All’uscita del primo libro mi disse che un libro è come un figlio e che come tale va seguito. I libri di poesia, in particolare, hanno vita lunga bisogna dare loro attenzione per almeno due anni. È in pratica quello che ho fatto. La poesia ha tempi lunghi di sedimentazione. Più che un anniversario io lo sento come una festa, per me è la festa delle parole, le mie.
Quando hai scoperto la tua passione per la scrittura poetica?
Per la lettura non c’è una data precisa. Negli anni del liceo ho iniziato leggendo Vincenzo Caldarelli e poi Montale, Salinas, Quasimodo, Bukowski. Mi piace anche citare Asimov, perché sono appassionato di fantascienza.
La scrittura invece è nata una decina di anni fa, oserei dire per caso. Nata sui social. Mi hanno iscritto in un gruppo “Scrivi un romanzo in dieci parole”, ho cominciato a scrivere delle cose e mi piaceva molto. Col tempo le dieci parole sono diventate di più scoprendo che mi veniva quasi naturale. Poi la sorpresa di essere notato da Enrico Nascimbeni e quindi la prima pubblicazione in una collana da lui curata. Probabilmente la mia poesia navigava sottotraccia e improvvisamente è venuta fuori. Il mio professore di filosofia del liceo ha scritto di me: “La prima volta l’ho conosciuto quando di anni ne aveva sedici. La sua vita, come la nostra, ha attraversato montagne russe e acquitrini melmosi. Ma in un cantuccio della memoria la sua mente continuava a coltivare, stilemi, lexemi, baci di vocali, jazzistici incontri di vocali e consonanti”.
Quanto tempo hai impiegato per raccogliere i versi di questa raccolta?
Per scrivere ho solo bisogno di vivere, di curiosare, di conoscere, di dialogare e confrontarmi. Sono questi gli irrinunciabili generatori di emozioni, anche perché non ho una formazione poetica o letteraria essendo i miei studi, liceali e universitari, scientifici. Ritengo, piuttosto, di essere fortunato per aver ricevuto il dono di riuscire a trasfondere le emozioni nelle parole, almeno così dicono. In realtà non c’è un tempo definito. Questi versi vanno dal 2017 (anno di pubblicazione del mio secondo libro) a oggi se ci riferiamo alla loro scrittura. Tecnicamente invece per diventare libro diciamo che c’è stato un lavoro di quasi un anno insieme all’editore visto che le poesie scritte sono molte di più, per scegliere quali e per la loro rappresentazione grafica. Il mio scrivere poesie non ha l’obiettivo libro, anche se poi in un certo momento nasce l’esigenza libro e l’esigenza di una omogena rappresentazione di tutte quelle parole buttate su fogli.
Già dal titolo della raccolta emerge potentemente una parola che è anche un simbolo: desiderio. Che cos’è per te, come uomo e come autore?
Spesso “desiderio” viene associato a “mancanza” e in effetti se si va a guardare l’etimologia della parola che viene dal latino “assenza di stelle” potrebbe anche essere. Io invece auspicherei di considerarla in maniera diversa, non una mancanza ma una presenza spesso immaginaria a cui fare riferimento per seguire una strada, una stella che ci indichi il cammino. Mille e poi ancora mille possono essere le forme assunte dal desiderio durante la nostra vita. Uno sprone ad andare avanti, a perseguire i sogni. Credo non ci siano differenze tra uomo e autore, il desiderio è uno dei casi in cui l’intento di entrambi tende a coincidere e a perseguire lo stesso scopo nel senso lato del termine, il primo magari in silenzio mentre il secondo con le parole. Aggiungerei che il desiderio è una astrazione, e non deve mai diventare voglia di possesso, perché diventa compulsione ed è altra cosa. In una poesia passata l’incipit recita “Non voglio possederti, perché se ti possedessi potrei perderti, e questo sarebbe insopportabile”. Questo sarebbe la perdita del desiderio e quindi del vivere.
In una poesia, A morte, scrivi tra l’altro: Uccidete i poeti/sono solo uomini fatti di parole. La parola poetica può essere una colpa per la nostra società?
Non casualmente parlo di uccisione del poeta/uomo e non della poesia. No, la parola poetica non può essere una colpa, infatti non viene mai additata la poesia, ma il poeta, chi prova a diffonderla. Dico sempre: “Che poi a scrivere poesia che ci vuole, prendi le parole e le metti in fila, senza nessuna colpa. Poi ognuno ci troverà la colpa che vuole”. Le parole non hanno mai colpe, è l’uso delle parole che è colpevole in senso positivo o negativo, ma comunque colpevole. Aggiungerei che uccidere i poeti è un simbolismo nel quale mi rifugio per ricordare la trascendenza dell’essere umano che richiede la libertà e la capacità di vedere oltre l’urgenza immediata, e spesso egocentrica, contrapposta a un vuoto interiore che spesso si cerca di riempire con le parole, che non muoiono mai.
Mi sembra che scegli per i tuoi versi parole di uso quotidiano, quindi non ricerchi parole singolari, termini rari?
Gesualdo Bufalino ne Il Malpensante scriveva: “Scrivo poesie che si capiscono, devo sembrare un cavernicolo”. In realtà non mi sono mai posto il problema, qualche “termine raro” capita anche a me di usarlo, ma solo perché funzionale al testo, e non per arricchirlo. Sono per una poesia diretta, senza fronzoli, non lunga e che arrivi al dunque senza orpelli, in cui l’immagine racconti in maniera immediata l’emozione. Questo non vuol dire che sia la maniera corretta, ma credo dopo anni a me la più congeniale. Sarà un mio limite, ma ho due condizioni per la poesia, non devo girare foglio per finire di leggerla e non devo avere vicino il vocabolario. Probabilmente il mio lessico è scarno e a corto di parole edulcorate, ma è il mio modo per arrivare al lettore. Una presunzione la mia.
Come lavori per scrivere una poesia?
Spesso mi chiedo se siamo noi a scrivere le poesie o siano le poesie a scrivere noi. Credo che la poesia sia già dentro di noi, dentro tutti noi, poi per alcuni accade la magia dello scrivere, del riuscire a esternare. Qualche tempo fa scrissi che il poeta “racconta di noi senza avarizia, non concedendo alibi alla vita” . Ecco, direi che il poeta ha la fortuna di riuscire a tirare fuori i versi nascosti dentro, sconoscendo l’avarizia nella generosità del dare e, senza concedere, ma soprattutto senza concedersi alibi; la poesia è un regalo che la vita ci concede, che ci prende per mano, e ci accompagna nel nostro viaggio, una trasparenza di emozioni che avvolge le parole. Non c’è un vero e proprio lavoro, block-notes e una penna in tasca sono una cosa irrinunciabile, quasi come acqua nel deserto della quale non si può fare a meno. È più forte di me, quando balena un pensiero o vedo o sento qualcosa che mi suggerisce, allora devo metterlo nero su bianco, buttarlo lì senza stare a pensarci, senza nessuna elaborazione, e magari resta lì per mesi, poi in un attimo la scintilla. Nascono così le mie poesie, poche correzioni e qualche limatura. Senza nessuna ansia.
Più di una volta isoli in un verso solo una “e”, qual è il peso che dai a questa lettera/parola?
Mi ha incuriosito, e sono andato a guardare questo mio uso della “e” inconsapevole, cercando di farlo diventare consapevole. È un taglio netto nei versi a sottolineare la contiguità e sovrapposizione contemporanea di due immagini, a volte tre. Un modo per rafforzare la sequenza. Ma è anche un modo per indugiare sui versi precedenti, preparandosi alla lettura di quelli successivi. Un momento di pausa per chiedersi dove sto andando e da dove sono arrivato. Indubbiamente un grande peso nella mia scrittura, immagino anche dovuta a un momento di pausa di riflessione nella stesura definitiva della poesia. Un accodamento che dà lo stesso valore e la stessa dignità ai versi precedenti e successivi anche se separati da una sola “e”.
Una parola che torna spesso è “culo”, che spazio ha il sesso nella tua ispirazione?
Premesso che viene ripetuto solo quattro volte, non vorrei si pensasse troppo male (sorrido) anche se il sesso di primo acchito può sembrare l’ispirazione predominante, in realtà lo è, si trasforma sempre in qualcosa di etereo e irraggiungibile. In una dico “fu un illecito/quel tuo culo,/non feci in tempo/a non guardarlo/e mi fottesti.” In un’altra “giudicando affrettatamente/dimenticò/la lode al culo/perdendo l’occasione”. Il “culo” e non c’è altro modo di dirlo, di usare altra parola che non sia questa, è dematerializzato, non è puro sesso. Nell’eccezione più comune forse sì, per me è solo una delle forme che può assumere il desiderio. Mi viene da pensare al desiderio di bellezza, e proprio la bellezza mi riconduce alla sezione aurea, a quella spirale meravigliosa che ritroviamo in qualunque cosa sprigioni bellezza, e a cui Fibonacci diede un nome, no, non lo chiamò “culo” ma “serie aurea”. Tutte le “forme” che attraggono, siano esse concrete o visioni, tutte (o quasi) ricadono dentro la sezione aurea, la perfezione, ma è la perfezione che percepisce il nostro occhio, la nostra mente, siamo sempre alla ricerca delle bellezza che deve essere inaccessibile altrimenti cessa il desiderio. E comunque il sesso e l’attrazione hanno sempre un loro perché soprattutto quando i versi diventano carnali, e la passione incute quel timore reverenziale a cui non riusciamo mai a sottrarci. Infatti non a caso ho scritto anche: “quel culo/– visto da qui –/una distrazione di certe notti”.
L’ultima lirica della raccolta comincia così: “Dal ruolo di poeta/mi affranco,/sarebbe barare”. Cosa vuol dire per te il ruolo di essere poeta?
L’ultima lirica è un saluto, un arrivederci. Vi saluto e adesso da poeta torno a essere l’uomo. Non so se essere poeta è un ruolo, di sicuro so soltanto che quando le parole finiscono su un foglio di carta cominciano a pesare, di qualunque tipo siano. Il ruolo del poeta, se un ruolo c’è, come per chiunque scriva, credo sia quello di dire la verità, senza sotterfugi, chiara e pulita, spiattellata lì, forse per il poeta ancor di più. Il “dono” della sintesi dovrebbe aiutare anche a denunciare, ribellarsi, e questo credo che avvenga magari dietro maschere che non smettiamo mai di indossare. Ognuno ha la sua maschera, il poeta ne indossa sicuramente una, e così anche ogni lettore. Una bellezza i lettori, perché ti fanno scoprire cose che non pensavi di aver mai scritto. Chiudo, non prima di averti ringraziato, con dei versi citati da Salvatore Basile nella prefazione:
… oggi la parola si allunga
nell’ora della tristezza
e adesso ognuno al suo posto,
io resto qui, mi sistemo la maschera
tra scena e orchestra,
e adesso musica.
Paolo Restuccia
Il link all’intervista su Storygenius: https://tinyurl.com/fbtum3fr
AFFETTI NON DESIDERATI di Elena Rui
La dimensione narrativa breve non è particolarmente amata dal pubblico italiano (soprattutto dagli editori italiani); eppure, una mole esigua può coesistere con la profondità e mostrare, attraverso un frammento di esistenza, tutto un mondo. Affetti non desiderati è il titolo dell’ultima opera di Elena Rui, una raccolta di racconti appena pubblicata da Arkadia Editore. Quello degli affetti non desiderati è un territorio di cui tutti abbiamo esperienza: chi, almeno una volta nella vita, non ha subìto malvolentieri l’attaccamento di una persona percepita come molesta, superflua, sgradevole, nella migliore delle ipotesi patetica? Viceversa, a chi non è capitato di provare sentimenti benevoli non ricambiati o che, addirittura, suscitano l’ostilità della persona che ne è destinataria? Nei nove racconti che compongono la raccolta si narrano, appunto, relazioni d’amore e d’amicizia sbilenche: il termine è usato dall’autrice in Compromessi, storia dell’incontro fra un tredicenne non omologato ‒ che ama i libri e cerca il confronto con gli adulti estranei alla sua famiglia ‒ e un libraio trentottenne introverso e irrisolto. Fra i due nasce una comunicazione e, per un momento, un legame significativo, nonostante la grande differenza d’età. La disparità, lo sbilanciamento caratterizzano tutte le storie della raccolta, in una carrellata a volte amara e a volte divertente di relazioni per un verso o per l’altro non paritarie: per età, per condizioni sociali ed economiche, per la diseguale intensità dei rispettivi sentimenti. Si tratta talvolta di relazioni in bilico fra l’essere troncate e il proseguire stancamente, come nel racconto Più di Xavier. O di un legame incrinato che un evento esterno ricompatta (Inquilini). In alcune storie prevale l’aspetto sentimentale, oggetto della narrazione sono l’amore e il disamore; in altre sono in primo piano la sfera erotica, il desiderio, la seduzione, come nel racconto I calzettoni (“Penso al tiepido, che è il destino del caldo, al caldo che diventa inesorabilmente tiepido e che quindi, forse, è una chimera”, riflette malinconicamente Elisa, la protagonista e voce narrante, a proposito della passione e della sua inevitabile parabola); in altre ancora, incontriamo personaggi intenti alla dissezione degli amori passati che diventa occasione per riflettere sulla propria personalità, sui propri limiti. Alcuni racconti sono brevi e folgoranti, quasi fotogrammi che, in controluce, lasciano trasparire il passato e intuire il futuro dei personaggi, sui quali l’autrice posa uno sguardo indulgente, pur mostrandoli in tutta la loro (nostra) povera umanità. L’amore ‒ quante volte l’abbiamo sentito dire? ‒ è un tema abusato e quindi ormai poco interessante. Ma ciò varrebbe anche per la guerra, la violenza, l’amicizia, il tradimento, i legami familiari: di che altro si parla, a partire dai poemi epici? Cos’altro si è narrato nei secoli, se non la commedia umana nelle sue sfaccettature? La raccolta di Elena Rui, attraverso il tema più antico e scandagliato di sempre, indaga con eleganza e consapevolezza aspetti svariati dell’Occidente contemporaneo: la precarietà diffusa; la scelta di vivere in un Paese diverso da quello di origine e di adattarsi alle differenze culturali (Presagi, in cui una giovane musulmana emigrata in Francia si trova costretta a scegliere fra la lealtà verso il marito e il proprio lavoro); l’innamoramento ai tempi dei social (Audiofilia). Un libro che piacerà agli appassionati del narrare breve ma che anche i lettori che prediligono il romanzo (o addirittura il romanzone) potrebbero apprezzare.
Rosalia Messina
Il link alla recensione su 84 Charing Cross: https://tinyurl.com/mr4yahyr