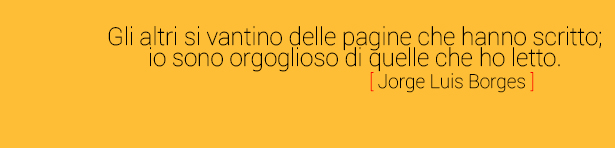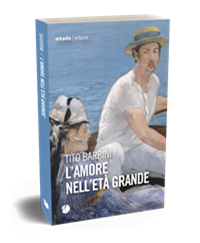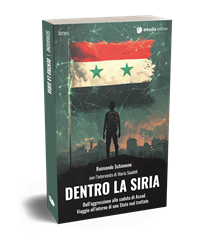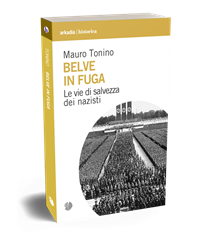Senza rotta
SCUDELETTI MASSIMILIANO
LA LAGUNA DEI SOGNI SBAGLIATI
Una terra malata genera mostri, questo è il messaggio di fondo del libro, e se vogliamo restare su suolo italiano, pochi luoghi possono essere considerati malati come Porto Marghera e il suo famigerato polo petrolchimico. E infatti, proprio qui è ambientata la storia: siamo negli anni ’90, il protagonista è Alessandro Onofri, 12enne che ha di recente perso i genitori è che quindi stato affidato alla zia: un’anziana signora aristocratica che vive in un palazzo a Venezia e che sembra aver avuto una vita abbastanza avventurosa anche se non ne sappiamo moltissimo. Oltre a tutto ciò, la zia è una grande appassionata di esoterismo e possiede una notevole collezione di libri sull’argomento. Alessandro di per sè è un dodicenne abbastanza normale, vive i primi amori, cerca di farsi nuovi amici, ma la perdita dei genitori lo porta a cercare risposte nell’esoterismo di cui la zia sembra così esperta ed è forse questo il “sogno sbagliato” del libro: la speranza in un modo o nell’altro di poter rivedere i suoi genitori tramite qualche pratica magica. I personaggi si muovono appunto per Marghera e i suoi dintorni: sede del famigerato polo petrolchimico che per generazioni ha sì dato lavoro a migliaia di persone, ma ad un prezzo spaventoso. Molti sono i riferimenti alle fiammate di emergenza delle ciminiere, agli incidenti, ai terribili effetti sulla salute dei lavoratori e sulle loro famiglie. La vita di Alessandro comincia a complicarsi quando a scuola arriva una nuova supplemente di matematica che terrorizza la classe in modo crudele e apparentemente privo di scopi didattici. La stessa supplemente comincia poi a cercare di carpire l’interesse di Alessandro verso quello che sembra una sorta di rito iniziatico dentro una setta oscura. Non per coincidenza, l’arrivo della supplente segnerà l’inizio di una serie di brutali violenze perpetrate nella zona. Alessandro dovrà contate sull’aiuto dei suoi amici, di un improbabile maestro di arti marziali, e soprattutto della zia, per poter uscire da questo circolo di oscurità e salvare la sua anima. L’autore, Massimiliano Scudeletti, natio di Firenze, fa un ottimo lavoro nella descrizione dei luoghi, e questo giudizio viene da uno che è nato e cresciuto a Mestre durante gli anni ’90. Particolarmente significativo è questo passaggio proprio su Mestre:” La laguna di Mestre. La città che non esiste, annichilita da una parte dall’ombra estetica di Venezia, dall’altra dal Moloch del petrolchimico.” Molto azzeccato anche il commento sui tramonti, fenomeno effettivamente osservabile:” Che il male avesse una sua bellezza Alessandro l’aveva imparato proprio stando alla finestra, perché una sola cosa bella Marghera aveva dato a Venezia: tramonti splendidi e venefici come pesci tropicali fluttuanti sulla laguna, come aurore boreali contaminate Ma sempre Salvatore, delegato sindacale che quelle cose le sapeva, gli aveva spiegato che più il cielo era bello, più accesi i rossi e i viola e gli arancioni, più carica di veleno era l’aria. La narrazione in alcuni capitoli è interrotta e ci porta avanti nel tempo, dove troviamo un Alessandro ormai cresciuto e che lavora come reporter di guerra in quella che sembra l’Ucraina al giorno d’oggi. Interessante notare infatti che il personaggio viene ripreso da un altro libro dello stesso autore, “Little China Girl” e da altri svariati racconti. Questi intermezzi sono forse più utili a creare un legame con le altre opere dello stesso autore più che a proseguire nella narrazione. In generale, un libro piacevole, dalle note oscure e a tratti anche cruento, ma dietro al quale si vede un grande lavoro di ricerca e di studio della materia. Lo consiglio a tutti gli appassionati di esoterismo e a tutti gli abitanti della zona Venezia, Mestre, Marghera.
Francesco Ricapito
Il link alla recensione su Lankenauta: https://bit.ly/44aL73l
La laguna dei sogni sbagliati, una storia dell’occulto a Marghera
Da Massimiliano Scudeletti un viaggio della memoria
(ANSA) – ROMA, 28 APR – (MASSIMILIANO SCUDELETTI, LA LAGUNA DEI SOGNI SBAGLIATI, Arkadia, pp.216, 17 euro) – Venezia, anzi, Marghera, anni Novanta
Alessandro Onofri ha dodici anni e, dalla morte dei suoi genitori, vive con una vecchia zia eccentrica, amante dell’esoterismo (si definisce una “vecchia diavolessa”), che lo cura e lo adora. È un’esistenza quasi normale la sua, tra nuovi amici e primi amori, ma il trauma subito lo porta a confondere fantasia e realtà, a rincorrere il sogno di evocare i fantasmi dei suoi genitori, per il quale farebbe di tutto. La zia gli ha insegnato che una terra malata genera mostri e forse questo spiega il fiorire di sette sataniche, gli atti di violenza e i delitti rituali che travolgono la città e la sua provincia. Intanto, mentre l’inquinamento del polo petrolchimico di Porto Marghera e le cupe vampe della guerra nella vicina Jugoslavia segnano il suo tempo, il mondo di Alessandro è scosso ancor di più dall’arrivo di una nuova insegnante che terrorizza i suoi alunni. È solo malvagia o nasconde qualcosa di più segreto, mentre cerca di attirarlo a sé facendo leva sui suoi desideri più oscuri? Perché cerca di indirizzarlo in un percorso iniziatico che unisce Crowley, LaVey e altri maestri dell’occulto a un pittore russo della metà del secolo scorso, tanto misterioso quanto delirante? Solo gli amici, un improbabile maestro di arti cinesi e la presenza della zia e della sua congrega potranno lottare per la sua anima e salvarlo dalle sue peggiori paure. Il libro si apre e si chiude con due momenti di Alessandro Onofri adulto – che è già protagonista di romanzi precedenti dell’autore – sul fronte ucraino, in cui annuncia e conclude la vicenda della sua infanzia che sta raccontando a una sua collega reporter.
Massimiliano Scudeletti è nato e vive a Firenze. Dopo gli studi si dedica alla realizzazione di documentari e spot televisivi prima come sceneggiatore, poi come regista. Nel passaggio tra analogico e digitale abbandona l’attività per collaborare con un’agenzia assicurativa che opera prevalentemente nella comunità cinese. Continua a viaggiare nel Sudest asiatico per passione. Compiuti i cinquant’anni, decide di dedicarsi completamente alla cultura tradizionale cinese e alla scolarizzazione di adulti immigrati. A febbraio 2018 pubblica il suo primo romanzo, un giallo con protagonista il videoreporter di guerra Alessandro Onofri, Little China Girl (Betti Editrice), giunto secondo al premio “Tramate con noi” di Rai Radio1, vincitore del premio Emotion al “Premio Internazionale Città di Cattolica”. Dopo numerosi racconti, alcuni con protagonista lo stesso Onofri, a luglio 2019 pubblica il suo secondo romanzo, L’ultimo rais di Favignana. Aiace alla spiaggia (Bonfirraro Editore). (ANSA).
Il link alla recensione sull’ANSA: https://bit.ly/3LWiGhl
“LA MENTALITÀ DELLA SARDINA”: CROSIO SULLA VIA FRANCIGENA PER RITROVARE SE STESSA
C’è sempre un momento di rinascita e di riscoperta nella vita di ciascuno, magari lontano dal frastuono e dalla frenesìa in cui siamo immersi: lo possono confermare le migliaia di pellegrini che ogni anno scelgono la Via Francigena, lo storico cammino che conduce a Roma, per vivere un tempo altro, per condividere la mensa con sconosciuti attirati dallo stesso obiettivo, per assaporare un’esistenza più lenta e più riflessiva. Tra di loro in passato c’è stata anche Olivia Crosio, traduttrice e scrittrice con diverse opere di successo alle spalle, che ha deciso di racchiudere in un romanzo autobiografia e finzione portando alla luce, con un’ironia di sottofondo talvolta spiccata e corrosiva, i tratti sostanziali di quanti scelgono di intraprendere questo viaggio. “La mentalità della sardina”, apparso nella Collana “Senza Rotta” di Arkadia Editore (244 pagg., 17 euro), è un divertente caleidoscopio di volti, voci, sentimenti, sogni e immagini di personaggi che, insieme alla protagonista (un’ex libraria ultrasessantenne appassionata di yoga il cui matrimonio si è ormai cristallizzato nella noia) si incrociano sulla Via Francigena conoscendosi e arrivando, in qualche misura, a una sorta di accomodamento tra caratteri spesso inconciliabili. Se Corrado Guerrazzi, in una silloge apparsa qualche tempo fa per Nem Editore aveva dato forma in poesia al proprio personale, spirituale pellegrinaggio, Crosio segue invece un altro modello, più sbarazzino, ma non meno penetrante ed efficace. Il bisogno di astrazione da una quotidianità vieppiù ingombrante trova uno sfogo nel recupero di un rapporto con la natura e con l’altro da noi: insieme all’autrice passiamo in rassegna borghi e città che da Camaiore, luogo di partenza, si affacciano sul cammino sino alla capitale. Di fronte alla paralisi delle emozioni è d’uopo, ci insegna la protagonista, lasciarsi andare, camminare magari separati per giungere insieme allo stesso punto di arrivo, dare una svolta alla routine mefitica e perniciosa anche rischiando: solo così, e lo sapremo al termine del volume, il cerchio si chiude e quella vita ordinaria e tranquilla lasciataci alle spalle riuscirà a riprendere, con maggiore vigore ed entusiasmo, il suo percorso. “La mentalità della sardina”, titolo che richiama un antico gioco d’infanzia del personaggio principale, è un invito a lanciare il cuore oltre l’ostacolo, a cogliere l’attimo, a impedire che gli eventi finiscano per sopraffarci o ancora, per dirla con Rita Levi Montalcini, a riempire maggiormente di vita i giorni anziché il contrario e mantenendo sempre vivi curiosità, interesse, speranza. È proprio quest’ultima che non manca in questo romanzo che non fa solo cenno a un microuniverso fluido, ma conchiude vicende e situazioni condivise ben sapendo che non tutto è mai perduto per sempre. “Una delle avventure più belle della mia vita” scrive Crosio nei ringraziamenti: dal 950, quando Sigerico di Canterbury nel suo diario di ritorno da Roma annotò le 80 tappe di questo percorso, ancora oggi la Via Francigena sèguita ad affascinare viandanti di ogni dove, pronti a reinventarsi e reimparare ad esistere risolvendo anche i propri dubbi interiori.
Federico Migliorati
Il link alla recensione su il Gazzettino nuovo: https://bit.ly/3KwV0iE
Recensione del libro “Luoghi Letterari Sardegna” a cura di Giulio Pisano
Un interesse rinnovato per i piccoli borghi, fuori dagli itinerari turistici tradizionali, attraverso gli occhi di sette grandi scrittori capaci di ammaliare con le loro opere milioni di lettori. Ognuno, con lo stile che lo contraddistingue, racconta il paese in cui ha soggiornato, per dare al lettore la sua interpretazione del vissuto attraverso l’arte della scrittura. Nel solco tracciato dalla grande letteratura di viaggio, uno spaccato della Sardegna da un punto di vista totalmente nuovo che farà viaggiare con la mente in luoghi misteriosi e poco conosciuti. In questo volume Carlo A. Martigli, Valeria Gargiullo, Giulia Ciarapica, Michela Tanfoglio, Paolo Roversi, Bea Buozzi e Diego Galdino raccontano Villacidro, Desulo, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Ovodda e Dolianova.
Introduzione
“Luoghi Letterari Sardegna” è una raccolta di racconti nata da un progetto che, sin da subito, mi ha entusiasmata. Sette autori continentali hanno vissuto per una settimana in diversi paesi dell’entroterra sardo: Villacidro, Desulo, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Ovodda e Dolianova. Dalla loro permanenza e dagli incontri con gli abitanti di questi paesi lontani dalle spiagge, tipiche mete turistiche, sono nati dei racconti nei quali assaporiamo tutta la magia della Sardegna.
Aneddoti personali
Chi di voi mi conosce e mi segue da un po’, sa che sono una fan di Diego Galdino. Quindi quando, nel 2022, ho saputo che avrebbe partecipato al progetto “Luoghi Letterari Sardegna” a cura di Giulio Pisano (editor e agente letterario che ho avuto modo di conoscere grazie all’Accademia d’Arte di Cagliari) ho seguito tutte le novità inerenti questo progetto (oltre ad aver incontrato Diego a Dolianova, il paese sardo che l’ha ospitato) fino alla lettura del libro.
Recensione
I racconti che si susseguono in questa raccolta, ci fanno immergere completamente nella cultura, nelle tradizioni, nella storia e nell’accoglienza sarda. Devo ammettere che, da sarda, sono rimasta colpita dall’amore che, attraverso le loro penne (o le loro tastiere), questi autori e autrici hanno dimostrato nei confronti della terra che li ha ospitati, facendoli sentire parte del tutto. La raccolta inizia con “Nel sogno di una cascata” di Bea Buozzi che, essendo ospite di Villacidro, non poteva non inserire nel suo racconto Jane Austen. Nel paese, infatti, c’è il bookclub dedicato all’autrice inglese. La Buozzi la fa vivere ai tempi nostri, grazie alla famosa cascata de Sa Spendula. Un racconto divertente e che, fino all’ultimo, fa sognare. A seguire troviamo “Te, la mia inquietudine” scritto da Giulia Ciarapica durante il suo soggiorno a San Giovanni Suergiu, in cui il culto delle anime dei morti (molto forte nell’entroterra sardo) fa da protagonista. In “Convinzione” di Diego Galdino, ci immergiamo tra le strade di Dolianova e tra i suoi singolari personaggi, frequentatori del bar in cui lavora il protagonista. Come sempre Galdino ci fa assaporare i luoghi che descrive, catapultandoci lì. In “Torneremo ancora” di Valeria Gargiullo, la narrazione viene da un punto di vista insolito: quello di un gatto. Dopo aver perso la madre sulla spiaggia di Porto Pino, l’animale vaga fino ad arrivare a Ovodda, paese in cui non solo trova una famiglia umana pronta ad accoglierlo, ma ottiene tante risposte sulla sua vita e su quella degli uomini che lo circondano. In “Il dono di Desulo” Carlo A. Martigli, ci presenta uno scritto a metà tra il racconto e il saggio. Attraverso gli aneddoti degli abitanti del paese che l’ha ospitato e i suoi studi, l’autore ci mostra Desulo e la Sardegna in tutta la loro bellezza storica e archeologica. “Il giocatore” di Paolo Roversi è ambientato, come il primo racconto, a Villacidro dove l’autore ha soggiornato, regalandoci pagine dalle tinte noir con un finale sorprendente. Infine la raccolta si conclude con il racconto di Michela Tanfoglio dal titolo “Toso, hai visto Diana?”, storia di un bambino che, crescendo fino all’età adulta, si trova ad affrontare il lutto di aver perso la madre. Ma a lei e alle sue origini sarde rimarrà sempre legato, tanto da tornare a Sant’Anna Arresi. La storia è giocata sull’anagramma che la rende singolare e ricca di suspence.
Conclusioni
Sette viaggi con sette autori e autrici, che ci portano nell’entroterra sardo, tra nuraghi, tradizioni e ospitalità. Un libro da leggere per assaporare la magia della Sardegna, che non è solo quella delle spiagge e delle mete turistiche.
Il link alla recensione su My Bookcrossing Life: https://bit.ly/3GiRM0W
Massimiliano Scudeletti – La laguna dei sogni sbagliati
Il videoreporter di guerra Alessandro Onofri, che abbiamo potuto conoscere nei primi due romanzi (e in diversi racconti) di Massimiliano Scudeletti, sta cercando di dare conforto a una collega giornalista, gravemente ferita da un colpo di mortaio. Per distrarla dal dolore, durante il viaggio frenetico verso il più vicino posto di soccorso, le racconta la storia della propria preadolescenza vissuta a Venezia, da dove viene la giornalista stessa.
Rimasto orfano, il dodicenne Alessandro si trasferisce a Venezia da Firenze, dove è nato e cresciuto fino a quel momento, per vivere presso un’anziana zia, l’unica parente che ha. Ben presto, però, a causa dell’età avanzata della donna, il ragazzino viene dato in affidamento alla famiglia Caputo. Bravissima gente, ma soprattutto vicini di casa della famiglia dell’affascinante Maria Luisa, di due anni più grande di lui.
Il giovanissimo Alessandro si trova quindi a vivere la tragedia degli operai di Porto Marghera, vista da lui attraverso l’esperienza dell’affidatario Salvatore e del padre di Maria Luisa; allo stesso tempo, entra in contatto con la guerra nell’ex-Yugoslavia tramite l’amicizia con Ivan, un suo coetaneo profugo. A scuola, poi, ha esperienza della crudeltà di una supplente di matematica, attraente ma sadica, che si sospetta abbia a che fare con la magia nera; e proprio di magia, nera e bianca, si intende l’anziana zia di Alessandro. Una premessa complessa per un romanzo non lunghissimo ma dalla trama certamente non lineare; del resto, ci viene presentato come la memoria di un adulto che ricorda il proprio periodo preadolescenziale, e si sa come la memoria, oltre a non essere sempre al cento per cento affidabile, a volte si perde seguendo associazioni di idee improbabili. Ma gli eventi si possono seguire senza grandi sforzi di memoria, dato come l’autore riesce a rendere i fatti da lui inseriti in questo romanzo davvero “forti” e incisivi.
Si tratta di un romanzo che colpisce, con tanta ma non troppa carne al fuoco; vengono messe in campo innumerevoli sottotrame, ma ognuna di esse si risolve, ogni elemento messo sulla pagina dal bravo Scudeletti trova un suo posto prima della fine del libro.
La scrittura dell’autore è fluida, interessante, accattivante. “La laguna dei sogni sbagliati” si legge in fretta, non perché sia una “gomma da masticare per la mente” (così definisco i libri che mi divertono, anche molto, ma che non mi lasciano nulla di speciale) ma perché la nostra attenzione viene catturata a metà della prima riga (“Alessandro Onofri era appoggiato a ciò che rimaneva degli uffici amministrativi dell’acciaieria”) e non viene rilasciata prima dell’ultima parola (che, se a qualcuno interessa, è “così”). Massimiliano Scudeletti ci regala, alla fine del libro, anche il link a una playlist su Spotify che ha personalmente selezionato per accompagnare la lettura di questo suo romanzo; consiglio vivamente di ascoltarla, mentre si legge o dopo (io lo sto facendo ora, scrivendo questa recensione), anche se, come nel mio caso, non si tratta esattamente del genere musicale preferito: suggerisce perfettamente l’atmosfera del romanzo. Una bella idea, davvero. Personalmente, mi permetto di aggiungere ai consigli musicali dell’autore anche l’ascolto di “The Venetian Book of the Dead” di Alessandro Monti/Unfolk.
Consiglio di leggere questo romanzo? Sicuramente sì. Come penso di avere suggerito in questo articolo, non si tratta certo di una lettura leggera; ma è una lettura che colpisce, una storia scritta per rimanere.
Marco A. Piva
Il link alla recensione su Contorni di Noir: https://bit.ly/3U4quB0
La mentalità della sardina
Diciamo la verità: a chi non è successo, a un certo punto della sua esistenza, di sentirsi vuoto, insignificante, privo di scopi? E a chi non è successo di veder appassire il proprio rapporto di coppia e di accorgersi di non avere più nulla in comune col partner di una vita? È quello che capita ad Angela, una simpatica signora di una certa età, ora che i figli non vivono più a casa e lei e suo marito Severino, entrambi in pensione, non sembrano aver più nulla da dirsi. L’uomo, si sa, quando smette di lavorare rischia di fossilizzarsi sul divano, davanti alla televisione, o di diventare ossessivo su certe questioni marginali, dalle previsioni del tempo al menu di pranzo e cena. Ad Angela dunque non resta altro che cucinare per il marito, e questa vita senza scopo e senza stimoli le va stretta. Combinazione vuole che la sua casa, a Camaiore, sorga lungo un tratto della via Francigena: ogni mattina vede passare sotto le sue finestre pellegrini affaticati con grandi zaini sulle spalle e pian piano un’ idea si fa strada nella sua mente. Comincia come se nulla fosse, con l’acquisto di una maglietta di materiale tecnico, cui seguono altri capi di vestiario, borraccia, torcia e altri gadget, fino a quando, un bel giorno, si mette lo zaino in spalla e infila l’uscio di casa, senza dir nulla a nessuno. Comincia così il divertente, lieve ma al tempo stesso profondo, romanzo di Olivia Crosio, La mentalità della sardina (Arkadia, 2022): chilometro dopo chilometro, Angela finirà per arrivare a Roma, conoscendo persone, condividendo esperienze, arrivando a conclusioni e decisioni importanti per la sua vita.
Marisa Salabelle
Il link alla recensione sul blog di Marisa Salabelle: https://bit.ly/3zgEgXW
‘Giovani ci siamo amati senza saperlo’, un romanzo di Emanuele Pettener
Emanuele Pettener è professore di Lingua e Letteratura Italiana alla Florida Atlantic University e vive negli Stati Uniti dal 2000. Nonostante faccia parte dei tanti intellettuali che hanno lasciato il Belpaese in cerca di opportunità migliori e giusti riconoscimenti non ottenuti in patria, Pettener non smette di rivolgere uno sguardo sempre affettuoso e nostalgico all’Italia. In qualche occasione ha confessato di sentirsi italiano in America e americano in Italia. Giovani ci siamo amati senza saperlo è il suo quinto romanzo, un elogio sensoriale alle passioni giovanili nella Venezia degli anni ‘90.
*****
Giovani ci siamo amati senza saperlo, Emanuele Pettener
(Arkadia 2022, p. 118, circa 14€)
*****
Venezia
Venezia. Qualcuno ebbe a scrivere: non sai mai se sia una città o un sogno. Per capire meglio questa sensazione devi aver passeggiato per le calli più ascose, sostato su una panchina solitaria in un campiello non battuto dai forestieri, devi esserti affacciato sui canali a respirare l’odore notturno della laguna dopo aver attraversato ponti da cartolina nella sera umida, quando a volte all’improvviso una nebbia finissima cala inseguendo un tramonto di fuoco e le poche creature autentiche, rimaste in giro dopo la dipartita dell’ultima orda giornaliera di turisti, si trasformano in ombre eteree e sommesse che incrociano a stento il tuo cammino. Anzi, a volte spariscono anche quelle, e allora Venezia diventa una fuga assoluta dal tempo e si trasforma in un deserto di “pura bellezza senza la parvenza di un umano, di un piccione, di uno squittio. Sembra sia sorto in quel momento per te, magicamente, e magicamente sparirà una volta che l’avrai attraversato, con i suoi archi di pietra bianca, con le sue imposte verde bottiglia.”
Questa è la preziosa atmosfera che si respira nell’ultimo romanzo di Emanuele Pettener, Giovani ci siamo amati senza saperlo (Arkadia, 2022), nel quale non c’è posto per una Venezia decadente, morta e spacciata, come la dipingono Thomas Mann o Charles Aznavour, ma una Venezia avvolta da una più frizzante malinconia autunnale, bella e misteriosa, sacrale e poetica, come quella cantata da D’Annunzio ne Il fuoco. Non importa che il capolavoro dannunziano sia stato dato alle stampe allo scoccare del 1900 mentre la storia di Pettener si svolge novant’anni dopo: la passione che infiamma i protagonisti arde con lo stesso vigore; la magnificenza di Venezia è immutata, come incastonata tra i granuli di un pezzo di giada che dà il colore ai suoi canali.
Il tempo
“Settembre era il vero inizio, altro che quel poveraccio di gennaio, ai propositi di gennaio non ci credeva nessuno, era a settembre che iniziava la stagione, il nuovo anno, quello che lanciava garanzie di successi e promesse di trionfi”. La storia ha dunque inizio con le prime folate di vento che annunciano l’autunno. Non potrebbe essere altrimenti: non solo abbiamo ricordato che la bellezza di Venezia è più struggente e invincibile in questa stagione, ma, trattandosi di una storia che ha per protagonisti alcuni studenti universitari, settembre è soprattutto il mese del preludio alle lezioni e all’inaugurazione del nuovo anno accademico. Il calendario che si resetta dopo la lunga pausa estiva è quello che portano nel cuore tutti gli studenti di questo mondo (almeno nel nostro emisfero boreale), che li fa palpitare al pensiero di nuovi incontri serbati dal destino insieme al pensiero di vecchie e nuove aspettative, che spesso si rivelano troppo complicate quando si tenta di mettere d’accordo gli obiettivi personali e quelli della famiglia. Ma il nuovo anno accademico è anche nel cuore, se non addirittura nell’organismo e fino all’ultima fibra, di ogni docente universitario, proprio come l’autore Emanuele Pettener, che insegna in un college americano e che deve conoscere bene quella tensione euforica che emana da tanti giovani assembrati tra i banchi della platea: bastano i loro vent’anni per elettrizzare l’aula che condividono di giorno e gli appartamenti e i locali che frequentano dopo le lezioni. Questa magica ciclicità si innesta con prepotenza nel racconto di Pettener, come un “temporale [che] s’avventa furioso sulla città, sulle crepe d’agosto, lavando via polvere e vecchi desideri” per fare spazio a un nuovo anno, a desideri novelli.
I desideri
Già, i desideri. Ma quali desideri? Di certo quelli plastici, malleabili e irruenti che muovono i tre giovanissimi adulti protagonisti di questo romanzo, ragazzi spesso un tantino impacciati a causa dell’inesperienza ma bramosi di sperimentare fino a bruciarsi, fino a spingersi a un passo oltre la misura del sostenibile. I tre ragazzi si chiamano Ema, Rodrigo e Feli. I primi due sono due coinquilini appena conosciutisi: Ema è il fortunato proprietario di un appartamento ereditato dalla nonna, il padrone di casa che svolge la funzione di narratore autodiegetico, e Rodrigo il suo coinquilino di adonia bellezza. Quest’ultimo si lega a una ragazza il cui fascino è obnubilato da una patina di tristezza, ma quando l’esuberante Ema, che ne diventa inevitabilmente amico, riesce a squarciare la coltre che avvolge Feli e posa finalmente lo sguardo sulla genuina bellezza dell’animo di lei, ecco che l’equilibrio fra i tre sodali ne risulta alterato. Ema infatti sente l’amicizia con Rodrigo, mentre nutre verso Feli un’attrazione peculiare non solo fisica ma anche immateriale, o “rapita fuor de’ sensi”, per dirla con D’Annunzio.
Il turbine dei sentimenti che avvolge il terzetto si trasforma presto in un vortice emozionale di non facile interpretazione, in dionisismo separato dalla corporeità, in goffo tentativo di coniugare l’eccitazione per l’ignoto con il timore per la sperimentazione. Sui piatti della bilancia ci sono, da un lato, l’amicizia che non si vuole incrinare e, dall’altro, il desiderio al quale ci si oppone a fatica. Regna così la confusione dolce dell’inesperienza giovanile unita alla sua leggerissima inconsapevolezza, ingredienti che non a caso ritroviamo nello stesso titolo del romanzo, tratto da un verso di William Butler Yeats: young / We loved each other and were ignorant (letteralmente: “giovani ci amammo reciprocamente ed eravamo ignoranti”). Nella traduzione di Montale, certamente più raffinata, l’ignoranza è resa proprio come mancanza di consapevolezza: giovani / ci siamo amati senza saperne nulla. Questa è invero la chiave del romanzo di Pettener, che elargisce al lettore ampie pennellate di slanci, impeti e frenesie ancora scontornate nella loro ingenuità.
All’affiatato trio si aggiunge per qualche frangente Barbara, ragazza di giunonica avvenenza, dai conflitti interiori molto ordinari e dalle aspirazioni un po’ dozzinali. La sua presenza è necessaria per ricordarci che la natura della relazione che lega Ema, Feli e Rodrigo appartiene a un altro ordine esistenziale, quasi metafisico, che malvolentieri riesce a mescolarsi con le lagne di una mediocre quotidianità.
I nomi
La sorte di ciascun protagonista è segnata dal proprio nome. Barbara, come ci rivela il narratore ispirandosi apertamente al vezzo dannunziano di affibbiare nomignoli alle amanti, è “interessante” in quanto foriero di calde, superbe e selvagge passioni che, però, non sembrano oltrepassare l’ambito della fisicità. Poi c’è Rodrigo, il quale in un paio di occasioni non sa dissimulare una competitività troppo accesa e la voglia di prevaricare sugli altri: fin troppo facile, qui, il richiamo al don Rodrigo di manzoniana memoria, privo di scrupoli e capace di mettersi di mezzo tra due amanti – se non per puro capriccio, almeno per frustrazione – ma ancora più calzante il riferimento al gentiluomo veneziano Roderigo, partorito dalla penna di Shakespeare. Roderigo ama Desdemona ma è deluso perché Desdemona è innamorata di Otello. Il rimando alla celeberrima tragedia shakespeariana, caratterizzata da gelosie e amanti che si rincorrono, ha certamente una relazione con il romanzo di Pettener.
Poi ancora c’è Ema, ovvio diminutivo di Emanuele, narratore che gioca a confondersi con l’autore empirico del romanzo, con il quale dunque condivide il nome di battesimo ma anche altre caratteristiche demografiche, tra cui la città di provenienza (Mestre) e la passione per lingue straniere e letteratura. Ema non è solo un tentativo di indurre il lettore ad accarezzare l’idea che possa trattarsi di autofiction, ma soprattutto il manifesto di un destino di Passione: αἷμα in greco vuol dire “sangue”.
E infine incontriamo Feli – al contrario di Ema, più soprannome che diminutivo. Feli sta per Felicita, ribattezzata tale da un amico appassionato di poesia (l’allusione a Gozzano è adamantina). La sua felicità dura fino al diciannovesimo anno, poi qualcosa si rompe. La vita va in frantumi, specie per gli affanni che riguardano la sfera familiare, e questo è qualcosa che accomuna Feli a Rodrigo. Il romanzo sembra suggerire che il compimento dei vent’anni segna uno spartiacque nella vita di una persona, si abbandona la spensieratezza e la serenità, si annuvola l’orizzonte. La citazione di un celebre incipit di Paul Nizan non lascia spazio alla brutalità di certe conclusioni: “Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita”. A questa età, infatti, si fa esperienza di separazioni e dolori. Feli diventa l’ossimoro della sua stessa condizione, l’infelice Feli, felice nel nome ma ferita nell’animo, e ancor più ferita per il dolore dei propri cari: “gli occhi le si riempirono di lacrime. Sopportare il proprio dolore era un conto, ma sopportare il dolore delle persone che più amava? Sul primo poteva avere qualche controllo, ma sul secondo si sentiva totalmente impotente”.
Feli si trasforma dunque in in-Feli-ce. È una metamorfosi che però la rende attraente, irresistibile, fuggevole, ed è così che il lettore la incontra nelle prime pagine, alla sua entrata in scena nel romanzo – già bella e trasformata. Ema, che oltre ad essere un ragazzo dal temperamento sanguigno possiede anche un fervido umorismo, durante una conversazione si prodiga in un buffo gioco di associazioni bislacche tra nomi propri e le presunte tendenze caratteriali. Poi, dopo una lunga disamina (comica) di Roberti omosessuali, Pietri testardi, Paoli dal naso grosso, Caterine stitiche, Laure bionde e Lise gattemorte, arriva il turno di Feli. Stanno fumando una sigaretta, un po’ appartati, una delle prime volte in cui si trovano da soli, ed Ema prova a sollevarla dalla cronica malinconia con le sue battute da spaccone, mormorando mezze verità tra le righe, parole fuggevoli che, se còlte, rivelano un incipiente amore mascherato tra tante allusioni salaci.
«Oh, le Feli – le Feli indossano calzettoni fucsia, purtroppo, ma ti fanno impazzire, sono miracoli di malizia e oscenità, d’altro canto Feli a cosa può condurre? Feli, Feli, oh Feli – fellatio.» E le guardai la bocca, spudoratamente.
«Sei un porco», sussurrò da quelle labbra, muovendole
appena, procurandomi una scossa al basso ventre.
«Certo.»
Le maschere
L’umorismo di Ema è uno stratagemma per affrontare le difficoltà, per reagire al dolore, anche al dolore altrui di cui è testimone; il motto di spirito è un modo per sdrammatizzare quel dolore, attenuandolo, mascherandolo, proprio come le facce di cartapesta carnascialesche che schermano le vite grame e grigiastre di coloro i quali prendono parte ai festeggiamenti e fingono di divertirsi.
La bravura dell’autore consiste proprio nell’alternare momenti di alto lirismo a battute sferzanti. Essere privi di umorismo è quasi una colpa; avere la battuta pronta, un pregio. Rodrigo, per esempio, è privo di umorismo e probabilmente è questa mancanza a fargli imboccare un vicolo cieco dal quale drammaticamente non potrà più tornare indietro: l’assenza di umorismo, ovvero l’incapacità di reagire con ironia alle inevitabili aggressioni della vita, gli farà perdere quel tocco di umanità che separa il dramma dalla risata, la farsa dalla tragedia, la ragionevolezza dall’irrazionalità.
L’umorismo si presenta dunque come antidoto per non lasciarsi sopraffare dal dolore o per affrontare ciò che è spiacevole tenendo vivo il barlume di un (a volte ingiustificato) ottimismo. La risata è essa stessa una maschera, un abbozzo di pianto trattenuto; pur tuttavia è innegabile la presenza di note positive disseminate nel testo. Abbiamo già detto dell’amore per Venezia che trasuda da ogni descrizione, come quando si accenna alla “luna […] che si bagna[…] nei canali […] intessendoli di trame d’argento”. Persino quando si parla di cattivi odori, Pettener usa termini più aulici come “afrore”, che fa pensare a un vino acerbo di Dioniso e suona bello come il nome di Afrodite, la “dea nuda e capricciosa” che si bagna nei canali, e i canali emanano odore di cetriolo e pesce arrosto piuttosto che fetore di alghe in putrefazione.
Lo stesso atteggiamento benigno si estende, infine, a un altro ambito dell’universo narrativo contenuto nel romanzo e tocca l’essenza della famiglia o, più precisamente, la preoccupazione nei riguardi dei familiari. C’è in questo affanno una componente tipica della gioventù (a conferma del titolo) che, non ancora slegata dai lacci della figliolanza, idealizza la genitorialità e ripone in essa ogni sforzo per comporre la minima incrinatura che intacca gli affetti familiari: Barbara è ben lieta dei legami tra i suoi e i consuoceri più che del legame che lei stessa trascina da tempo col proprio fidanzato storico; Feli è affranta dall’allontanamento del padre, ma principalmente dal dolore che la separazione ha causato alla madre e al fratellino; Rodrigo, senza padre, è alle prese con una madre gravemente ammalata; Ema è affranto per la brusca recisione che lo ha inaspettatamente e irreversibilmente allontanato dai suoi cari e condannato in eterno a un utopico quanto “lacerante […] desiderio di accudirli, accarezzarli, stringerli”.
E così, sotto un cielo cangiante, che nella stagione narrata sovrasta Venezia di bianco, grigio, nero, blu, blu di Persia e cobalto, si celebra il dramma dell’Eterna Giovinezza, la quale appare dorata solo a chi la osserva dall’esterno con un occhio nostalgico, mentre essa invece brucia, e a volte consuma tragicamente chi la vive dentro con una tale profondità al punto da lasciarsi avviluppare dalle sue vorticose fiamme.
Giuseppe Raudino
Il link alla recensione su Altritaliani: https://bit.ly/3TPOeZJ
Massimiliano Scudeletti : LA LAGUNA DEI SOGNI SBAGLIATI. Arkadia editore
Cosa avrebbe scritto Stephen King se, anziché essere nato a Portland nel Maine, fosse nato a Marghera?
Un romanzo che unisce IT e In viaggio con la zia all’esoterismo de Il pendolo di Foucault.
Una storia in cui occultismo, paure e strani personaggi si mescolano in una Laguna di Venezia mai così lontana dalla sua immagine da cartolina.
Venezia, anni Novanta. Alessandro Onofri ha dodici anni e, dalla morte dei suoi genitori, vive con una vecchia zia eccentrica, amante dell’esoterismo, che lo adora. È un’esistenza quasi normale la sua, tra nuovi amici e primi amori, ma il trauma subito lo porta a confondere fantasia e realtà, a rincorrere il sogno di evocare i fantasmi dei suoi genitori. Per esaudire questo desiderio farebbe qualsiasi cosa.
La zia gli ha insegnato che una terra malata genera mostri e forse questo spiega il fiorire di sette sataniche, gli atti di violenza e i delitti rituali che travolgono la città e la sua provincia.
Intanto, mentre l’inquinamento del polo petrolchimico di Porto Marghera e le cupe vampe della guerra nella vicina Iugoslavia segnano la fine di un secolo e di un millennio, il mondo di Alessandro è scosso ancora di più dall’arrivo di una nuova insegnante che terrorizza i suoi alunni. È solo malvagia o nasconde qualcosa di più segreto, mentre cerca di attirarlo a sé facendo leva sui suoi desideri più oscuri? Perché cerca di indirizzarlo in un percorso iniziatico che unisce Crowley, LaVey e altri maestri dell’occulto a un pittore russo della metà del secolo scorso, tanto misterioso quanto delirante? Solo gli amici, un improbabile maestro di arti tradizionali cinesi e la presenza formidabile della zia e della sua congrega potranno lottare per la sua anima e salvarlo dalle sue peggiori paure.
Il link alla segnalazione su Ambienteeuropa.info: https://bit.ly/3KgE2pH
Massimiliano Scudeletti e il nuovo libro La Laguna dei sogni sbagliati: “Un Tributo alle persone che ho amato e perse”
Massimiliano Scudeletti è originario di Firenze e, nel corso degli anni, si è dedicato alla realizzazione di documentari e spot televisivi. Ha viaggiato molto nel Sud-Est asiatico e, dopo i cinquant’anni, ha approfondito lo studio della cultura tradizionale cinese e della scolarizzazione di adulti immigrati. Il suo primo romanzo nasce nel 2018 e rappresenta il punto di svolta per il suo percorso letterario. L’autore è adesso tornato sugli scaffali delle librerie nazionali con il romanzo La Laguna dei sogni sbagliati (Arkadia Editore): una storia, questa, che si basa sulle vicende dell’ormai conosciuto Alessandro Onofri, un ragazzino che è alla continua ricerca di verità e scoperte.
Com’è nato il tuo primo approccio alla scrittura? Quando hai capito che sarebbe stata la tua strada?
Da ragazzo lavoravo nelle tv private e subito dopo ho iniziato a produrre documentari scrivendo sceneggiature prima di passare alla regia. Quindi ho sempre visto la scrittura come un lavoro, un lavoro fortunato. Qualche anno fa decisi di saldare un conto che avevo con la cultura cinese – sulle orme di Terzani è diventata la mia seconda cultura dopo quella classica – raccontando dall’interno la comunità cinese e anche la sua criminalità. Non volevo annoiare il lettore con un saggio, scelsi la forma del noir. Nacque così il mio primo romanzo Little China Girl, un pasticciaccio brutto in salsa agrodolce, probabilmente il primo romanzo italiano a parlare con dati di fatto di mafia cinese. Avevo bisogno di un protagonista, non volevo né un poliziotto, né un detective, si è presentato alla mia porta il video reporter di guerra (che caso!) Alessandro Onofri.
Parliamo del tuo nuovo libro La laguna dei sogni sbagliati: dove nasce l’idea per questo progetto?
Dopo LCG la strada sembrava segnata, Alessandro Onofri aveva tutte le caratteristiche per diventare un personaggio seriale, ma sono stato tentato da un altro progetto di scrittura: usare sì lo stesso personaggio ma per esplorare altri generi, abbandonando il noir. La Laguna è un romanzo di formazione e per questo ho dovuto descrivere Alessandro bambino, ma ho anche altri progetti per lui, un romanzo speculativo per esempio. La Laguna è anche altro: sicuramente un tributo a persone che ho amato e perse, la condanna senz’appello all’inquinamento, “una terra malata genera mostri” è forse la frase più importante del romanzo, e alla guerra. Siamo negli anni ’90 e a poche miglia di mare si consuma il primo conflitto dopo la WWII.
La storia è appunto ambientata in una Venezia degli anni Novanta e racconta di un ragazzino di nome Alessandro. Com’è stato costruire questo personaggio con una storia così intensa nonostante la giovane età? C’è qualcosa di te in lui?
Ho provato un enorme tenerezza per il personaggio di Alessandro bambino, sensazione che non provo mai con l’adulto. Cercare di ricreare quella sensazione di languore un po’ sognante della pre adolescenza, l’incertezza, la determinazione a imprese un po’ folli, le scoperte, i primi amori così struggenti, le prime letture, è stata la sfida maggiore: per alcuni lettori ce l’ho fatta ed è stato il complimento più bello. Quanto c’è in me di Alessandro? Mi piace pensare che ci sia molto del piccolo e non troppo del grande, ma non ci giurerei. Ma tu volevi qualcosa di più preciso, vero? Anch’io sono cresciuto lontano dai miei genitori in una famiglia allargata composta dai miei nonni e da mia zia, lontano da Firenze. Ero amatissimo e viziatissimo ma vivevo senza mio padre e mia madre… questo faceva di me un ragazzino diverso.
Frequente tra le tue pagine è anche il tema dell’esoterismo che influenza il protagonista, diventato orfano all’improvviso. C’è soprattutto una linea sottile tra fantasia e realtà che compare con il trauma vissuto dal ragazzo per la perdita dei suoi genitori. Leggo tra queste righe un approfondimento sulla psicologia infantile e su quello che accade nella mente di un ragazzino quando affronta un trauma così difficile. Che ruolo può avere l’esoterismo in questo processo mentale?
Alessandro vive una vita quasi normale tra bullismo e primi amori ma una parte della sua psiche è segnata dal trauma, ce lo dice l’amata zia: ”credo che sia affascinato dalle ombre”. Dopo le fasi classiche del lutto – incredulità, ira e accettazione c’è un momento in cui per crisi e per lisi, si arriva a scordarsi per un attimo la perdita, credo che molti di noi lo abbiano sperimentato con stupore e dolore. Ma Alessandro questo non se lo perdona e cerca qualsiasi strada per confessare ai suoi genitori la colpa più terribile: li sta dimenticando. Per lui è un peccato mortale e allora sceglie una strada rischiosa, malsana: un esoterismo malato, contrapposto alla visione della zia:
«Ma i fantasmi esistono?» Alessandro continuava sulla sua strada.
«Tutto intorno a noi c’è qualcosa d’invisibile che possiamo decidere come percepire».
«È come quando dici che dobbiamo vedere oltre, oltre l’aspetto delle cose?».
«Proprio così». Batté le mani soddisfatta: «Di una cosa magica si può dire che è strana, bella o misteriosa, e non solo se è vera o falsa. Per alcuni non è fondamentale. Quelli che scrutano le ombre non hanno niente a che vedere con gli zotici che dividono il mondo in vero o falso. Il vero cacciatore di ombre, il vero Schattenjäger, ricerca il lato inconsueto delle cose e alla certezza della luce del mezzogiorno preferisce il crepuscolo».
In realtà l’aspetto esoterico del libro è secondario nel senso che il vero male è in quella terra veneta assediata dal Petrolchimico da una parte e dalla guerra di Iugoslavia dall’altra.
Come ti sei approcciato a questo genere letterario? Chi sono stati i tuoi maestri letterari?
Ho definito spesso questo libro un misto tra IT di King (so che molti storceranno il naso) e il Pendolo di Focault per i riferimenti al satanismo moderno. Dentro ci sono tracce rilevanti di Graham Greene “In viaggio con la zia”, di “Zia Mame” di Patrick Dennis e Mark Twain, perché no? In assoluto credo che sia necessario “inquinare” i generi, per cui J.L.Borges, Junot Diaz, David Foster Wallace sono gli autori che mi portano via e quando parlo d’avventura… Hugo Pratt.
Quali sono i tuoi futuri progetti? Puoi anticiparci qualcosa?
La Laguna, si chiude con una citazione di Hemingway da “Fiesta” di “non era bello pensarla così?” : quindi avrà un seguito. Toccherà ad un Alessandro adulto confrontarsi con le paure che pensava di aver sconfitto nell’infanzia e confrontare gli anni 90 con questo nuovo millennio dove antiche paure hanno trovato una nuova locazione. Magari nel Deep Web dove il nuovo e l’antico confluiscono.
Stefania Meneghella
Il link all’intervista su Kosmo Magazine: https://bit.ly/3ZrSS0W