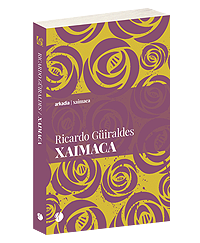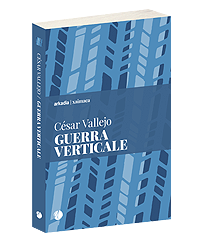“Guerra verticale” di César Vallejo
Era il più piccolo di undici fratelli, meticcio, la mamma era india ed è stato il più grande poeta e scrittore peruviano ed uno dei più importanti del Sud America, secondo solo a Dante a parere di Thomas Merton. Parliamo di Cesar Abraham Vallejo Mendoza, che conosciamo in Italia per un recente agile volume che offre un esempio articolato del suo contributo alla letteratura internazionale. L’inedita pubblicazione in Italia è merito della casa editrice cagliaritana Arkadia. A fine 2018 è andato in stampa e nelle librerie “Guerra verticale e altri racconti” (126 pagine, 14 euro), che raccoglie due testi: un romanzo breve, “Verso il regno degli Sciri” e una raccolta di racconti, “Scale”.
Tra i due, il testo narrativo più ampio, sebbene incompiuto, è quello che avvicina di più i lettori a Vallejo, i racconti infatti sono disomogenei per natura e si prestano meno ad offrire un valido biglietto da visita dell’autore andino.
Inquadriamo intanto questo protagonista della cultura mondiale, che ha lasciato una traccia della sua presenza nel Novecento europeo, durante il soggiorno in Spagna e in Francia, con una parentesi anche in Russia. Era comunista e la fede politica gli creò problemi col governo francese. Fu ben accetto invece dalle Sinistre spagnole e a Madrid affiancò Pablo Neruda nella redazione di una rivista antifascista, ma la sua permanenza in terra iberica ebbe bruscamente termine per l’esito infausto della guerra civile. Con la vittoria dei nazionalisti di Franco, riparò in Francia, dove morì prematuramente nel 1938, in totale povertà.
Cesar era nato a Santiago de Cucho nel 1892, sulle Ande. La madre, Maria Rosa, era di etnia india, come le nonne, il padre faceva il conciliatore di liti giudiziarie. Da ultimo nato, era destinato al sacerdozio, ma il ragazzo preferì il laicato. Studiò lettere e riuscì a laurearsi nel 1915, dopo avere alternato gli studi al lavoro, per mantenersi. Nelle piantagioni di zucchero, poté così constatare il cinico sfruttamento della mano d’opera indigena da parte di proprietari terrieri e manutengoli. Sovversivo e per un altro verso bohemienne, per il sodalizio stretto con altri giovani letterati, si trasferì a Lima e intraprese l’insegnamento. Contemporaneamente, si dedicò alla scrittura, in versi.
Cinque anni dopo, la nostalgia lo riportò a casa. A contatto di nuovo con le vessazioni subite dagli indios, manifestò atteggiamenti che misero in guardia le autorità. Un processo farsa, con l’accusa infondata di avere appiccato un incendio doloso, lo costrinse a mesi di carcere. Una condizione kafkiana, fa notare il curatore di questa prima edizione italiana, Luigi Marfè.
Guerra verticale, spiega, è un’espressione che mette in risalto come un conflitto, ancora prima di scatenarsi, sia già divampato nella mente di chi lo ha provocato o non efficacemente contrastato.
“Hacia el reino de los Scires” è stato un progetto avviato all’incirca nel 1924 e in realtà mai condotto a termine. Ebbe una gestazione travagliata questa sua riflessione storica sulle campagne di conquista condotte dal decimo re inca, Tupac Yupanqui, poco prima dell’arrivo dei conquistadores in Perù.
Il romanzo non è lungo ed è stato redatto a strappi, tra il 1924 e il 1928, in uno spagnolo che risente notevolmente degli echi della lingua andina. Ne autorizzò la pubblicazione solo in parte nel 1931. È uscito postumo nel 1944.
Nel passato inca, Vallejo vede le radici del popolo peruviano. Tupac vive una realtà prettamente incaica, ma la sua sensibilità politica sembra molto moderna. Comprende che la guerra è distruzione e che le responsabilità ricadono su chi l’abbia determinata.
I suoi guerrieri rientrano in Cuzco taciturni. Li guida il principe ereditario Huayna Capac, messo ancora adolescente alla testa di una spedizione di conquista, con l’obiettivo di occupare territori e soggiogare popolazioni. Una parte delle operazioni ha riscosso successo, una città ha spalancato le porte, tra lo spavento per l’ardore degli attaccanti e la corruzione degli anziani con elargizioni segrete, ma non c’è stato verso invece di piegare i fieri Chachapoya. Le perdite e il gelo sono risultate insopportabili. Da qui la ritirata a Cuzco.
L’inca è contrariato, ma non manca di considerare che quanto accaduto sia la volontà degli dei. Se non quella, è comunque la sua: il principe è stato sconfitto, i sacrifici vani, è tempo di rinunciare a combattere.
Basta conquiste, ci si dedichi alle fatiche della pace.
Questo vede Tupac ed è sincero quando dichiara di voler mettere fine alle guerre. Ma altri presagi e qualche catastrofe gli faranno cambiare opinione: l’esercito del Sole riprenderà la marcia verso la Cordigliera, pronto a mietere altre vite.
Nelle prime pagine dei primi racconti di “Scale”, riuniti nel capitolo “Cuneiformi”, lo scrittore rivede la vita in prigione, il rapporto con gli altri reclusi. Ogni brano prende il titolo da un muro del carcere. La presenza delle sbarre che bloccano la finestra della cella diventa un muro ulteriore, che delimita un micro universo claustrofobico.
“Coro di venti”, la seconda raccolta di racconti – altro capitolo della sezione “Scale”, spazia a sua volta su temi diversi uno dall’altro, decisamente meno omogenei.
Felice Laudadio