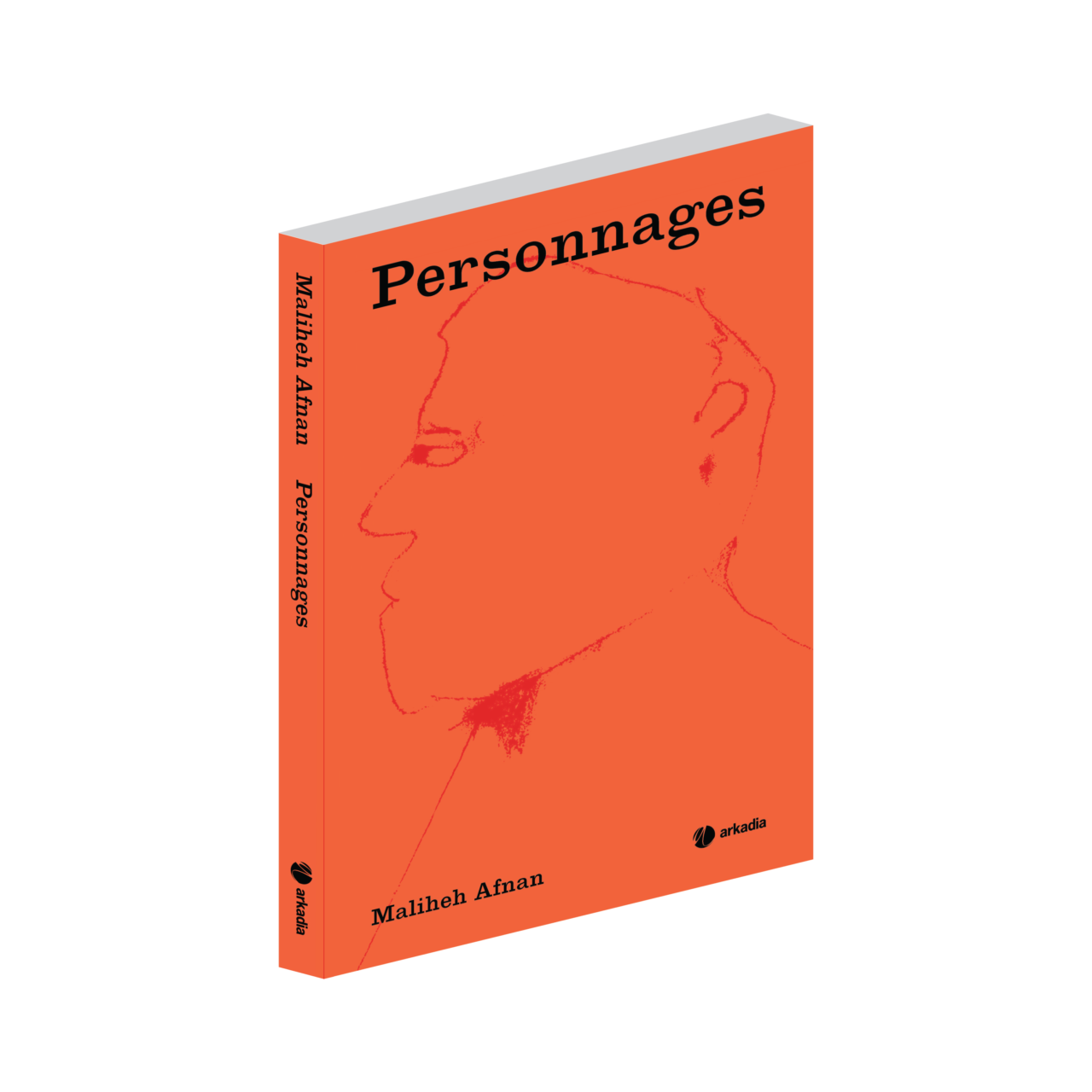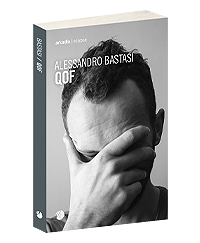Il catalogo della prima retrospettiva museale mai dedicata all’artista franco-palestinese Maliheh Afnan
Maliheh Afnan
Ricordi di Maliheh Afnan
La mostra Personnages dell’artista franco palestinese al Man di Nuoro
«Ciò che rimane ha un forte significato per me» – afferma Maliheh Afnan (Halfa 1935-Londra 2016) guardando la videocamera in un’intervista realizzata prima della sua scomparsa – «Porti via ciò che puoi, ma ti lasci molto alle spalle.» Il suo appartamento londinese, nel quartiere esclusivo di Kensignton – ultimo rifugio di peregrinazioni intercontinentali – è ancora così come compare in alcune sequenze delle interviste raccolte tra il 2013 e il 2016 da Rose Issa, critica e curatrice esperta di arti visuali del mondo arabo e dell’Iran, amica dell’artista palestinese è promotrice del suo lavoro. Si vedono l’antica sedia savonarola e la cassapanca di legno con gli inserti di madreperla e, accanto, in una teca trasparente i libri antichi di famiglia, passati di generazione in generazione. In questo appartamento-studio in cui, tra il ’96 e il 2016, Maliheh Afnan ha trascorso molto tempo in solitudine, concentrandosi sul disegno e sulla pittura: «l’arte è la digestione della vita che ho avuto». Pennelli e colori – la sua palette è essenzialmente una combinazione di marroni, grigi, neri, gialli, rossi – sono ancora al loro posto sul lavoro, vicino alla finestra, quando Luigi Fassi vi entra per le sue ricerche d’archivio. Anche per il direttore del MAN di Nuoro curatore di Personnages, prima mostra di Maliheh Afnan in un museo europeo (fino al 9 giugno), il fascino è innegabile nel ripercorrere quelle storie lontane e vicine, avvolte nell’atmosfera intangibile e sospesa di parole in parte non dette. La sovrapposizione di memoria reale, interpretazione e subconscio, del resto, sono presenti nell’opera di Afnan, in particolare quando – nel tempo – realizza con un gesto automatico la serie di Personnages, citati nel titolo alla mostra di Nuoro. «Personnages appare così come un archivio disperso, un registro di presenze, biografie e identità oramai non più riconducibili a una possibile matrice comune, ma abbandonate alla deriva del tempo», scrive Fassi nel testo del catalogo monografico pubblicato da Arkadia. «La mappa della tua vita è sul tuo viso», afferma l’artista. Nel suo, certamente, non c’erano tracce di tante esperienze, a partire dalla sua eredità identitaria e culturale persiana, direttamente collegata con la fede Bahá’í, religione abramitica monoteista basata sull’unità, nata in Persia alla metà del XIX secolo dagli insegnamenti di Baha‘u’llha, di cui Maliheh Afnan era pronipote (tra l’altro è sepolta nel cimitero londinese di Southgate, vicino alla tomba di Shoghi Effendi, altro capo spirituale Bahá’í). Baha‘u’llha fu fautore di numerosi libri, tra i quali Il libro più santo, Il libro della certezza, Le sette valli, Le parole celate. Un bagaglio culturale che affiora più esplicitamente in un’opera come What Remains (2014) e, come si diceva, appartiene all’artista fin da quando – bambina – è affascinata dai segni calligrafici, ancor prima di conoscerne il senso. Parole perdute come la patria Baha‘u’llha, e con lui i suoi discendenti, dovette lasciare per riparare nell’antica città di Akka (conosciuta anche come Akko o S. Giovanni d’Acri), allora sotto l’impero ottomano, dove ancora oggi si trovano monumenti e luoghi santi venerati dai suoi seguaci. I genitori di Maliheh Afnan, come lei, nacquero in Palestina. Così si chiamava quel territorio fino al 1948, data di nascita dello stato di Israele. Nel 1949 le scuole erano chiuse, c’era scarsità di cibo e una situazione tutt’altro che sicura: i genitori decisero di portare la famiglia a Beirut con l’idea di trascorrervi l’estate, invece non tornarono mai più indietro. A Beirut l’artista studia arte all’American University e, successivamente, alla Corcoran School of the Arts and Desogn di Washinston dove trova se stessa, «ciò che volevo essere». Alla pittura affida i suoi pensieri, come nell’installazione Contained Thoughts, 8 works (2000), in cui gli otto disegni su carta sono arrotolati con un nastro: sembrano antichi codici in viaggio verso un’altra epoca. Con il marito e la figlia Shereen vivrà poi Kuwait, nuovamente a Beirut dal ’66 al ’74, dove respira i primi sintomi della guerra civile, quindi a Parigi e Londra. Nel 1971 è il pittore, poeta e compositore statunitense Mark Tobey ad organizzare a Basilea la sua prima mostra. Un’amicizia e una stima consolidata anche dalla conversione di Tobey alla religione Bahá’í (già dal 1918) dal suo fascino per l’oriente e per l’arte calligrafica, matrice della sua ricerca pittorica nell’ambito dell’espressionismo astratto con l’evoluzione del «White Writing». «La Pace interiore è un altro ideale, forse lo stato ideale da ricercare nella pittura, e certamente è preparatorio all’atto», scriveva il pittore nel 1958. Se pure affiora timidamente un pizzico di humor, nel Personnages di Afnan è ben più forte il sentimento di malinconia. «Li ho chiamati personaggi e non ritratti, perché non ci sono modelli»: nel tracciare questi volti indefiniti che, in realtà, sono la combinazione di personaggi reali e di fantasia, l’artista ne ferma lo sguardo e la sensibilità. In Sam (1990), Suspended Sentence (1988), The scribe (1990) e, più in generale in tutti gli altri Untitled, il segno sembra riferirsi anche a certi aspetti teorizzati da Dubuffet nell’art brut, in particolare all’istintività, alla spontaneità, al carattere primordiale, all’alienazione. Quanto ai materiali se in Silent Witness (1979) e Wastron (1979), il cartone, con la sua superficie bruciata che allude alla guerra civile in Libano, è il supporto ideale per contenere ansie e paure, la «la texture» di scotch trasparente di Nuchis (1985) restituisce con le tonalità di una pittura rupestre preistorica, l’essenza di un momento vissuto proprio in Sardegna. Stavolta la scrittura è leggibile, il nome del villaggio gallurese è ripetuto più volte, come quando si sottolinea nella pagina del proprio diario un attimo di pura felicità.
Manuela de Leonardis