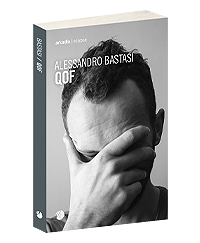Il nostro rifugio prima della pausa: la sincerità di José Luis Cancho
Anche Ork fa i conti con l’approssimarsi delle ferie, un periodo di sospensione durante il quale porteremo con noi libri e storie che sapranno dirci, raccontarci, nominare tutto ciò che ancora non sappiamo o che è rimasto nelle retrovie in attesa della voce di uno Scrittore. In giro non ne circolano tantissimi, di questa specie in via di estinzione, nonostante l’area editoriale si mantenga su livelli di una sovrapproduzione di cui faremmo volentieri a meno. Nell’arco di pochi giorni, ci siamo ritrovati a scartare tre testi di un colosso editoriale, per ragioni diverse, per l’inesistenza di un’identità chiara (scegliere di fare esordire una neutralità è un investimento dubbio, salvo avervi rintracciato potenzialità future e, in tal caso, ci si chiede perché si sia scelto di pubblicarla anticipatamente), per la banalità nella scelta autoriale della modalità con cui affrontare il tema centrale, già inflazionata e senza un’anima, osiamo dire noi in un’apparente semplificazione, in mancanza, cioè, di un’angolazione anomala, di una luce propria, insomma, e meritevole nello sguardo tale da giustificarne la ripetitività schematica. Ancora per assenza di sincerità. E su questo punto mi tocca spendere qualche parola in più perché l’ospite di oggi, se una lezione ci consegna, lo fa proprio lungo il filo sottile, ma non per questo cedevole alle sollecitazioni esterne, che siano critiche o ruvidezze del mondo, del rapporto con se stessi e con il lettore. Si sottovaluta spesso quest’ultimo a tal punto da credere che gli si possa somministrare di tutto: non solo l’inesistenza di una dimensione stimolante, ma persino qualcosa dentro cui chi scrive non è o non è ancora. Se è vero che la narrazione si nutre di una necessaria percentuale di invenzione, è altrettanto vero che non si può scegliere di raccontare qualcosa che non abbiamo vissuto da qualche parte o in qualche forma, così come non si può elevare a pagina scritta qualcosa che abbiamo deciso, più o meno inconsciamente, di scansare. Non possiamo improvvisarci maestri di vita e del dolore, se scrivendo non troviamo il modo, nostro, di farceli entrare, la vita e il dolore, coerentemente a un’esperienza, intensa o anche distante, che comunque abbiamo fatto. È la fedeltà a quella coerenza il nevralgico punto di snodo di un’arteria che congiunge chi scrive a chi legge: la sintesi del patto con il lettore che lo Scrittore è in grado di creare, l’inizio di un’insospettabile collaborazione e di una crescita reciproca o il principio di un tradimento. Al lettore attento, attenzione non al critico, non sfugge e l’ammutinamento è molto di più di un’evenienza possibile del viaggio. Di là dalla fuga, l’isola felice: “I rifugi della memoria”, di José Luis Cancho (traduzione Marino Magliani), edito da Arkadia nella collana “xaimaca jarama”, è stato in qualche modo l’approdo sicuro e inaspettato di un viaggio intrapreso contro il volere propizio degli dei, ammesso di potere concepire come disaccordo divino la nostra incapacità di farci condizionare dai venti che spingono, nella triste ordinarietà di questi tempi, molte delle esperienze di viaggio sparse potenzialmente nei libri in circolazione. Il romanzo di Cancho è un atto estremo di fiducia nel lettore che sente di avere a che fare con un’identità che, raccontando della sua fragilità e dell’ambiguità che la natura umana tradisce e implica, si rivela in tutta la sua forte schiettezza. Quella coerenza, insomma, che è base di un innamoramento che, pur nel gioco proiettivo, si radica su un mantello di realtà, quell’elastico sostare in attesa della partenza verso l’alto, senza cui la lettura non svilupperebbe i suoi potenziali benefici. L’autore racconta di sé e della sua prigionia, dell’opposizione al regime di Franco e, nonostante questo sia già un disvelamento della propria esperienza di vita tale da giustificare l’urgenza dello scrivere, concede al lettore un pezzo in più, una moltitudine di tracciati che, convergendo nella complessità della ricerca di sé, traggono linfa e sostanza dal linguaggio. Questo accade non solo perché le parole finiranno per configurarsi come l’approdo, tardo ma inevitabile, delle innumerevoli tappe del suo percorso esistenziale, ma perché il verbo si fa latore di inganni e verità, scavalca la storia e il suo carico ideologico e accede a un piano di realtà ambiguo almeno tanto quanto tutto ciò che si cela oltre la necessità di definizione e di incasellamento nel falso e necessario gioco sociale che la vita in qualche modo impone ai fini della stabile sopravvivenza. Ma non è quest’ultima la dimensione congeniale a José Luis Cancho che le forme sceglie di sovvertirle, di scardinarle, provando a fare i conti con ciò che c’è sotto, sotto la realtà, sotto le parole con cui la medesima si costruisce e si pone sotto lo sguardo disattento di tutti, di molti. Non dei lettori. «Mi hanno buttato giù perché credevano di avermi ammazzato. Il fatto strano è che non solo non mi avevano ammazzato, ma non mi hanno ammazzato nemmeno buttandomi giù»: recita così un passaggio quasi iniziale dei suoi “Rifugi”, rivelando non solo le sevizie subite per ribellione al regime, ma anche l’interpretazione dell’accadimento che passa dal verbo, l’idea che l’altro si costruisce su di noi in merito al significato che attribuisce a ciò che si svolge sotto gli occhi e che dovrebbe essere univoco e non lo è, se lo Scrittore narra l’accaduto da un’ipotetica postazione oltre la vita (“Scrivere come se fossi morto, questo è il mio progetto.”). Dunque, la fallacità della parola che non riesce a farsi carico di una verità che non sia la scarnificazione della vita stessa e la sua riproposizione essenziale, ciò che Cancho decide sostanzialmente di compiere attraverso il diario nella cui forma chiaramente volge lo scritto ospitato da Ork. Lo Scrittore, facendo esperienza della prigione, finisce per porsi rispetto alla vita in un’ottica di matura distanza e, parallelamente, di ingresso ufficiale nella medesima, come se riuscisse, pur nell’attraversamento di una tragedia personale e politica, a trovarsi nel giusto punto di equilibrio per stare nelle cose quel tanto che basta per non farsi travolgere dalle medesime a ridosso del superamento del confine che ci piace definire “di non ritorno”, in cui smettere di fare i conti con la precarietà dell’umano e con le urgenze del Sé non è più possibile. Qui l’ideale è svestito della sua carica giovanilistica, non perde senso, ma disperde l’afflato del passato nella ricomposizione della vicenda storica dell’opposizione al regime in termini realistici, talvolta piegati alla convenienza e alla cooptazione. Qui il carcere è sperimentazione di una ritrovata libertà, il diritto di incarnare gli ideali senza menzogna (“E la cosa più importante era che in quel mondo recluso ci si poteva esprimere liberamente: oramai non c’era più niente da nascondere. Eravamo quel che eravamo, militanti antifranchisti, giovani comunisti delle più diverse tendenze: trtotzkisti, leninisti, maoisti, luxemburghisti.”), lo spazio in cui rinviare al rientro in società la finzione di essere ciò che non si è, il capovolgimento dell’ordinario, la dimensione che, sovvertendo i piani della verità e della menzogna, introduce lo scrittore all’ambiguità del vivere, lo spinge, una volta uscito, un po’ più in là dove possiamo essere tutto e il contrario di tutto (“Ero un io che creava altri io per scoprire se stesso.”), seppure entro un solco identitario, gli conferisce l’autorizzazione ad essere tutte le vite incarnabili dai limiti sanciti dal suo corpo, compatibili con i suoi tempi, con quella porzione di contraddizioni in cui sa e fa esperienza di essere. “Dietro gli occhi, in viaggio”, pastello secco su carta Pastelmat, Mork. Ciò rende questo spaccato di memorie non solo carico della schiettezza verso cui abbiamo provvidenzialmente virato prima delle ferie, ma anche necessariamente sviluppato verbalmente in un’estrema semplicità che è quasi un tornare a nascere, la frattura della crisi, il tempo prezioso dell’attesa, il buio, il cimitero che, insieme al quartiere e alla prigione, racconta di chiusure cicliche e di necessari abbandoni, la difficoltà di trovarsi fuori dall’assenza di verità, dalle mistificazioni e dai segreti, la fatica di darsi un linguaggio proprio che riesca a riesumarlo dalle spoglie di una vita passata. Miglior viaggio per noi creature aliene, eternamente indefinite, viaggiatori viaggianti di un tempo nostro in cui la vita entra a singhiozzi, senza per questo rinunciare alla sua forza, non poteva esserci. A noi pare il perfetto preludio ai prossimi spostamenti, alle paure da incontrare, alle maschere da lasciare, alle fragilità da portare tra le mani, un po’ sbilenchi, ma fedeli a una linea immaginaria. Non un partito o un’idea, ma quel desiderio che congiunge la realtà alla luna di Astolfo.
Mindy