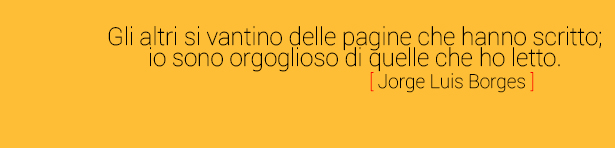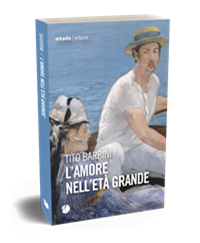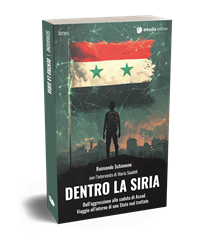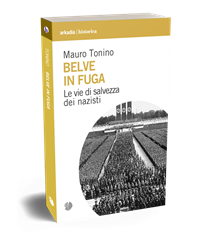Intervista a Marisa Salabelle, in libreria con “La bella virtù”
Secondo volume sulla storia di una famiglia, “La bella virtù” spazia dagli anni Cinquanta e Sessanta ma arriva fino alla pandemia di Coronavirus, dando voce a quattro personaggi, fra vita di tutti i giorni, lutti e ricerche. In questa intervista Marisa Salabelle ci lascia entrare nel suo progetto, fra possibili nuovi sviluppi, sessualità, religione e i grandi autori che l’hanno accompagnata e ispirata.
Marisa Salabelle è nata a Cagliari, ma vive a Pistoia dal 1965. Laureata in Storia all’università di Firenze, ha frequentato il triennio di studio teologici presso il seminario arcivescovile della stessa città.
I suoi libri più famosi sono Gli ingranaggi dei ricordi, 2020, e La scrittrice obesa, nel 2022 sempre per Arkadia Editore.
La bella virtù è pubblicato per Arkadia editore nel 2025 e le domande sono per questo libro.
Intervista a Marisa Salabelle
Buongiorno e grazie. Dove ha preso l’idea della bella copertina e del titolo del romanzo?
Copertina e titolo sono di competenza dell’editore, come i paratesti, cioè quello che viene scritto sui risvolti e nella quarta di copertina: presentazione del libro, bio dell’autore, una citazione… Tuttavia con i piccoli editori c’è una discreta collaborazione riguardo a questi aspetti. Il titolo è quello che ho proposto io: non sempre va così, con Arkadia ho pubblicato tre romanzi e sia La bella virtù che La scrittrice obesa sono titoli miei, mentre Gli ingranaggi dei ricordi è stato concordato con l’editore.
Per quanto riguarda la copertina, di solito Arkadia mi propone una scelta di immagini. In questo caso l’editore mi ha mandato una serie di bozze di copertina tra le quali la mia preferita è stata quella poi prescelta, ovvero l’immagine di una bella ragazza sorridente a bordo di una Vespa, che in qualche modo rappresenta, per me, il personaggio di Maria Ausilia, una ragazza che cerca, senza riuscirci del tutto, di emanciparsi dal ruolo che una società ancora patriarcale le ha assegnato.
Chi scrive ha detto che le pagine del libro possono essere anche pezzi di un diario o lettere. Cosa sono realmente nella sua scrittura?
Questo romanzo è costruito su quattro voci narranti: ognuno dei protagonisti parla in prima persona, perciò potremmo dire che i loro contributi costituiscono in effetti una sorta di diario per quanto riguarda Carla e Kevin, mentre si tratta di memorie nel caso di Felice e Maria Ausilia.
Se invece intende cosa siano, per me, le pagine che scrivo, indubbiamente la componente maggiore è rappresentata dalla memoria: memoria dei tempi in cui ho vissuto, delle esperienze che ho avuto, delle persone che ho conosciuto. Voglio precisare però che la mia scrittura non è nostalgica, non c’è nostalgia del passato in me e nemmeno nelle cose che scrivo. Inoltre, anche se attingo a materiale personale, ci tengo sempre a precisare che i miei sono romanzi e non “storie vere”: la componente biografica c’è ma è mescolata a quella dettata dalla fantasia.
La vita nel libro scorre tranquilla, tranne un avvenimento luttuoso enorme. Come ha messo insieme il dolore con la dolcezza?
Il libro parla della vita di una famiglia come tante, con alcuni aspetti che la rendono originale (per esempio la parentela con un santo famoso) e altri invece che la rendono rappresentativa di una società e di un’epoca, l’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Come in tutte le famiglie, a un tran tran tutto sommato banale si alternano pagine drammatiche.
Tutti noi abbiamo perduto una o più persone care. Il mio modo di raccontare la tragedia è attraverso una leggera ironia: sono un po’ manzoniana, in questo, non riesco ad abbandonarmi al dramma, detesto il patetico e quindi cerco di smorzare il dolore con un sorriso.
Nel romanzo conta molto lo scandire del tempo: a volte si va a ritroso, ma perlopiù si arriva al 2020, con solo accenti preoccupanti per il coronavirus. Perché il bisogno di nominarlo ma in modo circoscritto, sintetico?
Avevo bisogno di inventarmi qualcosa per vivacizzare il personaggio di Kevin, il giovane studente che fa ricerche sulla genealogia familiare, perché non risultasse una figura scialba. Così, tenendo presenti gli anni in cui collocare il suo lavoro per la laurea magistrale (nel precedente Gli ingranaggi dei ricordi Kevin aveva svolto la tesi triennale sulla figura di Silvio Serra, partigiano non molto noto e prozio di sua madre, nel 2016) ho avuto l’idea di farlo slittare al 2020, in modo da sfruttare la pandemia per arricchire la parte relativa a Kevin. Felice e Maria Ausilia sono spalmati in tutto il romanzo. La figlia Carla scrive quasi solamente di loro con un rapporto strettissimo col padre Felice, che sembra il perno della narrazione. La convince quello che ho scritto?
Senza dubbio, almeno nelle mie intenzioni, il protagonista assoluto del romanzo è Felice, di cui si rievoca l’infanzia difficile, si seguono gli anni della giovinezza e della maturità, infine lo si accompagna nella malattia e nella morte. Felice è una delle voci narranti ed è inoltre protagonista delle narrazioni di Maria Ausilia, sua moglie, e di Carla, sua figlia. Anche le ricerche di Kevin sono collegate alla figura di Felice, perché è sulla sua famiglia che il giovane indaga, per scoprire l’esatto rapporto di parentela tra il nonno Felice e il santo Giuseppe Moscati.
Lei ha uno stile riconoscibile; ma cosa migliorerebbe di questa “saga” familiare?
Non so cosa rispondere a questa domanda… non perché penso che il romanzo sia perfetto, tutt’altro, ma perché ci ho lavorato molto e ho cercato di fare “il meglio possibile”.
Cioè, penso che questa sorta di saga in due volumi (Ingranaggi e Bella virtù) sia il meglio che io potessi fare riguardo a questo tema. Naturalmente un lettore esterno potrebbe indicarmi i lati deboli, darmi dei consigli e suggerirmi dei miglioramenti, e questo in effetti è accaduto mentre i due romanzi erano in corso d’opera: ormai però sono usciti e non si possono migliorare più…
Qualcuno mi ha detto che il ciclo potrebbe completarsi con un terzo romanzo, perché ci sono personaggi che hanno avuto un ruolo marginale e che potrebbero aver voglia di far sentire la loro voce. Devo dire che non avevo pensato a un terzo capitolo, ma in effetti questo suggerimento lo trovo stimolante!
Maria Ausilia da sola regge dolore e ironia, mentre Kevin sembra un pretesto per non dare ulteriore spazio a Felice, Maria Ausilia e Carla. O è solo una mia impressione?
Kevin è un personaggio “di servizio”. A lui infatti, in entrambi i libri, sono affidate ricerche che devono chiarire alcuni aspetti poco conosciuti della vicenda familiare. Forse per questo ha meno spessore degli altri: non mi interessava approfondire la sua interiorità, quanto seguire le sue ricerche e le sue riflessioni, i suoi dubbi in proposito. È anche un personaggio “di alleggerimento”, perché è giovane, un po’ scettico, e le sue avventure sono lievi.
Lei parla di sesso tra coniugi molto ignoranti del come si pratica con una grazia che ci fa sorridere. Perché Felice è così preso ancora dal rapporto con la Chiesa cattolica? Di solito chi entra in istituti religiosi poi cerca di dimenticare quel periodo. È così?
Secondo me l’educazione ricevuta da bambini e da ragazzi lascia un’impronta importante in quello che poi diventiamo. In particolare l’educazione ricevuta all’interno di un ente religioso, soprattutto in periodi della nostra storia passata in cui il peso dell’educazione cattolica era davvero forte. Inoltre Felice è un ragazzo abbandonato, vive per strada, non ha la madre e suo padre è spesso lontano: è inevitabile che si leghi a don Angioni, il prete salesiano che diventa il suo mentore, e che assorba profondamente i suoi insegnamenti.
Riguardo poi alla sessualità, c’è da dire che proprio negli anni Cinquanta del Novecento un pesante silenzio avvolge sia la sana, normale sessualità coniugale, che le situazioni di abuso. Maria Ausilia, che non è bigotta come Felice, non ha ricevuto in famiglia un’educazione sessuale, e del resto all’epoca questo era normale, perciò prima del matrimonio è in ansia perché non sa cosa deve aspettarsi…
Insomma lei mette un punto al proseguimento di questa famiglia con la morte di Felice? Pensa che due libri siano sufficienti? Perché lo ha fatto morire tra forti dolori? Lei ha paura della morte?
Alla prima parte della domanda ho già risposto: non pensavo di scrivere un terzo capitolo della saga, ma potrei farci un pensiero alla luce di alcuni commenti che ho ricevuto.
Riguardo alla morte di Felice, più che forti dolori quello che lui prova è una grande sofferenza psichica. Nonostante sia anziano, non vuole arrendersi, non vuole morire, e nonostante la sua fede ha il terrore della morte. Si può dire che la fede non l’aiuta ad affrontarla.
Quanto a me, ho ormai una certa età e nella mia vita ho visto morire molte persone, alcune delle quali in età avanzata, ma altre ancora giovani. Forse per questo la morte è sempre presente nei miei libri, e non soltanto nei gialli, dove è praticamente d’obbligo. Mi sono accorta che nel primo capitolo di ognuno dei miei libri, considerando anche alcune cose che ho scritto ma non ancora pubblicato, nel primo capitolo, dicevo, c’è sempre una morte…
Riguardo alla mia, di morte, non ci penso granché; penso di avere davanti a me ancora un po’ di tempo, e non sono particolarmente preoccupata. La cosa di cui ho paura non è tanto il morire, ma la sofferenza, l’invalidità, la perdita dell’autosufficienza.
Mi dica, se ne ha voglia, quali libri leggeva durante la scrittura del romanzo e in generale di libri recenti che le sono piaciuti.
Oh, impossibile rispondere a questa domanda… io leggo una quantità veramente industriale di libri, e non ricordo cosa leggessi durante la stesura di questo romanzo.
Però posso dire qualcosa degli autori o dei libri che mi hanno influenzata. Ho già citato Manzoni per l’ironia e aggiungo anche per il “misto di storia e d’invenzione”, che è una caratteristica del mio scrivere e che a volte mi procura divertenti scambi di battute con quelli dei miei lettori che mi conoscono personalmente. Per l’infanzia di Felice, il modello è sicuramente dickensiano, e del resto Dickens compare nel romanzo fin dalle prime pagine, come un autore amato e discusso da Felice e da sua figlia Carla. Per la pluralità delle voci narranti, che è presente anche in altri miei libri, mi sono ispirata a uno scrittore che ho amato molto, Abraham Yehoshua. Infine, per la descrizione delle difficoltà di Felice e Maria Ausilia nei primi tempi della loro vita sessuale ho preso spunto da Chesil Beach, un romanzo di uno dei miei autori preferiti, Ian McEwan.
Vincenzo Mazzaccaro
L’intervista su SoloLibri