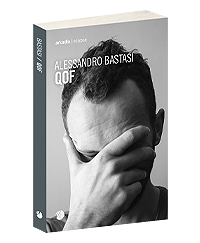L’OMBRA DI TIEPOLO, di Alberto Frappa Raunceroy
“Tiepolo è la disperazione del biografo. Si sposta tra ville, palazzi e chiese, in ottemperanza ai voleri dei committenti. In nessuna occasione manifesta la sindrome dell’artista. Di suoi malumori, cupezze, euforie nulla sappiamo.” Così Roberto Calasso nel suo magistrale saggio IL ROSA TIEPOLO incide la vita dell’artista su un sigillo che verrà di volta in volta impresso a suggellare ogni possibile tentativo di raccontarla. Della vita del pittore conosciamo episodi a macchia di leopardo, sprazzi dedotti dalla sua perseverante e frenetica attività o indizi ricavati da contratti, commissioni, forniture di materiali e colori; essi ci dicono dove si trovasse e a cosa stesse lavorando ma non molto di più. Come avventurarsi allora in un romanzo partendo da una lunga serie di omissioni delle fonti? Le sue opere più private e meno ufficiali costituiscono un’altra sorgente cui abbeverarsi per azzardare una ricostruzione di tratti caratteriali e temperamento lasciando a fantasia e intuizione altri elementi ma quanto ci si può spingere, in quella che rimane un’attività deduttiva che si basa sul criterio della verosimiglianza? Queste e altre difficoltà hanno accompagnato la redazione del mio romanzo L’OMBRA DI TIEPOLO uscito nel novembre scorso per i tipi di Arkadia di Cagliari. Esso racconta (e vagheggia) un solo anno (il primo) della sua presenza e della attività a Udine. Quanto avremmo voluto vederlo percorrere i vicoli del centro, incrociarlo o seguirlo da lontano magari per coglierne abitudini, debolezze o anche un solo vezzo. Abbozzato un Tiepolo schivo ed enigmatico, con il procedere della scrittura si è delineato un personaggio notturno quasi onirico. Un Tiepolo “altro” rispetto al pittore descritto e glorificato negli omaggi ufficiali. Glorificare però è anche un modo per incasellare e classificare. Ed è sempre Calasso a ricordarci che di Tiepolo “venne considerato decorativo ciò che non si riusciva a leggere, ornamentale ciò che era troppo carico di significati.” E ancora. “Molti si affannavano a ripetere ciò che, nella sua ovvietà, è forse anche vero: con Tiepolo si chiudeva per sempre un’epoca. Ma trascuravano di registrare quale inaudito addensamento di veleno e di dolcezza si compisse in quel motus in fine velocior.” A che veleno si riferisca Roberto Calasso quando accenna a questi lati oscuri o – meglio – in ombra mi è stato rivelato poco alla volta. Il giovane Giambattista giunge a Udine e si ritrova davanti alla sfida complessa di una commissione ecclesiastica con scene teologiche che trascendono i suoi gusti e istanze estetiche ma sembra che le difficoltà anziché scoraggiarlo, lo motivino e gli forniscano un’energia nascosta. “Tiepolo non comprendeva il dolore. Ne provava ribrezzo. Non comprendeva quel Dio biblico che poneva alla base dei suoi patti con l’uomo sacrifici nel deserto, esilii, comandi che non avevano senso. Per lui la vita era luce, dinamismo, un’attività instancabile e febbrile che lo spingeva a creare bellezza (…) Allora a che cosa servivano tutto il dolore, la rassegnazione, il sacrificio e la preghiera? Cosa c’era di buono e di raccomandabile in quelle scene di vita tormentata che gli volevano fare dipingere. Lui lo ignorava ma avrebbe fornito la dimostrazione di essere in grado di rappresentarla. Avrebbe dimostrato che lui sapeva essere di parola, che avrebbe potuto soddisfare ogni tipo di committenza e che il suo talento non conosceva limiti se non quelli che lui si imponeva per aderire alle richieste di chi lo pagava. Tiepolo sapeva che solo lui e il suo spirito avrebbero trovato posto in una dimensione fatta di cieli illuminati, di spazi aerei, di albe luminose dove non sarebbero mai esistiti malattia, dolore o limitazioni a una propria palpitante volontà. Un paradiso fatto su misura di un desiderio sconfinato: il suo.” Da questo Tiepolo volitivo e ambizioso che lavora agli affreschi di Udine sembra quasi distaccarsi un altro “sé” che si ribella alla maschera che gli hanno appoggiato sul volto e che gli attribuisce una parvenza di eterna felicità. Si ribella al fatto che gli impediscano di palesare i suoi inferni interiori o di sciogliere enigmi emotivi. Un Tiepolo che vuole uscire dalle cornici dentro cui lo hanno costretto o hanno sigillato i suoi affreschi. Paradossale che proprio a Udine (sulla volta dello scalone del palazzo patriarcale) Tiepolo stesso abbia affrescato un Lucifero che viene cacciato dal Paradiso da San Michele Arcangelo che lo precipita giù negli abissi infernali. “Io vedevo Satana cadere dal Cielo come folfore” (Lc 10. 18.) Ecco proprio su quella volta il pittore lancia un primo e incontestabile segnale di insofferenza a lacci annodati dall’esterno. Su tutto, spicca un braccio che trascende l’affresco e, appropriandosi della fisicità dello stucco, scappa dal dipinto scavalcando la cornice per afferrare la realtà di chi guarda. Un atto di ribellione dentro l’obbedienza di una commissione o l’attestazione che lui riuscirà comunque a ritagliarsi uno spazio dove il suo profondo si esprimerà sfuggendo comunque a limiti imposti altrove? Il titolo del romanzo “L’ombra di Tiepolo” rimanda a una protesta interiore e libera questo lato sconosciuto perché invisibile o – meglio – riscontrabile in alcuni lavori del grande maestro ma che solo alcuni hanno avuto l’intuizione e la costanza di indagare. È ancora Calasso che ricorda come “L’opera di Tiepolo potrebbe presentarsi come una successione di soffitti più o meno vasti, di pale di altare più o meno imponenti, di scene mitologiche più o meno maliziose e di ritratti più o meno ufficiali, se non ospitasse anche, annidato al suo centro, un armadietto delle spezie, delle droghe e dei veleni poco vistoso e segnalato da due etichette che vorrebbero essere rassicuranti: Capricci e scherzi di fantasia.” Ecco allora trovato il nascondiglio dove Tiepolo tiene custodisce il suo veleno e i suoi rimedi: le sue notti di veglia quando la sua interiorità si esprime e si celebra come in un santuario segreto, un sancta sanctorum. E un santuario di irresistibile magnetismo il pittore veneziano trova tra le stanze dell’appartamento dove è pigionante a Udine, in una casa attaccata alla Torre di San Bartolomeo (attuale porta Manin) che da sul piazzale del palazzo dei Patriarchi di Aquileia. Lì incontra la figura di Teresa Sturm, una donna prigioniera di una malattia che la obbliga a letto, sepolta sotto una montagna di adipe.
Eccone un abbozzo:
“Lo sconcerto gli fece pensare a una visione. Socchiuse gli occhi e affinò lo sguardo. Si stava confondendo. No, percepì un’essenza vitale. Tacque e udì un maestoso e tormentato respiro. Rimase impietrito. Indeciso e attratto fece un passo avanti. Distinse allora con nitidezza quello che gli altri sensi gli avevano comunicato per certo. Era una presenza reale e tangibile. Giaceva su un letto anzi lo sovrastava e lo inglobava come fosse stato parte del suo corpo. I polpacci tumidi come vesciche enfiate, le braccia ipertrofiche che fuoriuscivano dai panneggi delle lenzuola maestose come nevi perenni.
(…) Qualcosa di nobile, arcano e terribile, si sprigionava da una creatura ciclopica che languiva su un giaciglio avvolto in lenzuola rattoppate e consunte. Accanto al corpo, piatti incrostati di grasso, stracci sporchi, boccette buttate alla rinfusa parevano custodirne il riposo.”
La deformità di quella ispirazione non lo disturba, anzi:
“(…) quella camera era divenuta il centro dei suoi pensieri. Non è che trovasse Teresona Sturm un soggetto bizzarro, prodigioso o deforme, certe sensazioni erano aliene dal suo modo di interpretare la realtà. Per lui non esistevano persone normali o anormali. Per lui esistevano solo persone che sarebbero state in grado di abitare con familiarità e disinvoltura i mondi che lui prefigurava nella mente. (…)
Ora lei beffarda troneggiava con quel suo corpo immenso languido e morbido su un trono di pietre candide in un tempio mitologico, oppure volteggiava al sommo di una massa di nubi azzurre-violacee su un cielo in tempesta, costellato di fulmini, o ancora conversava, coperta da una lieve seta. Con ninfe, satiri o abitatori di fiumi e foreste.”
“Tiepolo custodiva il tesoro della “bizzarria dei pensieri”, già osservata dai contemporanei e sempre più sfuggente per i posteri. Lui che passava la vita a rispondere prestamente a committenti religiosi e laici, nobili e parvenus, regnanti e principi, per una sola volta si concesse di comporre un’opera senza committente e senza acquirenti. (…)”
Ecco, nel romanzo, l’ombra di questo Tiepolo si proietta sugli affreschi del patriarcato e anziché oscurarli ne evidenzia aspetti che dobbiamo ancora indagare.
Alberto Frappa Raunceroy, friulano, laureato in Storia del Diritto Romano alla Cattolica di Milano, attualmente risiede a Udine. È autore de La condanna dei Tre Capitoli (Il Segno, 2007), Il serenissimo borghese, ispirato alla tragica caduta di Venezia così come vissuta dalla famiglia dell’ultimo doge, Lodovico Manin. Il romanzo, pubblicato nel 2012 dall’editore Il Segno e ripubblicato nel 2014 da Solfanelli e nel 2018 da Arkadia Editore, è stato inserito nell’antologia del Premio nazionale “Albero Andronico 2012” di Roma e, nello stesso anno, si è classificato secondo nella sezione Narrativa al Premio Nazionale “Mario Soldati” di Torino. Con Il parruccaio di Maria Antonietta (Arkadia Editore 2016), secondo classificato al Premio Letterario nazionale Palmastoria 2018, l’autore porta il lettore in un terreno intriso di contraddizioni e ricerca della bellezza, grazie alla potente figura dell’enigmatico Salamandre. Il libro La lanterna nera, pubblicato nel 2020 si è imposto l’anno successivo come il secondo romanzo storico più gradito ai lettori del supplemento letterario Robinson di Repubblica che lo definisce: “Spunto originale, romanzo allo stesso tempo sensibile e duro”.
Ivan Crico
Il link alla recensione su Fissando in volto il gelo: https://bitly.ws/38rUY