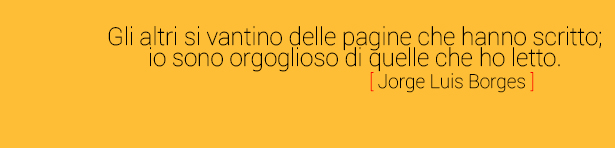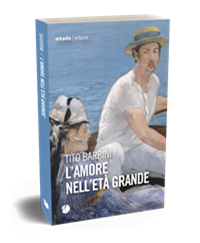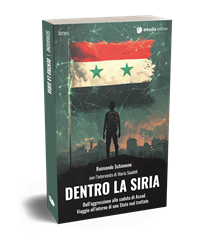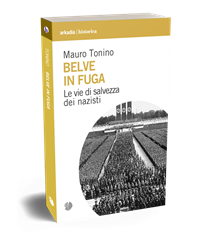Anna di Cagno: «Per me l’amicizia è pari all’ossigeno»
La giornalista ci racconta L’anno della Garuffa (Arkadia) candidato al premio Strega. Un romanzo che scava nelle verità taciute, parla degli anni di Piombo e affronta la ricerca della felicità
Ci sono anni che segnano la storia e anni che segnano le persone. Il 1978 è stato entrambi. L’Italia piomba nell’incubo con il rapimento di Aldo Moro, ma da qualche parte, in una città del Sud senza nome, un altro rapimento scuote un mondo fatto di facciate rispettabili e segreti inconfessabili. A raccontarlo è Monica, tredici anni, che osserva gli adulti e cerca di decifrarli con la lucidità disarmante di chi sta ancora crescendo. L’anno della Garuffa (Arkadia Editore) di Anna Di Cagno – giornalista, scrittrice e osservatrice attenta delle dinamiche sociali e umane – è più di un romanzo di formazione: è uno specchio impietoso di un’epoca in cui moralità e illegalità si confondono, dove il contrabbando è un male necessario e la verità è un lusso che pochi possono permettersi. Con una scrittura incisiva, l’autrice ci trascina tra i chiaroscuri di un’Italia contraddittoria, guidandoci attraverso gli occhi di una ragazzina che, nel tentativo di capire il mondo, finisce per capire se stessa. Un libro intenso e coraggioso che ha ottenuto un importante riconoscimento: è candidato al Premio Strega 2024.
Intervista Anna Di Cagno, autrice del libro “L’anno della Garuffa”
La tua protagonista, Monica, osserva gli adulti con una lucidità disarmante. Cosa ti ha affascinato nel raccontare il mondo attraverso lo sguardo di un’adolescente?
«L’idea che il bisogno di avere una “legge morale” è un’urgenza a quell’età. È quello il periodo in cui ci si forma come adulti, si è disposti a credere in qualcosa, ad avere degli ideali o dei sogni, e il contesto che hai intorno può fare la differenza».
Nel libro il rapimento di Aldo Moro e quello del piccolo Luca Barnaba si intrecciano in un parallelismo potente. Cosa volevi raccontare attraverso questo accostamento?
«Che i grandi eventi hanno sempre un corrispettivo “piccolo”, che anche dove gli Anni di Piombo non sono arrivati, la fiducia nel mondo dei “grandi” si è persa».
Il titolo, L’anno della Garuffa, richiama un colpo del biliardo italiano, un tiro difficile e imprevedibile. Come si collega questa metafora alla storia?
«Il biliardo è l’esempio classico che i professori usano a scuola per spiegare il principio di causa-effetto, è quindi il gioco logico per eccellenza. Ma è un gioco, e quindi come la vita ti devi aspettare tiri a effetto che invertono l’ordine delle cose. Monica lo capisce guardando come si comportano gli adulti che non sempre seguono questa legge della fisica».
Tra le pagine emerge un Sud Italia “minore” ma vivo e contraddittorio – anche se la città di Bari non è mai nominata – e ci si confronta con un mondo adulto corrotto, dove il contrabbando è visto come un “crimine bianco” e le menzogne sono all’ordine del giorno. È un ritratto di un’epoca passata o pensi che certi meccanismi siano ancora attuali?
«Credo che questo Sud “minore” oggi sia più specchio del tempo di ieri. Se la città che racconto nel romanzo ha come fragilità proprio quella di non essere abbastanza borghese, di non avere un ceto medio forte a far da filtro tra miseria e nobiltà, per citare Eduardo, oggi stiamo assistendo a qualcosa di simile: i ceti medi stanno perdendo ruolo e visibilità. E questo ricrea, sotto altre vesti, un’analoga polarizzazione».
Tra le altre protagoniste c’è la giornalista Maria Grazia che, come Monica, continua a fare domande scomode. Quanto c’è di autobiografico in questo personaggio?
«Molto poco, per fortuna. Maria Grazia comincia la sua carriera in un quotidiano dove è quotidianamente maltrattata da un caporedattore maschio e patriarcale, io ho cominciato in periodico, Cosmpolitan, sotto la guida di Patrizia Pontremoli e Franca Rossi, due donne meravigliose che hanno sempre creduto in me».
Le Pillole della Felicità, di cui si parla nel libro, sono solo un simbolo dell’ipocrisia degli adulti o rappresentano qualcosa di più profondo?
«Entrambe le cose. Sono il simbolo di qualcosa che non si può avere prendendo una scorciatoia, ma che richiede impegno e fatica (non c’è nulla di più faticoso della conquista della felicità) che diventa il simbolo per descrivere un mondo di adulti privilegiati, annoiati e viziati che circondano la giovane protagonista».
«Hai inserito nel romanzo espressioni dialettali e modi di dire del Sud. Quanto è stato importante per te rendere l’autenticità linguistica dei personaggi?
«In realtà non ho usato il dialetto, ma strutture sintattiche e grammaticali della mia terra origine che ritenevo fondamentali per ancorare nella concretezza i personaggi più belli del romanzo (la coppia di personale di servizio che vive in casa di Monica). Dire “ti esco le mozzarelle dal frigo” significa infrangere una regola della grammatica italiana ma, al contempo, non sapere di usare un francesismo!».
La moda e i marchi di quegli anni – Fiorucci, Wrangler – emergono nel romanzo quasi come simboli di identità e appartenenza. Che ruolo hanno nel definire i personaggi e il contesto sociale?
«La moda per teen-ager è nata in quegli anni grazie al genio di Elio Fiorucci: l’uomo che ha liberato tutte le bambine dai vestitini a punto smock e dalle orride scarpe a occhio di bue.
È stata una rivoluzione colorata e allegra, non poteva mancare nello scenario grigio e freddo degli Anni di Piombo».
Monica, alla fine, capisce di dover cambiare vita, di doversi allontanare per trovare la sua strada. È una scelta che trovi ancora attuale per molte ragazze di oggi?
«Allontanarsi dal proprio ambiente per capire meglio il mondo è per me attuale da sempre. Oggi però, forse, i ragazzi, e i genitori, sono più spaventati e si crea l’illusione che siano i social a farti scoprire realtà diverse e/o a darti l’opportunità di cambiare vita».
Come pensi che il tuo romanzo possa parlare ai lettori più giovani, che non hanno vissuto quegli anni turbolenti ma possono riconoscersi nelle sfide della protagonista?
«Io spero che possa servire innanzitutto a ricordare: abbiamo un passato recente di violenza e tensioni sociali terribili, il Terrorismo è stata una guerra civile in buona parte del nostro Paese. Io ricordo una prima adolescenza in cui la politica era importante: in casa, a scuola, in televisione. Oggi è diventata spettacolo e questo è un impoverimento per tutti. Poi le sfide di Monica sono quelle di qualsiasi adolescente dalla notte dei tempi: come si fa a diventare grande?».
Il viaggio, sia fisico che interiore, è un tema importante nel romanzo. Monica sente di dover andare via, di dover cercare la sua strada altrove. Cosa rappresenta per te il viaggio, e quanto conta nel percorso di crescita di un personaggio?
«Anche nel mio precedente romanzo dedicato a Gala Eluard Dalì (Morellini Editore) la protagonista fa un viaggio che diventa un percorso di crescita ed emancipazione. Quindi direi che per me quella del viaggio è una costante narrativa, sicuramente perché è una dimensione che considero fondamentale nella vita. Viaggiare ti cambia, inspessisce il tuo sguardo, ti mette alla prova, ti aiuta a dare la giusta misura alle tue idee».
Le amicizie femminili hanno un ruolo cruciale nel libro: tra alleanze, tradimenti e legami profondi, Monica e le donne che incontra si influenzano a vicenda. Cosa volevi raccontare sul mondo delle amicizie tra ragazze?
«Per me l’amicizia è pari all’ossigeno: non riesco a immaginare come si possa vivere, crescere, evolvere senza un’amica. L’amicizia è la prima forma d’amore che provi per qualcuno che non appartiene alla tua famiglia, ed è un sentimento unico perché si nutre di libertà, include altri rapporti e spesso li mescola creando innesti meravigliosi. Come si dice: gli amici dei miei amici sono amici… Credo sia l’unico sentimento che può legittimamente aspirare all’eternità».
Hai ottenuto la candidatura al Premio Strega. Cosa significa per te questa candidatura?
«Per me è già un premio. Un riconoscimento importante del lavoro che ho fatto, e la conferma di una cosa in cui credo profondamente: “La catena della stima delle donne”, ci sono arrivata tramite un passaparola da una donna all’altra che mi ha portato nelle mani di una donna – Ilaria Catastini – che ha apprezzato il mio romanzo tanto da proporlo».
Infine, c’è un personaggio del presente o del passato con cui vorresti partire? E dove vorresti andare?
«Vorrei parlare de L’anno della Garuffa con mia madre, perché è grazie a lei e alla sua passione per la politica e la cultura se ho un ricordo così nitido di quell’epoca. E poi vorrei andare in Sardegna, per scoprire una terra che conosco molto poco e che mi affascina».
Cosa non manca mai nella tua valigia?
«Un libro e una moka elettrica».
Isa Grassano
L’intervista su Amiche si parte!?