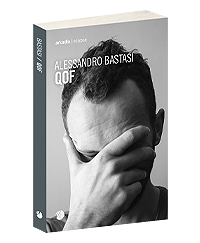Quelli che restano
L’Unione Sarda
8 novembre 2014
Dall’altra parte delle sbarre. Io, poliziotta penitenziaria
In “Quelli che restano” una giornata con una donna agente: il malessere di chi sorveglia e di chi è sorvegliato
Il carcere ha sempre rappresentato una miniera di storie da romanzo. “Quelli che restano”, l’ultimo libro di Paola Musa pubblicato da Arkadia, racconta l’umanità reclusa da un punto di vista nuovo e originale. Non è quello di chi è condannato a scontare la pena. È invece la prospettiva di un’agente di polizia penitenziaria, Elena, che condivide col marito la fatica e l’alienazione provocate da una professione scelta non per vocazione, ma per le opportunità offerte dal posto fisso. Dopo aver calcato «sulla testa un berretto azzurro al posto del cielo» ed essere sprofondata nell’abisso della sofferenza e dell’incomunicabilità, la protagonista – e con lei i personaggi che ne condividono la condizione – sente franare solidità e certezze e quindi traballare la vita familiare. Le speranze sopravvivono soltanto nella purezza dell’animo dell’unico figlio, ultimo spiraglio nel tentativo di giungere alla salvezza. Nel lavoro di autoanalisi, filo rosso di una narrazione che si svolge nell’arco di una giornata, non c’è disprezzo nei confronti dei detenuti. Si coglie invece un processo di identificazione che accomuna la sorte del servitore dello Stato a quella di coloro che, dietro le sbarre, sono affidati in maniera illusoria e ingannevole a un percorso di redenzione che invece è irrealizzabile. Il carcere diventa piuttosto un ammasso di esistenze, un cumulo dentro cui è difficile distinguere singole biografie. In questo luogo, «canile senza dignità» in cui «tutto si ripete e dove niente è mai uguale» anche gli agenti della polizia penitenziaria scontano la loro misura di pena. Elena, che vigila sulle detenute e sperimenta l’umiliazione di femminilità e maternità, si sente costretta a ripensare alla sua vita come se trascorresse «in un girone infernale, senza vita». Il motto “Vigilando, redimere” o la preghiera del poli- ziotto penitenziario, che riecheggiano dietro la narrazione ispirando senso del dovere, misericordia e fraternità, servono a vestire di inutile e deformante solennità una routine fatta di grettezza e abbrutimento. Sono solo rari gli aneliti di compassione. Tra le sbarre risuona il giudizio inclemente del mondo esterno che non risparmia nessuno. «Così come per certa gente tutti i preti sono pedofili – dice la protagonista – i cosiddetti secondini sono tutti aguzzini». Il romanzo quindi, oltre che raccontare storie individuali di sofferenza e alienazione, si fa strumento di denuncia nei confronti di un sistema che calpesta, schiaccia e stritola esistenze senza alcun distinguo. Tra le pagine di “Quelli che restano” c’è tutta l’attualità di problemi che l’opinione pubblica spesso ignora. Percepisce solo le manifestazioni più eclatanti, come il caso Cucchi o i ripetuti suicidi di guardie carcerarie. Trascura però tante altre emergenze: il sovraffollamento, la penuria del personale, l’incapacità di cogliere i bisogni dei detenuti stranieri o la necessità di madri e figli di stare insieme anche nel tempo della pena. Non c’è rieducazione, dietro le sbarre. «Raramente vedo qualche cambiamento – riflette Elena – non perché non ci sia voglia di pentirsi, ma perché il mondo fuori non cambia, propone i mede- simi percorsi, nelle stesse strade, con le stesse persone che in quelle strade t’incatenano». Terribile quindi la deriva: «Il degrado sociale diventa un circolo vizioso e l’uomo, si sa, è un animale che si abitua a tutto, anche alla cattività».
(Manuela Arca)