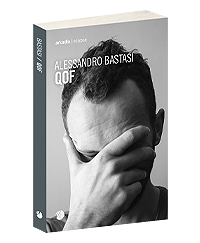N.B. Un teppista di successo
LA GLORIA CHE PASSÒ
Gli storici non sanno resistere alla tentazione di presentare i protagonisti della Storia come semidei che fin dalla nascita conoscono il loro destino e gli vanno incontro senza incertezze, a passo di marcia. Non è affatto così. Per fare la Storia bisogna essere avventurieri: gente che baratta gli ideali con il successo, che prende vie traverse, che intriga, bara, tradisce. E quando rischia, trema di paura.
Napoleone ne è un perfetto esempio: generale audace, politico dalle vedute limitate, esordì come rivoluzionario e si convertì in arrampicatore sociale per raggiungere il potere assoluto. Il suo unico scopo, al quale sacrificò ogni altra prospettiva, fu il successo personale.
Per capire che uomo fosse non dobbiamo lasciarci abbagliare dalle sue vittorie. Conviene piuttosto osservarlo all’opera quando era sconosciuto, quando puntava sui cavalli sbagliati, quando prendeva iniziative peregrine e vedeva franare le sue speranze una dopo l’altra.
Il ritratto che ne vien fuori non è quello di un superuomo o di un eroe. Semmai, è quello di un teppista sempre pronto a correre rischi. In combattimento, a volte si mostrò coraggioso, a volte codardo: nei momenti di sconforto, di paura, di indecisione, il futuro imperatore scadeva al livello dei comuni mortali.
Non fu soltanto Manzoni a chiedersi se quella di Napoleone fosse stata “vera gloria”: fra i suoi contemporanei se lo domandarono in tanti.
1
NABUGLIÒ
L’autunno era agli sgoccioli. Il sole usciva tardi da dietro le montagne e affondava presto nel mare. Eppure la costa occidentale della Corsica continuava a profumare di mirto e di arbusti selvatici. In quell’anno 1778, dicembre era cominciato con un libeccio che portava nuvole e pioggia intermittente. Poi il vento era caduto e il sole era tornato a farsi strada fra le nubi.
Nel primo giorno di tempo sereno, alle tre del pomeriggio, quando le ombre degli alberi cominciavano ad allungarsi verso oriente, una banda di ragazzini scalzi, con i capelli arruffati e le camicie sporche di fango, iniziò a dirigersi in ordine sparso verso l’obiettivo. Si erano armati di fionde e avevano scelto sulla spiaggia i sassi levigati dalla risacca. Seguivano un tipetto manesco che aveva soltanto nove anni e una statura inferiore alla media, ma dimostrava di possedere una certa personalità.
Il piano consisteva nel sorprendere i cavalli della guarnigione al momento dell’abbeverata, farli imbizzarrire fiondando sassate sui posteriori, farne fuggire la maggior parte su verso i monti e appiedare la cavalleria francese.
L’azione, anche se fosse riuscita, avrebbe procurato solo qualche fastidio agli uomini del conte di Marbeuf: i cavalli sarebbero stati ricuperati in un paio d’ore al massimo. Tutt’al più se ne sarebbero persi un paio, ammesso e non concesso che un contadino avesse avuto il fegato di catturarli. Ma questo non importava alla banda. Il valore dell’operazione stava nel riaffermare che i Corsi non erano mai stati genovesi e non volevano diventare francesi: erano Corsi e basta.
Il colpo fallì prima che fosse scagliato un solo sasso. Ma, se non altro, il giovane condottiero imparò che l’arte della guerra non si riduce a tattica e strategia: ci sono mille altri fattori che un comandante deve tenere nel debito conto. Nella sua futura carriera avrebbe messo in pratica la lezione. Per il momento aveva ancora tutto da imparare.
«Tu», ordinò a uno spilungone che aveva tre anni più di lui, «sali su quell’albero e facci da vedetta.»
Avrebbe fatto meglio a usare un tono meno imperioso. Oppure avrebbe dovuto scegliere un tipo più sottomesso. Quel perticone era lì per divertirsi con la fionda e non ci teneva affatto ad appollaiarsi in cima a un albero: lasciò cadere lo sguardo dall’alto in basso e replicò: «Vacci tu! Chi ti credi di essere per dare ordini?»
Il piccolo capitano diventò rosso fino alla radice dei capelli.
«Sali sull’albero! Sono io che comando!»
«Ma va’ a quel paese, Nabuglione! Con un nome così, che cavolo vuoi comandare?»
La risata scoppiò come un rullo di tamburi. Il comandante ragazzino rimase interdetto. Tutti i componenti della banda presero a strillare: «Nabugliò! Nabugliò! Nabugliò!»
Ruggendo di rabbia il piccoletto si scagliò contro l’insubordinato. «Ti faccio vedere io!»
Lo prese a pugni. L’altro rispose. Lui insistette. Per ogni pugno che riusciva a piazzare ne doveva incassare due, eppure continuava ad attaccare. Quando capì che i cazzotti dello spilungone erano più pesanti dei suoi fece un passo indietro, abbassò la testa e caricò colpendo l’avversario con una zuccata.
Rotolarono a terra aggrappati uno all’altro, mordendo, scalciando, graffiando. Ma quando “Nabugliò” riuscì finalmente a montare sopra al rivale, si sentì sollevare da una mano che l’aveva agguantato per la collottola e tirava su, impedendogli di farla finita con il ribelle.
«A casa vostra tutti quanti!», gridò l’avvocato Carlo Buonaparte ai cinque o sei curiosi che ancora non se l’erano data a gambe, e che non si fecero ripetere l’invito. Lo spilungone ammutinato si rialzò, prese atto della situazione, girò sui tacchi e se ne andò con calma, come se l’avesse avuta vinta lui.
Senza mollare la collottola del figlio il signor padre pronunciò il suo verdetto.
«Sono stufo di vederti fare a botte con tutti i lazzaroni della zona. Cosa vuoi diventare, un bandito? Per punizione stasera reciterai a memoria i primi cinquanta versi dell’Andromaque di Racine e se non li avrai imparati bene andrai a letto senza cena! Adesso fila a casa.»
Napoleone non replicò. Si avviò lungo il sentiero rimuginando sull’accaduto. Il rospo era duro da ingoiare, ma aveva imparato da tempo che una punizione non si discute: si paga e si passa oltre. Un giorno sarebbe stato lui a comandare.
Però, accidenti, una poesia francese! Cinquanta versi nella lingua dei nemici, quella lingua odiosa, piena di suoni nasali e di lettere che non si pronunciano. E quel Racine, sdolcinato come il rosolio! Come mai il signor padre aveva scelto una punizione così strana?
***
Qualche ora più tardi, davanti alla famiglia riunita a tavola, Napoleone recitò i cinquanta versi sotto lo sguardo intermittente del padre che controllava sul libro. Giuseppe, il fratello maggiore, ascoltava con gli occhi bassi. Elisa faceva finta di avere qualcosa da fare in cucina. Il piccolo Luciano si dimenava sulla sedia senza capire. Mamma Letizia e la balia si prendevano cura di Luigi, nato da pochi giorni.
Non andò tutto liscio: la pronuncia del ragazzo era orrenda; un paio di volte incespicò sulle parole che non ricordava e il padre intervenne con fare burbero a correggerlo. Ma, insomma, la punizione era stata accettata e diligentemente assolta. L’avvocato Carlo Buonaparte chiuse il libro e sedette a tavola.
Ciononostante, l’atmosfera non si rasserenò. Giuseppe, Napoleone e persino Luciano a turno guardavano la mamma che taceva e aveva l’aria più triste che mai, poi si guardavano l’un l’altro e sembrava che domandassero: “Cos’altro hai combinato?”.
Il signor padre concluse il pasto sbucciando l’ultimo fico della stagione. Poi respinse il piatto, tirò il fiato e puntò due occhi seri sui figli maggiori.
«Giuseppe e Napoleone», disse in tono di comando, «avete raggiunto l’età in cui bisogna stabilire cosa farete nella vita. Vostra madre e io abbiamo deciso per Giuseppe la carriera ecclesiastica e per Napoleone la carriera militare. Passerete qualche mese in collegio ad Autun. Imparerete a parlare francese e a comportarvi in società. Per Giuseppe, dopo il seminario, il conte di Marbeuf ha promesso l’interessamento del vescovo suo nipote. Napoleone avrà una borsa di studio alla Scuola Militare di Brienne. Il Parlamento riprende le sessioni e la settimana prossima dovrò tornare a Versailles. Voi verrete con me: il viaggio è pagato e ne approfitteremo per passare da Autun. Usate i prossimi giorni per studiare la lingua del paese dove vivrete nei prossimi anni.»
***
Lasciare la Corsica! Napoleone si rigirò nel letto. Andare in Francia e restarci per chissà quanto tempo, da solo, prima in un collegio e poi in una scuola militare. Che vita lo aspettava lassù in mezzo ai nemici? L’avrebbero picchiato, rinchiuso in cella, in punizione permanente? Avrebbe dovuto obbedire per tutta la vita? Ah, questo proprio no! Ripensò all’insolente cretino col quale si era azzuffato nel pomeriggio: glielo avrebbe fatto vedere lui se con un nome come Napoleone non si poteva comandare.
I Buonaparte non si potevano chiamare ricchi, ma ad Ajaccio avevano proprietà, mezzadri, affittuari e famigli che dipendevano da loro. Erano un clan influente e rispettato, come i Peraldi e i Pozzo di Borgo. Però i francesi non dimenticavano che l’avvocato Carlo Buonaparte era stato un luogotenente di Pasquale Paoli, che con lui aveva combattuto per la libertà della Corsica e che solo dopo la sconfitta di Ponte Nuovo si era avvicinato ai vincitori.
Paoli si era messo in salvo in Inghilterra e tutti i Corsi sapevano che, non appena la situazione avesse fatto intravedere una speranza concreta, il Babbu di a Patria avrebbe rialzato la bandiera con la testa di moro. Già sessant’anni prima il padre di Pasquale Paoli aveva capitanato la rivolta contro Genova. All’epoca, i Genovesi non avevano trovato di meglio che chiamare in aiuto i Francesi, e i patrioti avevano dovuto prendere la via dell’esilio. Ma in seguito Genova aveva avuto guai con gli Austriaci e Pasquale Paoli era rientrato in patria. Aveva proclamato la Nazione Corsa, con tanto di Costituzione, battuto moneta, armato un esercito e una flotta. E la repubblica genovese era tornata a chiedere aiuto alla Francia.
Napoleone si dimenò nel letto e morse il cuscino per soffocare un ruggito: per pochi anni aveva mancato l’avventura più sfolgorante in tutta la storia patria! Eppure suo padre, che quell’avventura l’aveva vissuta, scuoteva la testa: diceva che ci può anche essere gloria in una sconfitta ma, in fin dei conti, un fallimento è un fallimento e basta.
Fatto sta che la Francia aveva presentato una fattura astronomica e Genova aveva ceduto al re (non alla Francia, ma a Luigi XV personalmente) la proprietà dell’isola in cambio della cancellazione del debito. Il 9 maggio 1769 le truppe corse erano state sconfitte dall’artiglieria francese a Ponte Nuovo. In quella sfortunata battaglia Carlo Buonaparte e Carlo Saliceti erano stati aiutanti di campo di Paoli.
Dopo la disfatta, il Babbo era fuggito in Inghilterra. Ma l’avvocato Buonaparte non poteva fare altrettanto: aveva moglie, figli e responsabilità. Si era integrato nel nuovo ordine ed era stato eletto fra i rappresentanti della nobiltà di Ajaccio al parlamento di Versailles.
Chissà che fine aveva fatto Saliceti. Nei discorsi che si facevano a tavola quando si riunivano il signor padre, lo zio Fesch e l’arcidiacono Luciano, Napoleone aveva sentito parlare di un Antonio Saliceti, avvocato a Bastia. Sarebbe stato bello conoscerlo, parlare con lui, confrontare storie di famiglia e speranze per il futuro.
Ma no: a Bastia ci sarebbe andato solo per imbarcarsi, per far vela verso l’odiatissima Francia, dove avrebbe dovuto rimanere per anni. Forse per sempre.
***
Dopo aver valicato le montagne a dorso di mulo, i tre Buonaparte passarono la notte in una locanda schifosa dormendo su materassi stesi per terra. Il giorno seguente lasciarono Bastia per Marsiglia, dove arrivarono il giorno di Natale. Il primo gennaio 1779, dopo aver viaggiato per mare, per terra e in battello lungo fiumi e canali, arrivarono ad Autun, una cittadina della Borgogna che non aveva proprio niente di speciale.
La campagna era coperta di neve e faceva freddo. Il signor padre se ne andò quasi subito lasciando i ragazzi soli con le raccomandazioni dette e ripetute nelle ultime settimane. Napoleone si guardò attorno: c’era da lasciarsi morire o da schiattare di rabbia. Non aveva sottomano una vittima su cui sfogarsi e scaricò la sua furia su se stesso: si dedicò a imparare il francese con il fervore disperato di chi ne fa una questione di vita o di morte.
Catapultato a nove anni e mezzo di età in un paese straniero senza altra compagnia che quella del fratello maggiore, nel freddo di un inverno continentale, costretto a mangiare piatti indigesti cotti nel burro e a guardare fuori dalla finestra un cielo perennemente grigio, doveva ricominciare tutto da zero: imparare a leggere, scrivere e conversare nella lingua del posto.
Ce la fece, e per la prima volta si rese conto di quanto fosse forte la sua volontà. Dominare gli altri dà soddisfazione, dominare se stessi dà consapevolezza. In tre mesi arrivò a padroneggiare la lingua quel tanto che bastava per conversare con una certa scioltezza e per scrivere temi e riassunti. Imparò il francese, ma non dimenticò mai la lingua corsa.
Da quando era sbarcato sul continente si era imposto di tenere nascoste le sue emozioni, di non dare ai Francesi la soddisfazione di vederle riflesse sul suo viso o nei suoi discorsi. Tenne fede anche a questo proposito.
***
Il trasferimento dal collegio di Autun alla scuola di Brienne avrebbe meritato un minimo di interessamento paterno; ma l’avvocato Carlo Buonaparte non si fece vivo, impegnato com’era a coltivare amicizie nei caffè e nelle alcove di Versailles. Si limitò a pregare un abate di accompagnare Napoleone a Brienne.
Al momento della separazione Giuseppe scoppiò a piangere. Napoleone cercò di fare il duro, ma una lacrima scappò anche a lui.
Nel maggio 1779, sulla scorta di certificati che attestavano i suoi quattro quarti di nobiltà, il teppista di Ajaccio, nobile di diritto e futuro sanculotto, entrò nella scuola militare di Brienne.