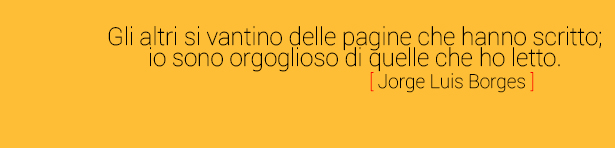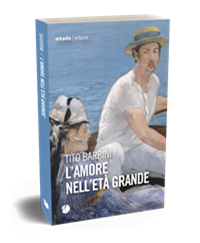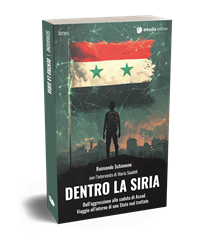L’ambasciatore delle foreste
Sarà che cominciare è la cosa più difficile e a forza di ragionarci sopra viene da rovesciare tutto e piazzare la fine dove dovrebbe stare l’inizio. Sarà che a ben guardare non c’è un inizio o una fine, non c’è mai contrariamente a ogni evidenza, nemmeno per gli uomini, che nascono e poi muoiono, però devono sempre fare i conti con un prima e perfino con un dopo. Tanto vale allora prendere un filo tra i tanti, tirare e vedere cosa succede.
O piuttosto sarà che sono semplicemente confuso, perché ora dovrei partire con un nome e un cognome, due date, qualche parola giusto per spiegarvi: quest’uomo ha fatto questo e quest’altro. Solo che no, non mi convince. Sono sicuro che non piacerebbe nemmeno a voi, non dico se vi capitasse di raccontare una storia, ma di essere voi l’oggetto della storia.
Pensateci: tra un secolo sbuca un sedicente giornalista tipo il sottoscritto, in realtà un guastafeste. Per qualche singolare ragione manifesta l’intenzione di sottrarvi all’immeritato oblio. Però tutto quello che è capace di fare, giusto per provare a spiegare, è disporre un nome e un cognome, due date e qualche parola.
Ovvero l’occorrente per una lapide. Qualcosa tipo
GEORGE PERKINS MARSH 1801-1882
AMBASCIATORE, INTELLETTUALE, ECOLOGISTA
Che poi, più che un modo di spiegare mi pare un modo per procurarsi un alibi: ecco a voi, di lui vi racconterò nel prosieguo. E abbiate pazienza, qualcosa verrà fuori.
Meno male che non posso cavarmela così. Sarei tentato di specificare subito che George Perkins Marsh di molti onori e oneri dell’ambasciatore avrebbe fatto volentieri a meno, che più che un intellettuale era un autodidatta di genio, che di ecologia ha cominciato a occuparsene prima che lo stesso termine ecologia spuntasse fuori.
Invece vorrei dire, semplicemente, che è stato uno di quegli americani che sembrano perfetti per un film, vai a sapere perché non ci hanno mai provato.
Però questo non va bene per una lapide. O per una voce di Wikipedia. E nemmeno per cominciare questa storia.
Così sono ancora qui, davanti al mio computer, un file aperto da un pezzo e nemmeno un rigo che valga la pena. Solo una pioggerella di parole. Digito, cancello, digito, cancello di nuovo. Fisso lo schermo, scuoto la testa, mi alzo e mi rimetto a sedere.
Prime avvisaglie della sindrome dello scrittore che non scrive. E se uscissi?
Una passeggiata per Firenze: la mia città e anche la città che per diversi anni sarà di George Perkins Marsh. Le storie respirano l’aria dei luoghi e c’è almeno un palazzo, lo so, che forse potrà darmi lo spunto giusto. Quante volte ci sono passato sotto, prima di imbattermi in questo nome.
Però sospetto sia un modo per prendere tempo. O ad- dirittura un pretesto per puntare al pub sotto casa, dove le birre a volte paiono destare profondità da romanzo russo. Mi trattengo.
E allora che faccio, comincio come cominciano le biografie?
I genitori, il luogo di nascita, i primi studi, gli affetti familiari. Più la domanda che si distende appena sotto la superficie: cos’è che fa di un uomo quel che è?
Forse meglio cominciare da dove ho cominciato io. La volta che George Perkins Marsh fece capolino nei miei giorni, non invitato.
Fu quel mio collega che da sempre si occupava di parchi, funzionario all’ambiente nell’amministrazione per cui all’epoca io mi occupavo dell’ufficio stampa. Lui andava in giro per le foreste, io dovevo contentarmi delle dichiarazioni degli assessori.
Prima di ritirarsi in pensione mi accennò a un uomo di un altro secolo che era stato importante per le foreste di qua e di là dall’Atlantico. Quindi mi consegnò un libro, raccomandandosi: però lo rivoglio indietro. E io glielo restituii, la settimana dopo. Senza averne letto nemmeno un rigo.
Solo per scrupolo feci le fotocopie, un monte di fotocopie. Le seppellii in un baule. Non mi ero ancora messo a cercare storie nelle pieghe della Storia, con l’intenzione di raccontarle.
Da allora, sì, sono passati diversi anni e diversi libri: e di storie, mi sa, ne ho raccontate anche troppe.
Allora: comincio così?
O comincio senza davvero cominciare?
Tanto in realtà è quello che sto già facendo. Digito, cancello, digito. Ora vado anche via, intendo via da questo file. Ragnatela di pensieri che sono vicoli ciechi. Vorrei spreme- re qualcosa dal bianco intorno alle parole.
Mi tuffo su Internet, provo a cercare qualcosa su Google.
Perkins di George Perkins Marsh, per esempio: ce ne sono un monte su Wikipedia. Gente di sport, soprattutto, basket e pugilato. Più un cantante, un paio di attori, un teologo inglese. Un paio di contee, una in Nebraska, l’altra in Sud Dakota. Un’azienda di motori diesel.
Molti meno ce ne sono di Marsh, che però significa anche palude. Basta volgere la emme in minuscolo e non è più solo un cognome.
Palude, associazione strana con un uomo che nella vita ha amato soprattutto i monti: e le paludi, si sa, stanno in basso, dove le acque si raccolgono e ristagnano.
Palude, come la vita di un uomo che non c’è più. Comunque sia qualcosa si raccoglie e ristagna. Fatti che sono ricordi, prima che con il tempo evaporino. Cosa ne rimane al fondo?
Palude, sì, ci sta per George Perkins Marsh.
Senz’altro se ne sarà interessato. Lui, l’uomo che si occupava della natura. Che ragionava della terra che via via diventava più secca, sabbia dove una volta si rivoltavano le zolle.
Ecco, mi piace questo pensiero vagabondo sulla palude. Mi sta regalando qualcosa di simile a un titolo: l’uomo che si occupava della natura.
Non è ancora un inizio. Però è già quanto serve perché dalla lapide venga giù Perkins, venga giù Marsh e rimanga solo George.
Magari posso cominciare così. Chiamandolo George. Per provare a raccontare di un vivo, mica di un morto.
***
Però una parvenza d’ordine ci vuole. Dopo tre cartelle che giro a vuoto, qualcosa dovrò pure mettere in fila.
Tanto vale allora partire dai posti di George. Quelli dall’altro lato dell’oceano, intendo. Che non sono mai diventati i miei posti, benché sia una vita che mi dica: prima o poi ci andrò.
In effetti mi basta così, saperli un altrove possibile. Allo stesso modo delle distese di betulle in Siberia o delle cime innevate delle Ande. Me le tengo vicine e le accarezzo come un gatto che fa le fusa.
Il Vermont, dunque, che allo stesso modo della Louisiana deve il suo nome ai francesi. Traducetelo Monte Verde e non è la stessa cosa, richiama una ridente stazione climatica del mio Appennino, altro che America.
Grande più o meno come il Piemonte, con una popolazione che supera di poco Genova, il Vermont è il Vermont. Il quattordicesimo stato, il primo dopo le tredici colonie che si ribellarono agli Inglesi e dichiararono la loro indipendenza.
Il New England come ci si immagina. Questo è il Vermont che ho nella testa e presumo anche nel cuore. L’incendio delle foglie in autunno, le soffici coperte patchwork, l’uso e l’abuso di sciroppo d’acero.
Non la risacca e la salsedine, i fari e gli scogli sferzati dalle onde, nemmeno i celebri panini all’astice più maionese del Maine. Tra tutti gli Stati del New England il Vermont è l’unico che non si affaccia sull’Atlantico. E se vi piacciono le storie di mare lasciate perdere, perché di mare in queste pagine ne troverete poco. Quel poco, per di più, solo per- ché non se ne può fare a meno.
The Great Mountain State, appunto. Grande, prima ancora che verde. E su questo ci sarebbe qualcosa da dire, anzi, lo dirà lo stesso George.
Il Vermont e nel Vermont una cittadina che basta nominarla per saltare su. Ma guarda, Woodstock. Peccato non sia quella Woodstock, la Woodstock del Vermont. Niente a che vedere con il concerto dei concerti, altrimenti sarei già a ricamarci sopra. Come a voler scovare un senso alla singolare connessione tra George e Jimi, intendo Jimi Hendrix.
Invece niente. Woodstock, contea di Windsor, è solo una piccola cittadina. Una bella piccola cittadina se è vero che qualche anno fa un giornale l’ha dichiarata la più bella tra le piccole in tutti gli States.
È qui che nasce George, in questa cittadina che se è oggi è così figurarsi allora. Diciamo che ai tempi è poco più di un villaggio. Una cinquantina di case in legno raggruppate su un’ansa del fiume con un nome che sa di tribù indiana: Ottauquechee. Più diverse fattorie sparse nelle colline dei dintorni.
Potrebbe essere il set di un film in costume, qualcosa tipo La Lettera scarlatta, oppure L’ultimo dei Mohicani, dipende dai gusti.
In ogni caso c’è quanto serve: la scuola, l’emporio, il sellaio e il calzolaio, qualche mulino sulle sponde a monte, dove il fiume che più tardi si getterà nel Connecticut non si è ancora placato. Perfino un albergo di tutto rispetto, l’Eagle Hotel, che in assenza di alternative è il centro della vita cittadina. Qui si tengono le assemblee, qui mercanti e agricoltori si incontrano e concludono i loro affari, prima di godersi le specialità di merluzzo e l’acquavite di mele.
Questa è Woodstock, contea di Windsor, Vermont, nel primo inverno del nuovo secolo. L’Ottocento ha appena bussato alla porta e vai a sapere cosa ne sarà. Presto tutto cambierà veloce, più che nei secoli trascorsi. Gli uomini si sposteranno con cavalli a motore, si parleranno a distanza, si divertiranno con la proiezione di immagini in movimento, addirittura potranno alzarsi da terra e volare, sì, volare. A dirlo ora più che per profeti si passerebbe per matti.
Quanto a me, ora sono di qua e sono di là: all’inizio dell’Ottocento e insieme alla sua fine. Questo è il bello, quando pedini la vita di un uomo che appartiene a un’altra epoca. Puoi entrare dentro quella vita e allo stesso tempo guardare da fuori. Sei nel suo presente e insieme lo osservi dal futuro. Dal punto di vista di ciò che è stato dopo.
Che è assai di più che essere contemporaneamente in campo e in tribuna durante una partita di calcio. Conosci già il risultato. Effetto sorpresa modesto, però quante cose vengono fuori, col senno di poi.
Non sono riuscito a spiegarmi bene, mi sa. Però, ripeto, è questa la sensazione: sono sia all’inizio di quel secolo che alla sua fine, così come per la verità anche in questo mio secolo, che è un pezzo che è cominciato.
Vedo binari e strisce d’asfalto, parcheggi e grandi magazzini, distributori di benzina ed edifici pubblici con l’aria condizionata, vedo questo e anche molto altro, però poi faccio in modo che svanisca lasciando solo ciò che c’era prima. Molto di più in effetti è ciò che prima non c’era. Pare sia questo il progresso: muoversi dal più vuoto al più pieno.
Per me George è nato in un mondo che è anche un’idea di America, quella che mi sono fatto sui fumetti del Grande Blek. Ci sono trapper con cappelli di pelliccia e lunghi fucili ad avancarica, recinti per i cavalli e taverne fumose, strade di terra battuta.
La casa dei Marsh è un cottage sulla riva del fiume. Niente a che vedere con l’edificio di mattoni in cui si trasferiranno sei anni più tardi, ai piedi del monte Tom.
Tra i primi odori con cui George esplora il mondo ci deve essere quello del legno intorno. Odore buono, odore vivo.
Buon legno è anche quello che arde. Il primo inverno di vita è uno degli inverni più rigidi da un pezzo a questa parte. Nel camino c’è sempre qualche ciocco che regala tepore.
Magari è anche così che si semina gratitudine per i boschi. In attesa del raccolto.
***
Nei miei ragionamenti, ve ne siete accorti, non procedo mai bello dritto, nemmeno mi piace. I pensieri sono farfalle che sfuggono al retino della logica, se logica c’è. Dico e divago, divago e dico. C’è di peggio, comunque.
Però ordine per ordine dopo il luogo di nascita dovrei aggiungere qualcosa sulla famiglia. Così si fa e così provo a fare. Malgrado questo cielo azzurro fuori, il cielo di Firenze. Non c’è niente di più bello del cielo di Firenze, in giornate così. Anche George, penso, di tanto in tanto avrà sentito struggersi dentro, di fronte a questo spettacolo. Avrà sollevato gli occhi dalle sue carte, godendo di questa luce. Per cedere poi alla tentazione di una passeggiata. Magari sui lungarni, dove a volte tutto sembra costruito con la stessa materia dei sogni.
Però ecco il nonno paterno di George. Si chiama Joseph ed è del Connecticut, ovvero dell’America che guarda il mare, non dell’America che punta a ovest, quella delle foreste popolate da avventurieri, ma anche da solitari, dissidenti, liberi pensatori. Persona tutta di un pezzo, Joseph. Saldi principi e notevole senso degli affari. Si distingue per memoria e assennatezza, nonché per la cura nel vestire e nei modi. Dei dodici figli che mette al mondo l’ottavo, Charles, è il padre di George.
È lui che si trasferisce a Woodstock, dopo gli studi in legge, primo avvocato in questa cittadina. E non so a voi, ma a me viene in mente Gregory Peck, in Il buio oltre la siepe.
Il Vermont non è l’Alabama, figurarsi, però il ruolo è lo stesso, il legale che esercita lontano dalla metropoli, in una comunità dove tutti si conoscono. Nel bene e nel male. Anche male, certo, perché l’avvocato è come il medico, quando serve c’è un problema. Se gli affari vanno a gonfie vele, qualcosa significa.
Dopo una prima moglie morta di parto Charles si sposa con Susan, la figlia di un medico che per far quadrare i conti tiene a pensione studenti e alleva muli: a Woodstock, pare, ci sono meno problemi di salute che con la legge. A ogni modo Susan è una Perkins. E questo cognome George se lo porterà sempre dietro, assieme a quello del padre.
Ed è come in chimica, quando si ragiona su una sostanza composta e sulla formula che ne lega i diversi atomi. L’acqua, per esempio, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno.
Charles, ovvero gli incarichi pubblici di cui fa incetta, per la verità senza troppo ricercare i favori dei concittadini. L’intransigenza e l’arroganza di chi a pochi si sente inferiore una volta escluso Dio. E per quanto riguarda quest’ultimo, l’idea che più che un padre amorevole si tratti di un giudice, equo ma inflessibile.
Susan è di pasta diversa. Sarà per suo padre, non privo di qualche stravaganza, animato da quella curiosità che è un modo di declinare l’amore per la natura, si parli dell’elettricità delle rane come di qualche altro singolare fenomeno. In ogni caso persino l’ambiente più segnato dal rigore e dal conformismo sa sviluppare i suoi anticorpi. Susan non è una persona avara di calore.
Fosse davvero chimica, potrei dire che George è Susan più Charles, magari in parti diverse, per esempio due parti di Susan e una di Charles, come l’idrogeno e l’ossigeno, appunto.
Meno male non è chimica. Meno male ci sono domande che restano senza risposta, persino quando ci riguardano. Cos’è che ha fatto di noi quello che siamo? Quali e quante parti ci compongono?
Discendiamo da parole, gesti, sguardi. Siamo eredi di istanti che abbiamo vissuto e di cui a volte non siamo nemmeno consapevoli. O di cui diventiamo consapevoli solo da un certo punto in poi: e che almeno non sia troppo tardi.
Di questi anni George parlerà sempre poco, però un ricordo del padre se lo tiene stretto. Non riguarda le parole come sentenze, le allergie agli affetti, le rigidità appena di tanto in tanto scalfite dal dubbio e dal rimorso.
Riguarda il padre che lo porta in giro per i boschi.
Insieme a volte vanno sul Monte Tom, che in realtà è poco più di una collina nei pressi di casa, generoso chiamarlo monte. Con quel nome, poi, ideale per una invenzione di Walt Disney, se solo fosse già l’America di Walt Disney. Però anche in quell’altra America il Monte Tom può valere le Ande. O l’Himalaya.
È bello salire fino in cima, raccogliere il vento, abbracciare con un colpo d’occhio il panorama sotto. Riconoscere il verso di un gufo, cogliere il guizzo di uno scoiattolo.
George e suo padre, le prime esplorazioni.
E anch’io, alla stessa età: il babbo che mi accompagnava per i boschi. Poche volte, strappate ai suoi impegni e alla mia pigrizia, però ci sono state. Non me ne sono dimenticato.
Una mattina un serpente attraversò il sentiero davanti a noi. Sparì in un attimo, lasciando appena una traccia nella polvere. Forse non era nemmeno una vipera. Però schizzai indietro come una molla e non ci fu più verso di proseguire. Tornai indietro a cavalluccio, le braccia strette attorno al collo del babbo, una barchetta a vela ormeggiata in acque riparate.
Ricordarlo ora che tento di parlare di George se non altro mi aiuta a contenere l’imbarazzo. Come non sentirmi un intruso?
Così. Con la convinzione che occupandomi di un’altra vita in realtà mi occupo della mia. E viceversa.
Non mi lascio più sorprendere nel giardino che non è mio, oltre la staccionata. Minimo, anch’io ho lasciato aperto il cancello, perché altri entrino.
All’epoca di George non si rimane bambini a lungo. Mica come oggi, dove adulti forse non si diventa mai del tutto. Io, alla mia età, sono ancora alle prese con la sindrome di Peter Pan. Per George il tempo dei giochi si sta già esaurendo.
Però c’è questo babbo. Lo dico con affetto. Un babbo che lo accompagna per i boschi, su verso i crinali. Che gli indica le piante, le nomina, ne illustra le varietà.
Comincia così la storia dell’uomo che amerà gli alberi.
Alberi, scriverà un giorno, che saprà considerare persone, non cose. Più di quanto ci riesca io.