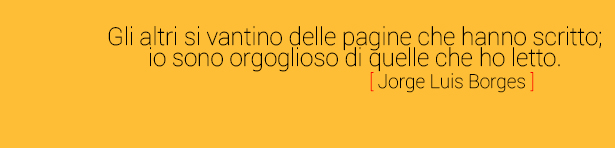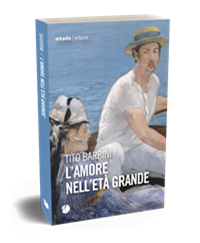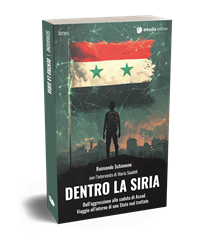“I giorni pari” su Letteralmentelive
Realtà e Fantasia nel Romanzo Italiano
I giorni pari di Maria Caterina Prezioso, Arkadia
Un racconto, che come spesso oggi fa accadere chi scrive, intreccia la realtà e la fantasia, e lo fa bene, con attenzione per i dettagli, quelli della nostra storia italiana. Tra la scalata e la caduta del fascismo, due donne, le loro famiglie: Sara ebrea, Silvana malata di tubercolosi. I fatti – che oggi assumono impressionante attualità alla luce della rilettura, spesso impietosamente banalizzante se non addirittura irrispettosa, dei drammi che molti cittadini del nostro paese hanno vissuto sulla propria pelle – sono visti e narrati internamente al contesto famigliare, con un taglio intimo che mi ha ricordato le opere di Natalia Ginzburg, dove, da dentro le stanze della vita quotidiana, assistiamo all’invadenza della storia nella traccia della vita. La lingua scelta è adatta ai contesti, l’uno medio-borghese l’altro popolare, in cui le due protagoniste si trovano ad agire, e qualche volta suona volutamente retrò con l’esplosione un po’ drammatica dei sentimenti, giovani e indomiti, di caratteri che si trovano del resto calati in un periodo di continui sconvolgimenti.
Sara è figlia di un farmacista ebreo “ingentilitosi” per non perdere tutto, all’uscita delle leggi raziali; un “gentile” è infatti una persona che si è fatta “arianizzare”, rinunciando al proprio culto. Una legge del Ministero degli Interni introdotta nel ’39 e usata in modo assai discutibile, tanto da poter essere accessibile solo a chi se la potesse “economicamente” permettere, consentiva di tornare a “vivere”, nel tessuto sociale dal quale i non ariani si vedevano esclusi. Tuttavia, gli altri membri della famiglia restavano “ebrei” e quindi, dovevano vivere in un cono d’ombra, che impedisse alla società di “accorgersi” di loro. Per questo Sara viene mandata via da Roma, è costretta ad abbandonare l’abitazione borghese dei genitori allo scoppio della guerra, e viene “accolta” da una famiglia di Sperlonga, pagata per spacciarla per una parente. Sarà la svolta del destino che cambierà tutta la sua vita, ma che non sopirà il suo senso di ricerca della giustizia. L’incontro con gli ideali dei partigiani, con gli intellettuali del “Manifesto di Ventotene”, la porterà a fare scelte che devieranno da quelle di una vita al “riparo” dal male, scelta dai i genitori, in buona fede, per lei. Silvana è figlia della borgata romana, delle case popolari dove il duce aveva trasferito il più indigente proletariato romano. Da suo padre, invalido della Prima Guerra Mondiale, ha avuto un’unica e sfortunata eredità: la tubercolosi. Sarà la malattia ad allontanare anche lei dal contesto famigliare, per entrare, giovanissima, al sanatorio Forlanini, dove il professor Fegiz (personaggio reale), luminare ebreo “imboscato” nel perimetro ospedaliero perché troppo bravo e utile alla medicina, la curerà, insieme alla popolazione di sfortunati che abitano una realtà drammaticamente parallela ai fatti della storia, quella della malattia. La sua vita sarà plasmata dal rapporto con il grande luminare che l’ha in cura, capace di apprezzare l’intelligenza emotiva della ragazza, la sua apertura verso la vita, la capacità di prendere in mano il destino, nonostante tutto. Le due protagoniste vivono, ciascuna per sé, una vita calata nel reale panorama dell’epoca più cupa dell’Italia, ed è scorrevole e appassionate il disegno finzionale che Maria Caterina Prezioso traccia, ponendole in parallelo, su binari che, solo leggendo il bel romanzo, sapremo se e come si toccano.
Anna Bertini
La recensione su Letteralmentelive