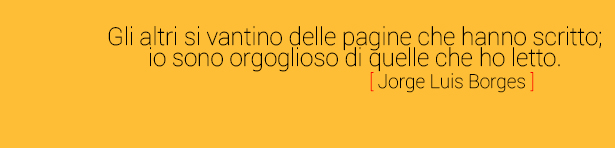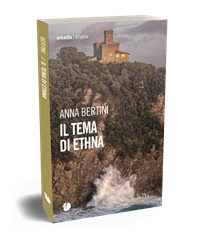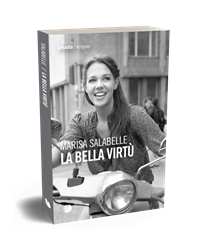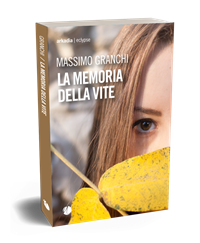“Grazia Deledda e il cibo” su City & City
Grazia Deledda e il Cibo nel libro di Giovanni Fancello e Sara Chessa
“Il cibo – assurge a elemento etnografico, antropologico, attraversa le preghiere, le imprecazioni, le poesie – diventa identità di una comunità ristretta ma universale nella sua elementarità” è questa la Sardegna che anima e pervade, Grazia Deledda e il Cibo da Omero ai giorni nostri, il libro di Giovanni Fancello e Sara Chessa, in libreria, edito da Arkadia Edizioni. Il libro è un racconto intenso, ricco di rimandi e citazioni di tutto ciò che è cibo nella prolifica produzione letteraria di Grazia Deledda, premio Nobel della letteratura nel 1926. Gli autori hanno riletto l’intera opera letteraria della scrittrice, partendo dalle prime novelle, arrivando sino ai romanzi pubblicati postumi, scoprendo che il cibo è un “personaggio” essenziale del narrare deleddiano. Il libro è un viaggio avvincente nella produzione agricola, nell’allevamento, negli usi, nelle abitudini, nelle contaminazioni culinarie di un’isola che è al centro del bacino del Mediterraneo. Non ci sono solo tavole imbandite, ma curiosità e aneddoti che sono la storia della gente di Sardegna. Grazia Deledda, donna della fine dell’Ottocento, descrive il cibo comune, quello di tutti i giorni: le zuppe di pane d’orzo, condite con formaggio filante, sos macarrones dalle diverse forme e nomi, fatti in casa insaporiti da un pesto di noci e pomodoro secco, la lattuga impreziosita con un filo di miele; ricette, preparazioni di una tradizione spesso dimenticata. E se la cucina sarda di tutti i giorni, può sembrare parca, a volte addirittura frugale, nei giorni solenni diventa regale. Grazia Deledda narra, che nei giorni di festa si sacrificavano le bestie dalle carni pregiate, come l’agnello, il cinghialetto, il maialetto e si cucinavano arrosto, irrorate di lardo fuso. Si faceva il pane e lo si decorava come un vero gioiello. Anche i dolci venivano preparati con ricercati e golosi ingredienti, perché sono, soprattutto loro a santificare le feste: s’aranzada, sas sevadas, sas tericas, sos coricheddos, sos papassinos. La tavola diventava simbolo di accoglienza, di condivisione e per il dì di festa si allungava ulteriormente e diventava luogo di socialità, di convivialità. Come sociali e condivisi erano i riti del fare il pane. Per più giorni le donne del vicinato si riunivano mettendo le mani in pasta, condividevano conoscenza, tempo e senso della vita, infornando carasau, poddine, pane de sapa e pane ammodicadu. Per non parlare del rito dell’uccisione del maiale che coinvolgeva un intero paese. Era una festa per grandi e piccoli; partecipare significava saziarsi e tramandare gesta che sanno di memoria preomerica, come quella di cucinare il sanguinaccio sulla viva fiamma. Alcuni di questi rituali rivivono pressoché intatti, ancora oggi in quella terra considerata antica e laboratorio antropologico incontaminato. Leggere le pagine di Grazia Deledda e il cibo, da Omero ai giorni nostri, è tuffarsi nella memoria di un popolo, è riscoprire le gesta, le abitudini dei Sardi. Sorprende invece, quanto sia ricco di storia, di contaminazioni e di analogie quel cibo ritenuto erroneamente arcigno e sconosciuto. Quanto sia simile e universalmente riconosciuto da tanta gente che popola il grande bacino del Mare Mediterraneo. E ben venga il libro di Fancello e di Chessa, perché oltre a dare la giusta dignità ai cibi dal sapore ancestrale, recupera e colloca in un preciso contesto ricette che si sarebbero perse e dimenticate.
Il link alla recensione su City & City: https://lc.cx/PbQBZu