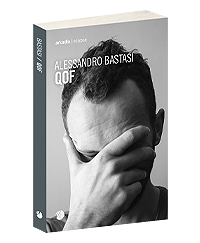Ed è già estate
Le chiese sono sempre fredde, anche d’estate, e sono buie, soprattutto al mattino quando si spengono le luci e gli altari perdono la voce. E sono sole: nel credo di gente inginocchiata che invoca la grazia o chiede il perdono. Gli anziani, votati al sacrificio e alla penitenza, le frequentano anche nei giorni senza celebrazione, in attesa di un miracolo. Paventano la morte.
Mi siedo tra quattro donne che dondolano il capo con i rosari intrecciati alle dita nodose nell’odore rarefatto dell’incenso. Guardiamo la Madonna incoronata: ha in braccio suo figlio, ignara del disegno divino. Lei, una madre forte, la Nostra Madre.
M’inginocchio, ascolto quei sussurri per imparare a pregare e rovisto nella memoria della mia fede ordinaria. Da bambina cantavo la religione nel coro di feste comandate in cui indossavo un vestito nuovo, mi pentivo e promettevo di fare da brava perché, se no, il diavolo mi avrebbe portato all’Inferno. Avevo paura, la stessa paura di adesso.
Guardo queste vecchie, ganci piegati dagli anni, grigie come i loro abiti. Ma camminano e lei non cammina, respirano e lei affanna, a mani giunte raccomandano a Dio i loro cari, lei ha le mani dolenti. Brutte streghe.
Mi vergogno della mia cattiveria e per contenerla esco dalla chiesa con un segno della croce bagnato d’acqua benedetta.
L’aria mi stordisce. È una giornata primaverile e mi fermo nel piazzale in cima alla scalinata che è un tutt’uno con il cielo e il mare.
Mi siedo sul primo gradino, la mia mente vaga. Mi rivedo seduta sullo stesso gradino accanto a lei che mi tiene stretta mentre babbo ci scatta una foto.
È bella. Ha i capelli raccolti e indossa gli occhiali da sole, ha l’eleganza di un’attrice prossima a ricevere un premio con quel suo tailleur che la fascia di una morbida femminilità lasciando appena scoperte le ginocchia perfette. Siamo in posa, io sorrido e lei è raggiante perché la Madonna di Bonaria mi ha salvata. Non so nulla della morte, vivo nei suoi occhi pieni di giovinezza.
Mi accendo una sigaretta e penso al voto che potrebbe farla tornare com’era. Lei lo aveva fatto per me, quando rischiavo di non superare la notte sotto una tenda d’ossigeno. Quale voto potrà avere l’importanza del suo? Forse dovrei smettere di fumare, forse dovrei andare a messa la domenica, digiunare…
Guardo il mare e mi tormenta l’idea che lei non potrà più sentire il rumore della risacca o la salsedine sulla pelle. Mi volto verso la statua della Madonna di Bonaria che impera nel cielo. La preghiera si fa supplica: «Lasciamela, non sono pronta.»
Prego perché io possa ancora vivere in lei.
Solo questo, e prometto di non fare più da cattiva. Sarò buona, non lo faccio più. Prometto.
Ho iniziato a leggere i suoi appunti con la smania di cogliere il senso d’ogni sua parola.
La grafia è mutevole; a volte è compressa e incalzante, a volte si fa incerta e stanca. Ma è comunque piena di lei, di me, di noi.
Leggo e sento la sua voce. Tocco i fogli uno a uno, li accarezzo: la tocco e l’accarezzo. Il tempo fugge, vorrei sapere, in fretta, e vado alle ultime pagine dove il piglio è più debole ma ancora sferzante.
Poi tra una riga e l’altra lo spazio si fa più grande sino alla pagina bianca: l’ultima pagina.
Ritorno indietro, al principio, per comprendere la fine e mai come prima d’ora l’ascolto.
Sono le sette del mattino e fa molto caldo.
Mi preparo per la mia passeggiata; mi infilo il costume e la maglia per coprire l’età. Mi avvio nella pace di questa mattina di agosto e arrivo in spiaggia senza nemmeno un pensiero. Respiro avidamente l’aria salmastra sotto il sole che già mi scalda. Il mare è increspato dalla brezza e si aggrappa al cielo ancora libero dalla calura. È un di- pinto che faccio mio e per fermarlo chiudo gli occhi, come quando da bambina volevo sognare. Guardo l’orizzonte nell’eternità dell’infinito con l’illusione di essere immortale.
Affondo i miei piedi sulla sabbia, cammino sul mio destino, lascio un segno: le mie impronte resistono alle onde che, morbide, si infrangono sulla battigia. Un passo dopo l’altro, ho le gambe forti e senza fatica arriverò lì, al villaggio dei pescatori.
All’estremità dell’insenatura di Baccu Màndara vedo già i barconi che con i vecchi motori rompono la quiete del mare. Rallentano e si avvicinano alla riva dove i villeggianti li aspettano. Mi affretto per comprare pesce fresco e mi confondo tra i tanti che sopraggiungono e si preparano all’affare. I pescatori ormeggiano e balzano fuori dai pescherecci che tirano sul bagnasciuga. Le stadere pesano il pescato, le catenelle sferragliano sotto mani esperte che acchiappano i pesci guizzanti.
D’un tratto un pescatore afferra una murena e armato di bastone la massacra mentre quella si contorce sotto i fendenti. L’uomo si accanisce e con la rabbia del potente la prende a calci. La murena non ne vuole sapere di morire, lotta ma poi agonizza, spalanca la bocca e soccombe.
Sono nata in una città di mare, ma la scena mi impressiona. Mi viene in mente mio nonno che friggeva le murene e noi nipoti con le mani tese. Quella crudeltà sbiadisce uno dei miei ricordi più belli e mi cambia l’umore. Non compro nulla, rientro a casa con il cuore avvizzito.
Ora le onde sono violente e sbattono sulle mie gambe che cedono. I miei piedi si riempiono di alghe e si alza un vento di pietra.
Ho freddo.
I gabbiani sporcano l’aria con le loro grida stridule. Forse un presagio.
La mia ultima passeggiata, dopo pochi mesi mi sarei ammalata di Artrite Reumatoide e avrei iniziato a chiedere a Dio il perché di quel castigo.
La malattia spesso allontana gli affetti più cari.
Nella vita dell’ammalato c’è chi lo commisera e chi invece soffre con lui. Con chi lo commisera finge salute, non offre il suo dolore, che custodisce gelosamente. Con chi condivide si lascia andare; chi condivide ama, ascolta, veste di senso la sofferenza.
Ma a volte chi ti ama rifiuta il tuo dolore e ti chiede come stai per stare bene o non fa domande per scordare le responsabilità. E la malattia vince, rende chi ami simile a chi ti compiange: l’ammalato forte resiste, quello debole può lasciarsi morire.
Ti senti abbandonato e cerchi nella preghiera qualcuno in cui credere.
Non so se la mia fede potrà aiutarmi, e sino a quando.
Non so.
Però credo in chi ha cura di me, senza niente chiedermi e senza niente promettermi, credo in chi mi perdonerà di averlo dimenticato nei momenti felici della vita. È a Lui che mi rivolgo se mi sento perduta. Lui è nelle chiese vuote e nella mia umile stanza.
La fede è un dialogo muto d’amore e fiducia e la preghiera più ascoltata è il silenzio. Prego e non mi sento sola.
Ma a volte continuo a domandarmi il perché, e smetto di pregare.
E la solitudine ritorna.
Scrivo per il bisogno di parlare con chi non c’è.