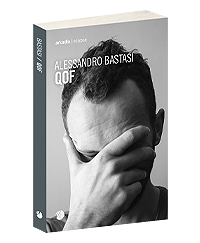Destini di sangue su Economiaitaliana.it
Economiaitaliana.it
luglio 2013
Sono 63 anni spesi bene (è nato infatti a Chicago il 6 maggio 1950) quelli di Jeffery Deaver, il maestro del brivido internazionale che, con quella faccia “un po’ così”, ha collezionato una lunga serie di bestseller, culminati nel 1997 con il colpo vincente legato a Il collezionista di ossa che Rizzoli ha da poco riproposto, nella collana bestBUR, a soli 4 euro e 90. Un capolavoro che ha visto il debutto del criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme e della sua bella collega Amelia Sachs e che, tradotto per il grande schermo per le intense interpretazioni di Denzel Washington e Angelina Jolie, ha contribuito a sostenere il percorso vincente di Deaver. Con il risultato di essere tradotto in 25 lingue, pubblicato in 150 Paesi e aver venduto oltre venti milioni di copie. A fronte ovviamente di una corposa produzione (si va dalla trilogia della giovane regista Rune al ciclo dedicato al cacciatore di location John Pellam e a quello di Kathryn Dance, dai dieci thriller legati al detective Rhyme ad altri undici lavori che spaziano su variegati personaggi, cui vanno aggiunte due antologie che raccolgono una serie di racconti brevi). Uno scrittore eclettico, dalla passione per i cani e per l’editoria, nonché autore degli undici testi delle canzoni contenute nel romanzo XO, incentrato su una giovane cantante country popche dovrà affrontare le malevoli attenzioni di uno stalker. Lui che aveva debuttato nel 1988 con Nero a Manhattan e che, da allora in poi, non avrebbe più sbagliato una mossa; lui che, per sua stessa ammissione, ha l’obbligo di regalare colpi di scena a ripetizione per intrigare il lettore; lui che i suoi protagonisti li propone sempre sull’orlo del baratro e a rischio sopravvivenza; lui che adora i cattivi delle sue storie e che si siede al buio in una stanza per immaginare le più orribili nefandezze; lui che ha un’unica vera paura: quella di scrivere un romanzo che non piaccia ai suoi affezionati lettori. E forse proprio per questo raramente sbaglia un colpo. Insomma, un bel tipetto, non c’è che dire, che ha “collezionato” una marea di riconoscimenti, vincendo – ad esempio – per tre volte l’Ellery Queen Readers Award for Best Short Story of the Year, poi il British Thumping Good Read Award, ilCrime Writers Association’s Ian Fleming Steel Dagger Award e anche il Premio Nero Wolfe. Ma veniamo al suo ultimo lavoro, La stanza della morte (Rizzoli, pagg. 590, euro 18,50), il thriller che riporta sulla scena del crimine Lincoln Rhyme e la sua compagna di indagini Amelia Sachs. Anche in questo caso alle prese con un omicidio misterioso: in una stanza d’albergo delle Bahamas un cecchino ha infatti ucciso un cittadino americano, tale Robert Moreno, noto attivista “a favore dei diritti dei popoli del Sud America”. Omicidio che sembra essere stato commissionato dal Governo degli Stati Uniti per sventare i suoi piani terroristici. In realtà, secondo i primi accertamenti, l’uomo si stava limitando a preparare una manifestazione pacifista. Ma allora chi ha realmente ucciso Moreno in abbinata ad altri due innocenti? A metterci la faccia saranno ovviamente i nostri investigatori che, sorretti dal loro intuito e dalla loro esperienza, seguiranno le tracce dell’assassino (forse un appassionato di alta cucina – le cui ricette menzionate nel libro, “culinarie e non omicide”, si possono trovare sul sito internet dello stesso Deaver – che sa come maneggiare come si conviene i suoi coltelli). E lo faranno senza peraltro trovare grande collaborazione da parte della polizia locale. Secondo logica (come già accennato, Deaver ci ha abituato bene) più i suoi due investigatori si avvicineranno alla verità più rischieranno in prima persona, a cominciare da Amelia che è rimasta a New York a seguire una certa pista che sembrerebbe portare… Tutto questo mentre nella “stanza della morte vengono prese decisioni che ancora una volta rischiano di confondere colpevoli e innocenti”. In sintesi: mischiando misteri e avventure, cuore e batticuore, realtà e finzione, Deaver riesce a manipolare a piacimento la storia, scandagliando – a fronte di un ritmo che non concede pause – i lati più oscuri dell’animo umano.
Passiamo ora da un primo della classe a un debuttante di settore, che ha però alle spalle una carriera da far invidia in quanto autore televisivo, radiofonico e di strisce, nonché regista, sceneggiatore e collaudato scrittore per ragazzi. Non deve quindi sorprendere più di tanto che Marco Di Tillo, al suo primo tentativonoir, abbia fatto centro. Inventandosi una bella storia, di quelle nere che più nere non si può, con tante teste tagliate via dai corpi (si tratta di anziani trucidati e quindi fatti a pezzi nei vari sobborghi della nostra Capitale); giocando di diritto e di rovescio con un ispettore insolito, che vive in una parrocchia ed è un “laico consacrato”, un finto-sempliciotto, peraltro dotato di grande umanità, che si occupa, nei ritagli di tempo, di giovani tossicodipendenti. È infatti su questa falsariga che si snoda il thriller Destini di sangue – Un’indagine dell’ispettore Sangermano (pagg. 50, euro 16,00), una chicca per intenditori, che si legge d’un fiato, pubblicata da Arkadia (una casa editrice nata a Cagliari quattro anni fa e che ha già in catalogo un centinaio di libri che spaziano dalla narrativa alla saggistica, dalla letteratura per ragazzi al cinema). A tenere banco, ovviamente, il citato ispettore, che di nome fa Marcello, pronto a rischiare reputazione e carriera pur di risolvere il caso. Riuscendo a “salvarsi” in extremis grazie a un indizio fortuito che lo porterà a imboccare la strada più che stretta della verità. A titolo di cronaca, Di Tillo è nato a Roma nel 1951. Città dove si è laureto in Psicologia, dove attualmente vive e dove, come già accennato, ha ambientato gran parte di questo romanzo breve o racconto lungo che dir si voglia. Lui, personaggio fuori dalle righe, che aveva iniziato elaborando testi per fumetti e vincendo il Premio Paese Sera per una nuova striscia italiana (Piero) su disegni di Fabio Petrassi. E che in seguito sarebbe stato anche premiato da Hugo Pratt al Salone dei fumetti di Lucca. Ma queste sono soltanto briciole della sua lunga produzione, ben presto allargata a 360 gradi e benedetta nel 1978 dai primi lavori per RadioRai. E da allora non si sarebbe più fermato, passando anche al grande schermo nel 1988, quando ha diretto il giallo per bambiniOperazione Pappagallo, scritto insieme a Piero Chiambretti e Claudio Delle Fratte. Nel 1994 avrebbe invece debuttato la sua stagione dei romanzi, pubblicando con Einaudi Il giovane cavaliere, cui avrebbe fatto seguito, per Mursia, Tre ragazzi e il Sultano. Quindi sarebbe stato il turno, sempre per Mursia, delle favole illustrate Mamma Natale, Mamma Natale e i Pirati. Senza dimenticarci un sacco di altre “creazioni”, anche se è meglio fermarci qui in quanto faremo notte. Ci limitiamo pertanto a suggerire la lettura di Destini di sangue, cui a ruota è seguita la pubblicazione negli Stati Uniti di un altro thriller, The Other Eisenhower(edizioni Webster House), scritto a quattro mani con l’americano Augustine Campana. Una storia, in questo caso, che si basa su un fatto realmente accaduto a Londra nel maggio del 1944, un mese prima dello sbarco in Normandia.
Breve quanto intenso, anche se privo di particolari acuti, il romanzo Una notte ad Amalfi (edizioni e/o, pagg. 142, euro 14,50), un’inquietante storia che si sviluppa in pratica nell’arco di una sola notte, sulla costiera amalfitana ovviamente; una storia che è stata scritta dalla spagnola Begoña Huertas, classe 1965 (è nata a Gijón, anche se ora vive nella capitale iberica), docente all’Università Autonoma di Madrid e in diversi corsi di scrittura creativa, oltre che collaboratrice di alcune testate culturali. Una scrittrice dalla prosa senza fronzoli, che non manca di prendere posizione sulle illusioni, le disillusioni e le frustrazioni della società, alle prese con i tanti problemi che la crisi si è portata al seguito. Seppure in punta di penna, senza magari darlo a vedere. Come in questo lavoro (il suo primo a essere tradotto in Italia), che vede in scena una coppia di giovani sposi, Sergio e Lidia, che dalla Spagna arrivano a Napoli dove trascorrono una notte e poi in traghetto, via Positano, si trasferiscono ad Amalfi per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ma mal gliene incoglie: appena arrivati al bed & breakfast, una piccola costruzione incassata nella montagna, Lidia lascia il marito perché ha qualcosa da fare, forse una commissione da sbrigare. Ma non rientrerà più e Sergio, ovviamente in preda alla preoccupazione, si farà accompagnare nella difficoltosa ricerca da un tizio apparentemente sbucato dal nulla. Una ricerca per certi versi breve (ma decisamente lunga per come gli avvenimenti si accavallano), che finirà per cambiare le carte in tavola a tutti e tre questi personaggi. D’altra parte, come afferma l’autrice fra le righe del romanzo, è impossibile scappare dalla vita…
E che dire di Claudia Piñeiro, argentina di Buenos Aires, dove è nata nel 1960? Un gran bene. Lei che, oltre che a dedicarsi alla narrativa di settore, risulta attiva anche nella drammaturgia e nelle sceneggiature; lei che prima di trovare la sua strada ha lavorato per una decina d’anni come contabile (è infatti diplomata in ragioneria) oltre che come assistente manager in una società di un certo livello. Di fatto una penna fertile che si è fra l’altro aggiudicata il premio “Clarín” per il romanzo Le vedove del giovedì, pubblicato in Italia per i tipi de Il Saggiatore nel 2008 e che ha beneficiato di una trasposizione cinematografica. Ma sono stati soprattutto Tua (2011) e Betibú (2012), entrambi pubblicati da Feltrinelli, a sottolinearne il talento e a regalarle fama internazionale. Un successo che trova ulteriore conferma ne La crepa (Feltrinelli, pagg. 206, euro 14,00), romanzo vincitore del Premio Sor Juana Inés de la Cruz e nel cui canovaccio tiene banco un assunto: “È impossibile non notare una crepa, ma quando questa diventa visibile niente è più lo stesso”. Tanto più che le crepe della vita sono le più pericolose. Come quel terribile segreto (un morto ammazzato, un cadavere nascosto, nessun colpevole per la Giustizia) che tormenta l’architetto protagonista di questa storia, un uomo irreprensibile sul lavoro e in famiglia – dove ha a che fare con una moglie rompiscatole che non manca di martoriarlo in abbinata alla povera figlia – e nel cui quotidiano si trova ad avere a che fare con una giovane donna che si presenta in ufficio in cerca di una persona scomparsa, riaprendo così una pagina che sembrava chiusa per sempre. Una bella donna che sembra sapere molto su una “pratica” apparentemente sepolta nel tempo e nei cui confronti scatterà la molla della passione. Così la quotidianità andrà a rotoli, la famiglia si sgretolerà, il lavoro diventerà insopportabile (cosa peraltro comprensibile, visto che nello studio dove si dà da fare lui è l’unico dipendente, in quanto tutti gli altri sono associati e non sembrano dare peso al suo progetto di costruirsi un palazzo). Un contesto non certo ideale che lo porterà a riflettere e a chiedersi se non sia il caso di rimettersi in gioco, di diventare a sua volta una canaglia… Graffiante, amaro e attento ai temi sociali (come quello legato alla speculazione edilizia) questo lavoro, che attinge anche nel torbido e nelle disillusioni dei sentimenti, è di quelli che catturano.
Voltiamo ora pagina per assaporare un lavoro leggero, di una semplicità che richiama autori dei tempi andati, senza scene truci o situazioni da brivido, magari a tratti disarmante, ma sempre di piacevolissima lettura. Ovvero Natura morta in riva al mare (Piemme, pagg. 306, euro 16,90), un romanzo la cui forza risulta legata a un protagonista da copertina: l’abitudinario commissario Georges Dupin, uno scapolone che curiosamente conquista, oltre che per la sua simpatia, soprattutto per i suoi difetti e le sue manie, che a conti fatti lo rendono uno di noi. Lui che è nato a Parigi e che non sopporta le periferie “fuori dal mondo” (leggi Bretagna) dove, benché sia arrivato già da tre anni, lo considerano ancora uno nuovo del posto; lui che si porta al seguito, a mo’ di distintivo, un inseparabile taccuino rosso; lui che non vuole essere disturbato quando al mattino si dedica al caffè in abbinata alla lettura dei quotidiani. Lui collerico e svogliato quanto basta, che adora l’entrecôte con patate fritte, senape e vino rosso del Languedoc, che adora gustare a cena in un angolo appartato del suo ristorante preferito; lui che qualcuno è persino arrivato a paragonarlo al mitico Maigret di Georges Simenon. Paragone per la verità un po’ azzardato, anche se bisogna ammettere che il personaggio creato da Jean-Luc Bannalec – nome de plume di un debuttante che vive fra la Germania e il Finistère meridionale, del quale non si sa volutamente altro proprio per alimentare come si conviene la dietrologia – si propone aspro quanto accattivante, bonario quanto singolare, ancorché brusco e un po’ gigione. Lui che se può scantonare da un caso lo fa con piacere, magari proponendosi “fuori servizio”. E lo vorrebbe fare anche quando gli viene comunicato che, nel pittoresco borgo di pescatori di Pont-Aven e quindi fuori dalla sua giurisdizione, c’è stato un omicidio un po’ strano: quello del novantunenne proprietario dell’Hotel Central (dove fra gli altri aveva soggiornato anche il grande Paul Gauguin), fatto fuori nel ristorante dell’albergo. Ma il commissario del posto è in ferie e le scuse accampate non tengono. Per di più, e ben lo sa, i casi gravi sono di sua competenza. Non bastasse, la stagione turistica è alle porte e bisogna risolvere in fretta questa brutta faccenda, anche perché il prefetto imperversa. Da qui un’indagine di quelle condotte sul filo del rasoio, fra le pressioni delle autorità locali e l’ostinata indifferenza della gente. Indagine che, curiosamente, sembra portare proprio a una tela del famoso pittore parigino e, appunto per questo, il caso sale ben presto agli onori della cronaca nazionale. Risultato: 300.000 copie vendute, i diritti già acquistati in una decina di Paesi, la pubblicazione del secondo romanzo di Bannalec – in quanto il successo va cavalcato come si conviene – avvenuta lo scorso aprile (per le edizioni Kiepenheuer & Witsch) e che a sua volta sta già scalando le classifiche di vendita.
Cambiamo argomento e mettiamo subito i puntini sulle i. Prendete un tizio che nella sua vita ha fatto di tutto: che ha lavorato in un negozio di dischi e ha trasportato sacchi di letame; che è stato responsabile di una libreria e di un pub; che si è reso protagonista di “diverse bancarotte”; che è diventato giornalista oltre che famoso sceneggiatore di fumetti; che è irriverente quanto geniale, visionario quanto eclettico; che sa divertire condendo le sue trame di ironia e di cinismo, oltre che di una robusta carica eversiva. Insomma, uno da prendere con le molle. Che di nome fa Warren (Girade) Ellis, il barbuto scrittore che è nato a Essex in Gran Bretagna il 16 febbraio 1968 e che si propone come l’inventore di X-Men e The Avengers, lavori che una volta travasati sul grande schermo hanno incassato, nei botteghini di mezzo mondo, la bellezza di un miliardo e 850 milioni di dollari. Dopo aver debuttato nel 1990 con la pubblicazione di un racconto di appena sei pagine, quattro anni dopo Ellis avrebbe realizzato il suo primo lavoro per la Marvel Comics, la qual cosa lo avrebbe in seguito portato a rivoluzionare il mondo delle storie a fumetti, influenzando il linguaggio e gli stili di grandi film di successo. Ma anche facendo proseliti su internet tramite blog e Twitter, oltre che con la sua seguitissima rubrica Good Morning, Sinners(Buongiorno, peccatori). Detto del personaggio, passiamo al romanzo, La macchina dei corpi (Longanesi, pagg. 292, euro 16,40), un thriller ben strutturato quanto geniale, dal quale negli Stati Uniti sarà tratta una serie televisiva. E la cui trama si può così sintetizzare: un uomo impazzito si mette a sparare sui vicini in un palazzaccio di Brooklyn. Il detective Tallow, del dipartimento della polizia di New York, interviene e riesce a bloccarlo, ma il suo collega ci rimette la vita. Intenzionato a mollare tutto, dovrà però cambiare idea a fronte di una scoperta casuale: in uno degli appartamenti difeso da una porta blindata vengono scoperte duecento pistole che, a un successivo esame, si riveleranno essere legate ad altrettanti omicidi commessi in città negli ultimi vent’anni. Per Tallow inizierà quindi l’indagine più complessa della sua carriera, fra i mugugni dei colleghi costretti a riaprire tanti casi irrisolti. Ma quale enigma si nasconde dietro la “collezione” di queste armi? E cosa c’entra Manhattan con Brooklyn? Più l’indagine si allarga, più il caso risulterà scottante. Perché ci sono uomini potenti in cattedra, le cui ambizioni si incrociano con quelle di un misterioso quanto metodico killer che si fa chiamare “Il cacciatore”. In sintesi: un lavoro spietato, duro quanto basta e a tratti anche divertente; un thriller di quelli che non si lasciano certo a metà.