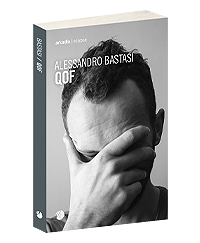Le ragazze con le calze grigie
DALMAZIA, 1917
Lontano, tra gli scogli, i riflessi del sole giocano sulle onde del mare. Mille cristalli che feriscono le palpebre, mentre le rondini attraversano le distanze, rincorrendosi come pensieri che arrivano fino a te, oltre questa distesa di acqua. Pianure e passi. Al di là delle montagne.
Quaggiù, invece, tutto soffoca nel grigio. E fatico a ricordare. Vorrei tornare da te. Vorrei ritornare da te, per dirti un’ultima volta addio.
Sono intrappolata in questa terra nera, Egon. Non troppo lontana dal rumore della guerra.
L’ospedale da campo, i letti di metallo tutti uguali e l’odore aspro di disinfettante.
Chiudo gli occhi. E posso vederti ancora. Posso, forse, seguire le rondini – minuscola tra le loro ali – il loro volo alto, piume accarezzate dal vento. Come piaceva a noi, guardare le cose del mondo diventare sempre più piccole, sotto di noi. Osservarle da altitudini non toccate dall’odio e dall’invidia, dall’orrore che sconvolge le terre e gli uomini.
Un giovane medico si avvicina. È quasi un bambino, penso. Abbiamo la stessa età.
Parla con un’infermiera. «Resti con lei, questa notte.»
Poi se ne va. E io, io ritorno da te.
Seguo le correnti altissime e quando mi sembra di poter toccare il sole, mi tuffo in un oceano fatto di buio, da cui pescare come perle le immagini che lego insieme.
Torno nella nostra casa, in quella Vienna che abbiamo odiato, abbandonato. Ma da cui non hai mai saputo staccarti davvero. In mezzo ai tuoi quadri. E anche se è passato molto tempo, il mio cuore batte ancora nel tuo. Sono una viandante che scopre la strada. Ma per ritrovarti davvero, devo ricordare chi sono.
OMBRE
Mi chiamo Walburga Neuzil. Sono nata il 19 agosto 1894 a Tattendorf, un paese nel distretto di Baden, che vanta più vacche e maiali che abitanti. Dove le case con i tetti spioventi spuntano da un mare di fango e letame e tutto è nebbia e poi bosco, e volti scottati dal sole e induriti dal vento dell’inverno.
È stata mia madre a darmi il mio primo cognome, Pfneisl. Quando conobbe mio padre, il giovane maestro venuto dalla lontana Kolomieritz, era una ragazzina dalle guance rosse, con poco sale in zucca e una gran voglia di vedere la città. Non ci pensò molto prima di allargare le gambe sui pagliericci di una stalla, accogliendo il suo seme tra l’odore di fieno e sudore. Forse la convinsero, intercalati dai gemiti e dai sospiri, i racconti dello straniero e la promessa di un viaggio sotto i tetti dorati di Vienna, le Promenade infinite dove passeggiano signore con gli ombrellini di seta. E nacqui io. Con buona pace del prete, della cara nonna e delle sue preghiere, e i suoi segni della croce sulla fronte china.
Ma si sposarono, sette mesi più tardi. Abbastanza per salvare l’orgoglio e mandare l’anima in Paradiso.
Così mio padre mi lasciò il suo nome e il vento inquieto di chi attraversa molti luoghi senza riconoscere una casa.
Antonia, Marie, Berta, nessuna delle mie sorelle è nata a Tattendorf. Seguimmo mio padre a Moosbrunn, e a Neudorf. A Mödling.
Fu solo quando lui morì che mia madre capì quanto si fosse sbagliata. Fu la morte dell’uomo che raccontava sogni a portarla nella grande Vienna. E non le sue promesse. Non gli onori di un titolo accademico né l’orgoglio di rivalsa. Ma la fame.
Ci arrivò con quattro marmocchie e una vecchia brontolona, nonna Pfneisl.
Vienna era grande, magnifica, sconfinata. Il cielo ingabbiato tra tetti e cupole. Vienna era un sogno che presto si raffreddò e divenne scuro come il piombo di cui sono fatti gli incubi. Ricordo un gioco che facevamo da bambini. La notte di Capodanno ci accalcavamo intorno al tavolaccio di legno della stube, con le guance accaldate per l’eccitazione e negli occhi i riflessi del fuoco. Scioglievamo una vena di piombo al calore di una fiammella. Ero io, la più grande, a reggere il cucchiaio. Poi lasciavo scivolare il metallo nell’acqua gelida e come uno stormo di galline, noi bambini allungavamo il collo per guardare dentro al secchio. Allora la mamma ci scostava, rabboccando le maniche fino ai gomiti, afferrava la sagoma solidificata da sotto l’acqua, e leggeva il presagio. Poteva essere un gattino per Marie o il cavallo di un bellissimo principe per Antonia. Ma per me e mia madre era sempre il duomo di Santo Stefano o la ruota panoramica. Vienna, i suoi mostri di pietra abbarbicati sulle facciate delle cattedrali, erano nella mia carne prima che i miei piedi sfiorassero le sue pietre nude.
Erano nella mia carne come l’uomo dinnanzi al quale persino la bella Vienna si inchinava. L’uomo che conobbi, di cui mi innamorai.
Mi chiamo Walburga Neuzil. Sono nata il 19 agosto 1894 a Tattendorf, un paese vicino a Baden, dove tutto è prato e poi fango, nebbia fino alle pendici dei monti e boschi neri, su in alto, a sfiorare i ghiacciai.
Lo ripeto finché torno a crederci. Per non perdermi e per ritrovare la strada.
Mia madre si chiamava Thekla Pfneisl. Aveva mani nodose e scorticate dalla terra.
Mio padre era Josef Neuzil. Morì quando avevo undici anni.
Guardo l’uomo ritto in piedi di fronte alla tela bianca che lo sovrasta. Ci sono soltanto lui e il rettangolo ancora vergine, che cattura tutta la luce della piccola stanza nera. Lui, e i suoi occhi tormentati, i capelli bagnati di sudore e le guance incavate. Lui, bellissimo.
È immobile, le braccia rigide lungo i fianchi. Il suo sguardo è fisso, non percorre la tela, non misura le distanze né gli angoli. Ma io so che nella sua mente ha già visto ogni segno, ogni pennellata, che violerà la pelle morbida della garza, le sue venature di gesso. Nell’altra stanza, una donna geme. Vuole vivere. Implora Dio di risparmiare il bambino che porta nel ventre. E lo fiuto sin da qui, l’odore della morte, delle viscere macerate dalla febbre.
Il velo si sfilaccia come nebbia trascinata dal vento.
Mi chiamo Wally Neuzil. Non sono nata nell’agosto piovoso di un paese della Bassa Austria, che forse è stato spazzato via dalla guerra.
Sono nata nella primavera del 1911, su una panchina di ferro battuto dell’Augartenpark, quando i miei occhi hanno incontrato la follia dell’uomo davanti al quale perfino la grandiosa Vienna chinò il capo. L’uomo che mi diede una casa, il mio unico nome, in cambio dei suoi demoni.
L’uomo che ora sta accarezzando la tela, prima di inciderne la carne. So che sarà il suo ultimo quadro. L’ultimo impresso con il suo nome: Egon Schiele.
Io sono venuta per lui. Perché la morte ci ha resi amanti e poi fratelli. Perché la morte ci riunirà di nuovo.
Sul quadro dipingerà La famiglia. Lui, nudo e accovacciato. La moglie Edith, rotonda e sciatta, seduta tra le sue gambe. E il bambino che dovrà nascere, ai piedi di lei. Una piramide di carne, volti scavati. Soltanto lo sguardo di Egon fissa lo spettatore e si tocca il petto, quasi a chiedere pietà. La donna e il bambino volgono i visi di lato. È lui che li protegge, il tramite con il mondo. Tutto inizia con lui. Persino Edith e il bambino sono soltanto feti partoriti dalla sua essenza, dal suo corpo che non è donna né uomo, ma li racchiude entrambi.
Egon. Lo osservo mentre dipinge il suo ritratto. In quei gesti brevi e sicuri che si sono fissati nella mia memoria.
Accanto ci sono i suoi dipinti, i fogli dei taccuini, gli schizzi. Molti sono stati venduti, ma i bozzetti, quelli li ha conservati, nonostante la gelosia di Edith e l’urgenza di quattrini.
Io sono lì dentro. Un lembo di me è in ciascuno di essi. Per una parte della storia, almeno: la parte che mi riguarda.
WALLY
Vienna 1911
1
L’ATELIER
Ero arrivata a Vienna da qualche mese. Ma avevo vissuto abbastanza la città per vedere il sogno di mia madre morire, pregno dello stesso tanfo che ammorbava l’aria nei vicoli fuori dalla Ringstrasse.
L’atelier del pittore era invece uno spazio senza tempo, che non apparteneva né a Vienna né alla mia infanzia. Mi guardavo intorno, frastornata dal bianco di pareti altissime. Sullo sfondo di calce il tavolaccio nero, le librerie nere, persino le copertine dei libri erano dello stesso tono di pece. Era come trovarsi minuscoli su una gigantesca tastiera di pianoforte. Io, mi sentivo uno dei tasti neri. Non li ho mai capiti, i tasti neri.
Soltanto due quadri appoggiati contro il muro di fondo spezzavano il rigore: il ritratto di profilo di una donna con i capelli raccolti e il corpo nudo e scheletrico di un uomo che si masturbava. Non sembrava felice né provare piacere, soltanto la figura uscita da un incubo, che somigliava molto al volto spigoloso del pittore, alle sue dita lunghissime.
«Quindi avete posato per il Maestro», l’uomo lasciò la frase in sospeso. Aveva preso una scala e si dava un gran da fare per posizionarla nell’esatto centro della stanza, accanto ai miei piedi. Ero seduta sul pavimento di legno a spine di pesce e aspettavo, come mi aveva ordinato lui.
Annuii.
«Eppure non ho mai sentito parlare di voi.»
«I pittori sono gelosi delle proprie modelle. Soprattutto il grande Klimt», abbozzai, tenendolo d’occhio.
Si sforzò di controllare un mezzo sorriso, quasi avesse intuito la mia bugia. Ma un istante dopo il suo sguardo era di nuovo sulla scala. Un equilibrista con le braccia tese per lo sforzo e il volto concentrato. A confronto mi sentivo una contadina che per quanto possa sfregare la pelle con la saggina non laverà via la puzza di sterco. Lui era elegante. Non nei vestiti, anche se il colletto della camicia era stirato di fresco e i pantaloni cadevano in un taglio dritto e perfetto, che avresti potuto trovare nelle vetrine della sartoria Goldman&Salatsch o negli atelier di Michaelerplatz. Era il suo sguardo scuro, quella lieve differenza di profondità dell’occhio sinistro per cui non sapevi mai cosa gli stesse davvero passando per la testa, a tenermi distante, come in sospeso.
Lui, un giovane uomo che si muoveva tra le sue cose, sicuro di sé in tutto quel bianco e quel nero, mentre io alzavo con un gesto impacciato la gonna per scoprire le ginocchia. Me lo avevano insegnato Vienna e Herr Lindner, il padre della famiglia per cui lavoravo nel fine settimana: gli uomini diventano improvvisamente più disponibili. Non serve molto, giusto qualche centimetro, pensavo mentre controllavo le reazioni del pittore, che sceglieva la tela con la stessa attenzione che avrebbe dovuto riservare alle mie gambe.
«Io non sono geloso delle mie modelle. Eppure i miei quadri valgono quanto quelli di Gustav.»
Cercavo di decifrare il tono della sua voce. Lo aveva offeso il paragone con il Maestro?
Avevo bisogno di quel lavoro, arrivato come un regalo. E se volevo tenermelo, dovevo darmi da fare per piacere al pittore.
«Voi non siete di Vienna», proseguì.
Restai a chiedermi se pretendesse una risposta o fosse piuttosto una semplice constatazione dovuta all’accento boemo ereditato da mio padre.
«Sono nata vicino a Baden e sono qui da qualche mese.»
«Sola?», chiese salendo sulla scala.
Mi stiracchiai sulle braccia ancorate al pavimento e sollevai il collo in una piacevole vertigine. I soffitti erano alti e il profumo di trementina pizzicava le narici.
«Con mia madre, mia nonna e le mie tre sorelle.»
«Sei donne e nemmeno un uomo», si sporse, appoggiando il braccio sulla cima della scala. Era sopra di me. I capelli, folti e scuri, fluttuavano nel vuoto come tentacoli di anemone. «Anche se avete spalle larghe e piedi da maschio, dovete fare attenzione, Fraulein Neuzil. Ci sono molti lupi, a Vienna.»
«Dovreste ringraziare i miei piedi da maschio. Sono stati loro a portarmi fino a voi.»
Il tono della mia voce sembrava divertirlo. Io invece bollivo e mi costringevo a tenere a freno la lingua.
Un lampo attraversò lo sguardo scuro. Sorrise mentre lo abbassava di nuovo sulla matita.
A dire il vero, non era il commento ai miei piedi sgraziati e tozzi come pagnotte a bruciare, quanto il ricordo dei lupi che avevo incontrato. Ma non riguardava il pittore. Sai il fatto tuo, Wally, e non gli devi nulla, pensai con orgoglio. Succede, quando convivi con la fame, il freddo, tre sorelle, una vecchia brontolona e una madre che se ne gira tutto il giorno con l’aria di chi porta sulle spalle la croce di Gesù Cristo. Capita quando, in sei più quattro, condividi due stanze e una cucina con una famiglia di rompiscatole, come i coniugi Berenstein e i loro due marmocchi. Non avevo neppure voglia di raccontargli delle occhiatacce che ci lanciava Frau Berenstein quando io e le mie sorelle passavamo attraverso il corridoio, con i vestiti appiccicati dall’acqua che ci eravamo spruzzate addosso in cortile e il respiro affannato per la corsa. E di quanto invece piacessero le mie canottiere sudate e l’odore delle mie mutandine a Herr Lindner.
«Mio padre è morto quando avevo undici anni e Vienna ci è sembrata il posto giusto da cui ricominciare. Un buon lavoro», già, pulire pentole e lasciarsi palpeggiare il sedere da un vecchio, «nuove prospettive», una topaia dai muri lerci di muffa.
Si era fermato. Ebbi l’impressione che non mi stesse più ascoltando. «Anche mio padre è morto. Avevo quindici anni. Sifilide.»
Ogni traccia di divertimento era scomparsa dal suo sguardo, inghiottita in un abisso che non riuscivo a smettere di fissare. Era diventato duro e immobile. Ma non c’era imbarazzo, quasi si divertisse a mostrarsi nudo, vulnerabile. Io, invece, avrei voluto scomparire sotto le listarelle a spina di pesce del pavimento.
«Ora potete togliervi quella…», disse alleggerendo la voce e facendo roteare l’indice sul petto, «camicetta e…»
Alzai un sopracciglio.
«E tutto il resto.»
Avvampai.
«Avete un gusto grazioso nel vestire. Mi piace soprattutto la gonna a fiori», l’entusiasmo della voce non bastò a mascherare la bugia. «Ma io sono Egon Schiele», dichiarò con irritante orgoglio, «non un disegnatore di tappezzerie o paralumi.»
«E poi», aggiunse prima che potessi ribattere, «non avete nulla da temere. Sono a una ragguardevole distanza di sicurezza», sorrise spalancando le braccia.
Hai bisogno di quei quattrini, Wally. Non essere sciocca. Non ora. Cosa potrà mai succederti? Niente è peggio della casa nera.
«Voi resterete… lassù?»
«Vista a volo d’aquila. È la prospettiva da cui voglio dipingervi. Non vi sfiorerò nemmeno.»
Avevamo bisogno di soldi. Di mangiare. Forse sarei riuscita a comprare delle uova, della farina, e ne avremmo fatto una torta. Forse… Il pensiero si perse nel ricordo del profumo dello strudel caldo, delle mele che si mischiavano con lo zucchero e la cannella, sciogliendosi sulla pastafrolla. Deglutii, sforzandomi di pensare ad altro. Osservai le mani del pittore. Avevano dita lunghe, nervose, ma curate. Molto diverse da quelle tozze, con le unghie incrostate di tabacco, del vecchio che di tanto in tanto mi alzava la sottana.
Dopotutto l’atelier aveva un’aria confortevole. E lui non era certo il peggio che potesse capitare.
Sbottonai la camicetta, la sfilai mentre lo sguardo guizzava verso il pittore. Aveva spalancato il taccuino e annotava qualcosa. Non era interessato ai miei movimenti. Tanto meglio. Mi sentivo seducente quanto un manichino di anatomia nello studio di un dottore. Abbassai la gonna, facendola scivolare velocemente sopra le caviglie. Sfilai un piede, l’altro.
«Anche quelle.»
Lo sguardo saettò verso la scala. Il pittore era ancora lì. Non si era mosso di un solo millimetro, assorto com’era sul foglio del suo taccuino. Non sembrava provare alcuna emozione, quasi fosse del tutto naturale chiedermi di restare nuda davanti a uno sconosciuto.
Anche quelle, le mie mutandine di lino grezzo. Trattenni il fiato, mi feci forza come a prendere lo slancio per un salto, e fix und fertig, ecco fatto.
Aspettai che il respiro si acquietasse. Sollevai gli occhi e incontrai il suo sorriso obliquo, un sopracciglio inarcato sulla fronte alta. Poggiava il mento sulle braccia incrociate, quasi a godersi il paesaggio dal finestrino.
«Decisamente meglio, Fraulein Neuzil. Voi siete un autentico Schiele.»
La voce mi accarezzò con la lenta soddisfazione di chi è abituato ad avere ragione. E io capii che per tutto quel tempo mi aveva osservata con un’attenzione di cui non mi ero accorta.
E adesso?
«Ora chiudete gli occhi e pensate a qualcosa che vorreste con tutta voi stessa. Qualcosa che volete ardentemente, cui non riuscite a smettere di pensare.»
Stetti al gioco e socchiusi gli occhi. Presi un bel respiro e mi sforzai di visualizzare il mio desiderio. Ma era più difficile di quanto previsto. Sapevo che stava studiando ogni dettaglio del mio corpo, le cosce rotonde e il seno immaturo. Il naso sgraziato. Ero esposta al suo sguardo, nuda, sotto una raffica di ghiaccio. Sentivo il leggero attrito della grafite che scivolava sul foglio di grana dura, il suo respiro lento. Ogni movimento, ogni suono nella grande stanza era amplificato e vibrava nel cuore. Ero al centro di una fanfara su di una piazza in festa.
«Concentratevi, Fraulein Neuzil», mi rimproverò. «Forse vi aiuterà pensare alla casa che avete lasciato, vicino a Baden. Il luogo dove si è nati ci è sempre caro.»
Una sensazione di disagio mista a nostalgia riempì la mente insieme al sapore di fango e latte appena munto.
«Il profumo dell’erba che vi solletica le cosce nude. Abbandonatevi su quel prato, godete del sole che vi sfiora il seno sotto la scollatura della camicetta. La brezza che scende dai ghiacciai, scivolando sulla vostra pelle. La avvolge nell’odore di pioggia e di muschio, inturgidisce i vostri piccoli, deliziosi capezzoli.»
Spalancai gli occhi.
«Fraulein Neuzil, concentrazione!», sbottò. «D’accordo», ammorbidì la voce, «pensate a qualcosa che a – ma – te»
Tornai a concentrarmi.
«Un colore o un profumo che vorreste sentire ora. Ricordate…»
A un tratto smisi di ascoltarlo mentre il palato si riempiva della fragranza della pastafrolla, dell’uvetta mescolata alla cannella. Era il sapore delle sere d’autunno. Di casa. Di mio padre e noi insieme. Quando avevamo poco, ma abbastanza per sopravvivere e non sentire gli artigli della fame che si conficcano nello stomaco e stringono le viscere. Cannella, zucchero. Uvetta. E un mondo distante mille paesi. Esistito forse soltanto nei miei sogni. Cannella, pastafrolla, mele di campo. Cannella, zucchero…
«Ora ci siamo», sussurrò. La voce del pittore era un filo di seta che si avvolgeva lento intorno alle mie braccia.
Le orecchie isolarono il suono della carta, del tratto continuo della matita sulla superficie rugosa mentre i battiti si acquietavano. Respiravamo insieme, allo stesso ritmo, in una stanza buia dai soffitti alti fino al cielo.
«Ti ha toccata?»
«Berta!»
Nella penombra della stanza, rischiarata appena dalla luce di una luna a picco che trasudava polvere di stelle, intuivo il viso impertinente di mia sorella, i suoi occhi lucidi di emozione e le labbra piene come scorze di albicocche. Marie e Antonia dormivano nel letto, sul lato opposto della stanza. Sentivo il loro russare lento.
Berta e io, invece, occupavamo il divano sotto la finestra. Io da un lato, lei dall’altro. Si era sollevata sul cuscino, dopo aver stiracchiato i piedi contro le mie guance.
«È vero quello che si dice? Che Herr Schiele tiene teschi e dita mozzate nel salotto di casa?»
«E perché dovrebbe?»
Il chiarore della luna disegnava la sua figura tonda, i capelli raccolti in due codine per la notte. Indossava la mia vecchia camicia. Le stava larga, ma ne andava fiera. «Per dipingere», sbuffò spazientita. «Come fanno tutti i pittori. Lo ha detto nonna. Quando è morto papà, ti ricordi? È rimasto nel letto un giorno intero, stecchito, e quel tizio gli ha fatto il ritratto. Era un pittore, ha detto nonna. Uno molto bravo.»
«Herr Schiele non dipinge cadaveri.»
«Già, ha dipinto te», sospirò con orgoglio e un certo sollievo, rituffandosi sul divano.
«Berta, queste gambe stanno diventando troppo lunghe», brontolai scostando di lato i piedi che si stropicciavano sul mio collo.
«Se sarò fortunata, diventerò alta come te!»
«Sai che non devi dire nulla alla mamma e alla nonna, vero?»
«E tu credi che non l’abbiano capito? Quando sei arrivata con le uova e la farina. E il pane fresco! Credi che non si siano chieste da dove venisse?»
«Dalla cucina di Frau Lindner!»
«Avevi tutta la gonna sgualcita, la camicetta con i bottoni allacciati storti», si era sollevata di nuovo sul cuscino e si sforzava di tenere bassa la voce, strozzata in un fiato acido e saccente da badessa. «Puzzavi di gatto», sibilò. «La sciarpa, era piena di peli.»
Mi pentii di averle parlato del pittore. Avrei dovuto immaginare che avrebbe fiutato la mezza verità e non avrebbe più mollato finché non le avessi raccontato ogni dettaglio.
«E Frau Lindner odia i gatti.»
La vergogna mi scaldò le guance. I gatti di Herr Schiele. Sarebbe stato tutto perfetto se non fosse arrivato quello stupido gatto.
«Mi ha dato dei soldi, perché posassi. E con quelli ho comprato quello che serviva al mercato di Leopoldgasse.»
«Lo sapevo», gongolò.
«I piedi!», sbottai per il dolore al fianco.
Berta piegò in fretta le gambe. «Quindi, ti sei spogliata!»
«No», mentii. «Gli piaceva la mia camicetta. E anche la gonna a fiori. Soprattutto la gonna a fiori», finsi fosse vero e che per un istante non avesse scambiato i miei vestiti per ritagli di tappezzeria. Intrecciai le braccia sul petto, fissando il soffitto. «E giravano dei gattini nell’atelier», continuai.
«Come vi siete incontrati? Perché ti ha scelta?»
«Berta!»
«Perché ha scelto te?», insistette.
«Non so. Ci siamo incontrati all’Augarten. Lui passeggiava. Io ero seduta su una panchina. È venuto da me, abbiamo parlato. Mi ha detto che era un pittore e io gli ho risposto che avevo posato per i migliori di Vienna. Anche per Klimt.» Era stato avventato e sciocco.
La verità era che la sua arroganza mi attraeva e mi respingeva allo stesso tempo. Non volevo capisse quel che ero davvero: una ragazza appena arrivata dalla campagna.
Avevo visto un quadro di Gustav Klimt nel salone dei signori Lindner, proprio sopra il divano dove Herr Lindner mi aveva fatta sdraiare la prima volta. Mi ero persa nel suo oro, negli occhi scuri della modella e fra le sue dita lunghe da fata. O da strega. Un giorno avevo sentito Herr Lindner dire ad alcuni ospiti che era un dipinto del Professor Klimt, il miglior pittore di tutta Vienna. Meglio persino di quegli arroganti pittorucoli francesi. Ne andava molto fiero e lo trattava come un tesoro. Nessuna delle cameriere poteva avvicinarsi tanto. Nessuna, tranne me. E avrei fatto volentieri a meno di quella gentilezza. Diceva inoltre che il Professor Klimt disegnava anche altre cose, cose da uomini, ma che forse sarebbero piaciute anche a me. Cose che sarebbe stato meglio tenere segrete. Ma di me si poteva fidare, giusto? Lo avevo lasciato parlare mentre mi perdevo nell’oro della strega per non sentire le sue mani e il suo fiato. Il nome del pittore, però, mi era rimasto ben impresso nella mente.
«E ci ha creduto?»
«Cosa?»
«Il pittore, ha creduto che fossi una modella?»
«Finché non è arrivato uno stupido gatto.»
Vidi il volto di Herr Schiele, con gli occhi acuti da folletto. Le labbra che si piegavano in un sorriso da canaglia sul mento lisciato di fresco e dall’aroma di colonia. Accarezzavo il gattino bianco, divertita dalla macchia nera che gli copriva il musetto tagliandolo di traverso come la benda di un pirata. E lui mi guardava.
«Il pittore si è scusato. Mi ha detto che di certo non dovevo essere abituata a quel disordine. L’atelier di Gustav Klimt era senza dubbio più ordinato.»
«E tu?»
«Gli ho risposto che sì, era molto pulito, ogni cosa al suo posto.» Mi ero ricordata di Frau Lindner, della sua mania per la pulizia e l’odio per i peli di gatto. Erano così, i ricchi. E Klimt doveva esserlo molto, se dipingeva quei quadri con l’oro. «E che non avrebbe sopportato di vedere un gatto gironzolare fra le sue cose», maledetta linguaccia sempre troppo svelta.
«Poi lui mi ha detto che il gatto si chiamava Diego», aveva preso ad accarezzarlo. Io avevo soltanto la mia camicetta addosso, ancora aperta sul davanti. E per la prima volta da quando aveva cominciato a dipingermi, mi ero sentita a disagio.
«Bel nome», ho risposto. «Un nome italiano.» Sentii ancora una volte la voce morbida e lenta del pittore, lo sguardo fisso sul gatto, la sua carezza lunghissima. Spagnolo, Fraulein Neuzil. Diego, come Velázquez, il pittore preferito da Herr Klimt. Aveva alzato lo sguardo. Lo stesso lampo soddisfatto di quando mi aveva vista nuda, sotto di lui. È stato lui a regalarmelo. A dire il vero, adora i gatti e ne tiene un’intera colonia nel giardino del suo atelier di Hietzingerstrasse. Ma quando avete posato voi, di certo erano tutti addormentati sotto i castagni.
Il cuore si era fermato di un battito.
«E lui? Ora non vorrà più vederti», concluse Berta con una vocina sconsolata.
«Al contrario», sospirai, «si è annotato il mio indirizzo.»