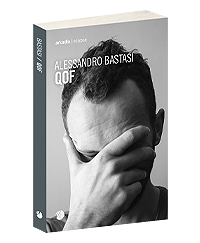“L’anno che Bartolo decise di morire” su Mork Mindy Ork
Il pianeta Ork torna a parlare di libri dopo la pausa natalizia e, coi suoi tempi, riemerge da un flusso di riflessioni in cui, al solito, i libri ne costituiscono più che lo spunto, fornendolo, quest’ultimo, la vita stessa e i suoi accadimenti, l’alimento, quell’angolo di mansarda, ideale e salvifico, in cui sono custodite le parole con cui dare forma ai pensieri non ancora definiti e la maturità successiva che è digestione di quell’alimento, trasformazione, ricaduta nel mondo reale, laddove i pensieri entrano in quello spazio fino a scendere ai piani bassi.
Quel collegamento tra vita e libri senza cui Ork non avrebbe il suo senso, quel filo sottile che non solo mette in comunicazione piani alti e basso reale, mansarde e cucine, ma si fa linguaggio che risente del libro medesimo per raccontare una storia nuova, un tassello di crescita, una maturità in divenire in un’accezione che è un accordo quasi musicale ed estetico con l’autore, con chi ha aiutato che l’aria diventi alimento e circoli e lo ha fatto in modo estremamente proprio, a tal punto da meritare di trovare ingresso nell’intima sfera del nostro pianeta.
“L’anno che Bartolo decise di morire”, di Valentina Di Cesare, edito da Arkadia, è il perfetto ingresso al nuovo anno per noi che non abbiamo più vent’anni e facciamo i conti con la fatica di una sistemazione esistenziale dentro cui sarebbe comodo stare lasciando fuori tutte le inquietudini di un tempo e di una generazione di cui sono il segno distintivo, è il pane e il vino, la mensa dei semplici di fronte all’inutile abbondanza, la semplicità di un pasto frugale e, intorno, gli eccessi del mondo, l’origine di tutto e il presente che si oppongono alle ansie del futuro, un ritorno necessario e un passo avanti ineluttabile, la difficoltà di tracciare la linea retta di un’ipotetica coerenza, il crollo delle giovanili certezze e l’ortodossia che genera morte in un’incompatibilità che non è solo il caotico magma in cui si traduce l’esistenza, ma una militanza ideologica e idealistica che fa i conti con la miseria umana e l’urgenza di trovare una via per continuare ad esistere.
Bartolo, custode di un museo d’arte, è l’emblema, volutamente indefinito in sé, di una coscienza che passa attraverso le vite altrui, di cui necessita per un fisiologico processo di mantenimento nel confronto: quelle di Lucio e di Vito, di Giovanni e di Renzo, di Roberto e del maestro Nino, una voce fuori dal coro, più intima che esterna, un Grillo parlante di un Pinocchio cresciuto, di un burattino che, assunte le morbide fattezze di un bambino, fa i conti con la durezza della vita e non sa cosa opporre fuori dall’evangelico sguardo incompreso e calpestato.
Non è casuale che l’identità di Bartolo venga saggiamente tracciata in forma indiretta, attraverso vicende altrui o passaggi nei quali egli è nella relazione, nell’ascolto, è testimone di nozze o destinatario di una lettera di addio, è il punto fermo di un mondo che cambia, è l’inossidabile resistenza alla vita che passa e che fa marcire le idealistiche spinte giovanili, che spegne i moti universali e chiude l’individuo in se stesso, gli preclude il desiderio o glielo limita a una dimensione utilitaristica e insensata.
Quanto questa vita che semina morte sia, poi, la vita e non chi ci è dentro è la riflessione immediatamente successiva sollecitata dall’evidenza racchiusa nell’esistere di Bartolo in funzione dell’altro: non solo, dunque, chi siamo noi fuori dallo spazio dell’altro, ma anche quanto siamo responsabili di un disadattamento indotto dall’agire esterno. Se l’altro cambia e cambia diversamente rispetto a noi, fermo restando che tutto scorre e nulla ne è esente, cosa ne è di ciò che siamo stati? Se il parametro esterno si inverte e io rimango fermo a un punto passato che porto, magari rinnovato, ampliato, al presente, che ne sarà di noi, di me e di quel punto fuori con cui ho condiviso tanta parte della mia esistenza? Andrà a rotoli ciò che è stato? Morirò? Moriremo in quelle forme pregresse? E cosa avremo dopo in cambio?
Bartolo non è Vito che è nelle scelte familiari, nella dipendenza da un padre che decide per lui, non è nella sua subordinazione agli eventi, nell’assenza di desideri; non è Giovanni, la linearità di un percorso tradita da un amore non rincorso tanto quanto avrebbe meritato, non è nel matrimonio di comoda apparente stabilità con una donna diversa da quella amata e non è nella “scarsa dimestichezza coi suoi fantasmi” che, invece, lentamente in Bartolo si fanno strada, nelle incomprensioni e nei silenzi, nella vacuità delle cose in cui non riesce più a galleggiare, tramutandosi essa in una liquidità da cui non resta che lasciarsi sommergere se Lucio, rispetto a cui Bartolo è, senza bisogno di non essere, decide che la partita della vita non ha più senso giocarla, se vieni licenziato e ripartire non ha più, per età e disillusione, il gusto della sfida, ma il sapore amaro della sconfitta.
E, qui, il riferimento si fa specifico, passando il registro da una dimensione atemporale e universale ad una storicizzata, legata ai tempi, a quello presente che, dimentico di ogni conquista di civiltà, spazza via ogni diritto e impone la forza di reinventarsi, ma anche quella riflessione fondamentale, nei limiti in cui non degeneri in un assolutismo negatorio, per cui il lavoro, che è fonte di sostentamento e potenziale e parziale latore di dignità, quando negata dalla storia individuale, non siamo noi: noi siamo chi portiamo, anche laddove le nostre azioni hanno una funzione a cui corrisponde uno scambio economico che ci tiene dentro un portone, piuttosto che nell’angolo freddo di una strada.
La voce di Bartolo è giunta su Ork dopo quella della sua autrice, ascoltata in uno strano e confuso sabato pomeriggio a Bologna. La sincera semplicità con cui ha raccontato la sua creatura è stato il più bell’incentivo a leggerlo prima di altro, unitamente a quegli accadimenti che ci dirottano su un autore, piuttosto che su un altro.
La crescita, i rapporti con il passato, le perdite, la fatica di agganciare il passato al presente sono, così, diventate le tappe inevitabili di un percorso a bivi in cui è assai difficile giudicare, trovare una verità facile a cui aggrapparsi per sentenziare e andare via dalla scena delle relazioni giovanili leggeri e senza “colpe”. Il punto di frattura è l’altro o siamo noi? È l’altro che è cambiato o siamo noi che, radicati alle certezze con cui siamo cresciuti, non sappiamo stare nel divenire delle cose e ci chiudiamo al mondo? E se la verità, ammesso che ne esista una, fosse nel punto di convergenza tra quello che l’altro non è più e ciò che noi non siamo ancora?
E, dunque, è facile comprendere come la morte del titolo sia una storia complessa, un luogo ipotetico in cui lo smarrimento di Bartolo di fronte agli amici, che, alla morte di Lucio, reagiscono quasi fossero fuori dall’impeto emotivo della vita, è il principio di una fine, la cui natura lasciamo che siano i lettori a scoprirlo.
Ci preme fare un’osservazione che troviamo peculiare e che coinvolge la voce dell’autrice e la casa editrice che ne ha sostenuto il talento in un’unità meta-geografica che congiunge l’Abruzzo, terra di origine di Valentina Di Cesare, alla regione sarda dell’editore fino a decretare uno stile che attinge al passato per farne una lingua con cui raccontare il presente in un neorealismo che concede poco al bisogno di toccare corde emotive che non siano quelle offerte dalla storia e dagli incastri degli eventi: è una terra senza nome quella di Bartolo, un po’ come lui agli esordi di questa avventura, ma è una terra forte, che risucchia, che vive dell’abitudine alla gravità delle vite che la popolano, quasi si potesse esistere solo nel lamento greve per una mancanza, un’assenza, nel lutto, in chi va via, nella partenza e nella disfatta, una terra antica che potrebbe essere l’Abruzzo o un sud d’Italia o un angolo di Sardegna, fuori dal sole delle coste e dentro le maschere scure che sono lo sguardo più sincero di quello che siamo prima dell’irruzione degli Issohadores.
Mentre sistemiamo la nostra posizione e la spostiamo costantemente, Bartolo resta qui, in questo principio d’anno: aiuta a decifrare conflitti e compare al nostro fianco tutte le volte in cui chiudiamo e basta, senza farci domande, sostiene la riflessione e ci conduce verso l’altro con la voce di Valentina.
Mindy