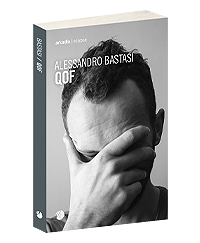Perché leggere “La cella di Gaudí”
Ilmiogiornale.org
8 febbraio 2013
Perché leggere “La cella di Gaudì – Storie di galeotti e di scrittori”
Il ruolo di una prefazione è importante, me ne sono resa veramente conto un paio di anni fa, leggendone una che era così noiosamente accademica da farmi temere che potesse scoraggiare la lettura del raffinato romanzo cui si riferiva. Da Marcello Fois ci si aspetta che faccia le cose bene. E la sua prefazione a La cella di Gaudì non tradisce le aspettative: perfetta; in due sole pagine scende in profondità tanto nella condizione del detenuto quanto nel mestiere dello scrittore. È qui, inoltre, che si può trovare la definizione più esauriente e più elegante di cosa sia questo libro: «[…] è insieme un’antologia, una raccolta testimoniale, un catalogo di esperienze umane delinquenziali, una collazione di scritture e stili, un manifesto di tolleranza, una teoria di delitti e castighi.» Il libro raccoglie dodici storie di persone detenute nella casa di reclusione di Isili (una colonia penale agricola maschile in provincia di Cagliari), raccontate da altrettanti scrittori. Più in particolare, l’antologia costituisce la conclusione del progetto “Adotta una storia”, realizzato da più attori “illuminati”: oltre alla casa di reclusione, il presidio del libro “Carpe Liber”, l’associazione culturale “Il colle verde”, il marchio “Galeghiotto” del progetto “C.o.l.o.n.i.a.” e la casa editrice Arkadia. Commovente, destabilizzante ed edificante, capace di minare certezze e scardinare luoghi comuni: a questa forte carica sociale e umana si affianca un notevole valore letterario. La qualità dei racconti è, infatti, molto alta e pure la “architettura” del libro è lodevole, in quanto la voce dei dodici detenuti trova spazio anche direttamente, senza la mediazione degli “scrittori partner”. Già il sottotitolo, Storie di galeotti e di scrittori, suggerisce quale sia il punto di forza del libro: c’è un detenuto che racconta ad uno scrittore la sua storia; c’è uno scrittore che racconta quella storia a modo suo al lettore; c’è, infine, un lettore che legge quella storia raccontata a quel modo e non sa dire dove finisca la voce del detenuto e inizi la mano dello scrittore … ma non se ne cruccia, perché ciò che conta qui è solo imparare come va il mondo, imparare a vivere. Il libro ci mostra uno squarcio della vita in carcere, che resta drammatica anche se rivestita di letterarietà. Nelle parole di Victor Hugo Gonzalez – la cui storia è raccontata da Nicolò Migheli in Buscarse la vida – la sintesi lapidaria e senza appello della condizione di vita di un detenuto: «Il carcere ti toglie tutto e ti fa diventare niente.» L’umanizzazione del sistema carcerario è urgente, lo dicono i detenuti, lo dice la polizia penitenziaria, lo dicono le associazioni che operano in questo settore, lo dicono i dati sul sovraffollamento… Eppure, azioni significative in tal senso non se ne vedono ancora, anzi, si parla persino di riduzioni del budget per il lavoro penitenziario (interessante, in proposito, l’articolo di Daniele Biella L’imboscata contro Smuraglia e svuota carceri, pubblicato qualche settimana fa su Vita.it …). Perché? Forse perché ancora è dominante l’idea che in cella non si stia così male, che dopotutto lì ti danno vitto e alloggio gratis e ci mancherebbe che dovessero anche darti il lavoro quando fuori è pieno di disoccupati, che ci sono altre priorità … e così via con le guerre tra i poveri che fanno la fortuna dei potenti, liberi di scontentare tutti con la scusa del non poter accontentare tutti. Certo, anche stabilire l’idonea forma e l’equa misura di una pena è tutt’altro che facile, soprattutto se si affronta il problema con gli occhi delle vittime di determinati reati o dei loro familiari. Tuttavia, sarebbe d’aiuto tenere sempre a mente il principio ricordato da Marcello Fois nella prefazione a La cella di Gaudì: «[…] ogni penitenza, o penitenziario, che si rispetti non deve mai perdere di vista il concetto che punizione non è vendetta.» Più di una storia, in quest’antologia, riguarda immigrati, così che anche i temi dell’integrazione razziale e del razzismo vi trovano spazio. Sul punto, colpiscono fra tutti due passaggi. Il primo è tratto da Destiny. Le porte della fortuna, in cui Salvatore Bandinu racconta la storia di Collins Osaro Igbinoba: «Partiva senza le catene ai piedi, ma in fondo si trattava solamente di un dettaglio. […] Non più le catene. Non più galeoni a solcare l’oceano con le stive gonfie di carne e sangue: l’umiliazione indossa abiti nuovi e si serve di moderne strategie.» Il secondo è preso da L’uomo che non sapeva dare un nome ai fiori, in cui Savina Dolores Massa racconta la storia di Farhat Amor: «Ma forse Amor non sbaglia quando non vuole assegnare ai fiori il nome proprio, così come noi tutti dovremmo riflettere un poco, prima di dire: negro, cinese, cileno, indiano, bianco, parigino, afghano. Se avessimo imparato, nei secoli, a chiamarci semplicemente uomini e donne senza metterci confini, forse Amor non avrebbe mai conosciuto il carcere e noi tutti avremmo potuto definirci innocenti. Forse.»
E sono soprattutto le vicende dei detenuti immigrati a ricordarci che il corso della vita di un uomo deve molto alla fortuna e che nascere in un luogo piuttosto che in un altro, in un dato periodo storico piuttosto che in un altro, può fare – eccome – la differenza: «Non scegliamo noi la parte del mondo in cui nascere. Però, poi, ce la portiamo dentro, tatuaggio marcato di un’appartenenza. Non scegliamo, a pensarci bene, neppure il nostro padre e la nostra madre e loro non scelgono noi. Siamo il risultato di un miscuglio di colori presi a caso, di speranze represse, di combinazioni rubate al destino con molte incertezze. Nasciamo in virtù di circostanze fortuite.» (da La quinta stagione, storia di Gueorgui Ivanov Borissov raccontata da Giampaolo Cassitta). Loro – i detenuti – sono dentro, noi siamo fuori. Ma possiamo, dunque, ancora escludere che la nostra libertà e – si presume – la nostra onestà non debbano proprio nulla alla buona sorte? È vero anche, però, che – come insegnano, in particolare, la storia di Gueorgui Ivanov Borissov, quella di Pierluigi Forti raccontata da Anthony Muroni e quella di Pierpaolo Limbardi raccontata da Gianni Zanata – la buona sorte bisogna saperla gestire con saggezza e accortezza: «Agli altri vorrei far capire una cosa: che non bisogna mai giudicare le persone che stanno in carcere. Purtroppo, è facile finire dentro, uno nemmeno se lo immagina. Basta un passo diverso, e si finisce all’inferno.» (Pierpaolo Limbardi, Gianni Zanata). Anche perché, delle volte, è facile individuare la via sbagliata, ma difficile è resistere al suo fascino: «“La nostra esistenza è piena di coincidenze e di biforcazioni. Posso dire senza tema di smentita di avere, a ogni bivio, preso la strada sbagliata. E spesso ero perfettamente conscio di questo. Eppure c’è un qualcosa che non so spiegare, una sensazione, un brivido, un fremito, una scossa, che mi ha sempre dato un gusto estremo per quel che facevo. […] ”» (Quel grande imbroglio chiamato vita, Anthony Muroni). Non giudicate, dunque, si raccomanda Pierpaolo Limbardi, anche perché «per saper valutare e giudicare bisogna aver vissuto certe situazioni», come bene ha scritto Fabrizio Fenu (citato nel libro da Giovanni Leoni, la cui storia lo scrittore racconta in Il coccodrillo verde). Certo, un libro da solo non può bastare a risolvere un grave problema, a cambiare la mentalità di tutti gli uomini del mondo, ma può essere sicuramente un “propulsore di cambiamento” perché «[…] la cultura […] è già da sé ciò che ci rende migliori.» (Io esisto, storia di Mohammad Mohammadi raccontata da Claudia Musio). Grazie a questo progetto, i detenuti coinvolti – come ci rivela in queste pagine più di uno di loro – sono riusciti a sentirsi per un breve ma intenso tempo di nuovo Uomini, non detenuti. Interventi come questo e, in generale, tutte le attività che mirano al reinserimento sociale del condannato devono essere salvaguardati e incentivati non solo perché pienamente rispettosi dell’art. 27 della Costituzione, ma anche perché senza una guida è facile sbagliare o ripetere l’errore, come ci ricorda Massimiliano Pilo nel commento a Gola di lupo, in cui Michela Capone racconta la sua storia: «Ora ho capito che chi vuole cambiare può farlo, a qualunque età, ma c’è bisogno di persone che ti dicano qual è la strada giusta da seguire e come si deve agire per fare bene.»
Man mano che si avanza con la lettura, però, si fa strada nella mente del lettore l’idea che, forse, questo libro – più che a quelli che stanno dentro – serve a noi che stiamo fuori. Il progetto ha reso momentaneamente liberi i 12 protagonisti delle vite narrate, ma ora sono loro (e gli scrittori che li hanno “interpretati”) che – dalle pagine del loro libro – possono indicare a noi alcune vie per essere liberi per sempre.
Il “cast” de La cella di Gaudì al completo:
– Collins Osaro Igbinoba e Salvatore Bandinu
– Massimiliano Pilo e Michela Capone
– Gueorgui Ivanov Borissov e Giampaolo Cassitta
– Giovanni Leoni e Fabrizio Fenu
– Mohamed Ndyae e Michele Pio Ledda
– Mounir Hamdaoui e Paolo Maccioni
– Farhat Amor e Savina Dolores Massa
– Victor Hugo Gonzalez e Nicolò Migheli
– Pierluigi Forti e Anthony Muroni
– Mohammad Mohammadi e Claudia Musio
– Alexandru Aurel Olaru e Pietro Picciau
– Pierpaolo Limbardi e Gianni Zanata
(di Marcella Onnis)