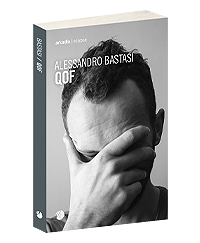L’arte della cucina. Tutti i sapori dell’isola da leggere e da vedere
La Nuova Sardegna
02.07.2010
C’era nel Trecento, poco distante da Sorso, un villaggio che si chiamava Géridu. Scomparso nei secoli, sta tornando alla luce grazie a una serie di scavi guidati dall’archeologo Marco Milanese. Bene: nel villaggio Milanese pensa di avere scoperto anche l’antico zilleri: «Potrebbe trattarsi di un’osteria, la prima mai identificata in uno scavo archeologico in Sardegna». E’ una delle cento e cento curiosità che si possono leggere nel volume «Sapori e saperi della tavola», il 12° della collana «Antichi mestieri e saperi di Sardegna», che sarà in vendita nelle edicole, da domani, insiene alla «Nuova». «A Géridu le case si concentravano a schiere e la vita si svolgeva su spazi comuni. Ma in uno degli edifici che si affacciavano su questi grandi cortili sono stati rinvenuti alcuni bicchieri in ceramica che recavano impresso nell’argilla lo stemma aragonese che identifica questi manufatti come misure pubbliche approvate per la mescita del vino». Mangiare e bere è un’attività primigenia e fondamentale dell’uomo. Ma subito, con il cibo e il vino, sono nate le tecniche per cucinare e per fare il vino. Cuocere e cucinare non sono la stessa cosa. Tra cuocere e cucinare c’è la stessa differenza che separa l’uomo primitivo da quello tecnologico. Cuocere è una necessità, cucinare un’arte. Oggi l’umanità è ossessionata dal cibo. Anzi, il cibo la divide in tre: la parte di quelli che non hanno da mangiare e muoiono di fame ogni giorno come le mosche, quelli che mangiano quel pochissino che hanno, quelli che non mangiano se non cose elaborate e reinventate dai grandi maestri della grande cucina. I sardi, che hanno conosciuto nei millenni anni terribili di fame, con l’avvento del turismo hanno poi imparato a trasformare la loro cucina tradizionale, ormai abbandonata negli usi domestici quotidiani, in una risorsa importante dell’accoglienza. Sono perfino rinati, sotto una veste appena rimodernata, antichi mestieri come l’uccellagione (quella che in passato forniva le ghiotte ghirlande di pillonis de tàccula), la caccia al cinghiale, alla pernice e alla lepre, la pesca di fiume e di mare nelle sue forme più diverse. Ormai esiste anche uno standard del cibo e della cucina tradizionali, che è quello offerto nei cento e cento agriturismi che popolano la Sardegna: menu che noi sardi riguardiamo con un tantino di superiorità, ma che costituiscono una ghiotta antologia del «mangiare alla sarda»: dagli antipasti figli dell’allevatore di maiali e del pastore fabbricante di formaggi non meno che del bosco e dell’orto ai primi di paste di ogni varietà (e con varietà locali indimenticabili, come la «suppa cuata» gallurese o il «pane frattàu» barbaricino) e secondi equamente compartiti fra gli arrosti quando il gestore dell’agriturismo viene a raccontarvi il mito dell’arrosto «a carraxiu», cotto sottoterra per nasconderne la provenienza, frutto di qualche «balentìa» festiva e i pesci, fra cui domina sovrana l’aragosta, che ogni chef presenta secondo la sua ricetta, vergognandosi di dire che il meglio è quella appena bollita, servita tiepida con un filo di olio extravergine di quelli che adesso decine di aziende sarde hanno imparato a fare alla grande. E poi la frutta e soprattutto i dolci, con mille nomi diversi e mille sapori inediti. Ultimo, colpevolmente, abbiamo lasciato il pane: ogni festa ne aveva (e ancora oggi in molti luoghi ne ha) uno speciale, come «sa pippìa ’e s’ou», la bambolina di pasta che stringe sul petto un uovo, simbolo pasquale della rinnovata fertilità della natura. Il libro non ricorda solo le cose, ma anche le persone: come Tzia Peppedda, la biscottaia di Orune, o «is turronargios» di Tonara, e insieme i grandi mercati civici, il mangiate e bere nelle taverne, gli antichi caffè delle città maggiori, l’immagine del cibo nell’arte e nell’artigianato sardi. – Manlio Brigaglia