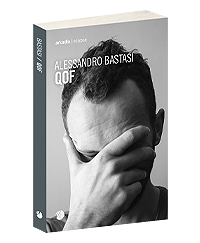La collagista
1
Cerco ancora un uomo che mi faccia desiderare il precipizio. Mi è capitato, tanto tempo fa. So che la crepa rimasta ha condizionato tutta la mia vita.
2
J’ai perdu mon alliance!
La donna in ginocchio sul marciapiede cerca la sua fede matrimoniale con le mani che tastano dappertutto a caso, gli occhi sono rigati di lacrime e ripete: «Mon alliance, mon
alliance!»
Mi inginocchio vicino a lei nonostante la pioggia, la sento gemere, ha appoggiato malamente i pacchi della spesa e mele, patate e scatolette sono cadute fuori, c’è una birra che sta per finire in frantumi e una scatola di fagioli che rotola verso la strada. C’è anche del latte in polvere e immagino un bambino che la aspetta a casa, bisogna fare in fretta, faccio caso alla marca di fagioli e alla birra, che ogni tanto compro anch’io. La gente ci guarda. L’aiuto, raccolgo il cibo, cerco a terra con la mano e trovo l’alliance che è finita sotto una panchina, un vero colpo di fortuna. Prendo
fra due dita il minuscolo cerchio d’oro giallo per darglielo, si mette a saltare e mi sorride.
“Alleanza, un bel nome per la fede”, penso. Mi accorgo che la pioggia sta aumentando, quelle piogge oblique a cui mi sono abituata, ma grazie al cielo il mio albergo è vicinissimo. Rallento, respiro, chiudo l’ombrello.
Porta a vetri, secondo portone. Gli alberghi dei quartieri periferici parigini sono labirinti che cambiano ogni giorno, pieni di fantasmi rapidi, visi che non riconosci o che riconosci troppo, quando ti fermi a bere con loro (e certe volte accade, se la solitudine ha bisogno urgente di essere placata).
All’entrata non mi aspetto mai quel neon anemico che mi ferisce gli occhi, non mi soffermo a guardare il riflesso, temo le mie mucose troppo esangui, tranne in certe giornate fortunate, quando i colori sono subito carichi di armonia, e mi sento abbastanza.
Una vita per riuscire a sentirmi abbastanza, per zittire la scimmia sulla spalla che mi ripeteva sempre: «Non va bene, non vai bene, non sarai mai abbastanza in questo modo, non ti vedi, sei inadeguata, sbagliata, fuori fase e fuori fuoco.» L’ho spinta via, la scimmia, l’ho lasciata sul marciapiede di una città che ho dimenticato.
Piove di pomeriggio da tempo, sono giorni di piccoli temporali traditori.
Giorni in cui la felicità della mattina rotola via, tutto si rannuvola con una puntualità crudele, sempre alla stessa ora: il cielo diventa polvere e petrolio, arrivano i tuoni e di solito quando accade sono lontana, non ho ancora organizzato niente, mi affretto e rientro con una scatola di biscotti, il succo di mirtillo dei colori nuovi, magari una tela, ma non basta mai, ho sempre questioni burocratiche da completare e non riesco a fare tutto, come oggi. “Almeno ho aiutato la signora”, penso aspettando l’ascensore, ricordando il suo sorriso gentile mentre si rimetteva la fede. In fon-
do nessuno mi attende, non devo rendere conto di pranzi, cene o colazioni, potrò fare qualcosa nel pomeriggio.
Terzo piano, doppia uso singola con la porta che cigola. La stanza è sempre sottosopra, i miei vestiti sono disseminati sulla moquette. Niente bianco, niente regole, niente perfezione e abiti piegati, il caos che conosco e la vita negli angoli, dove nessuno sa, ma io sì.
Mi stendo, ascolto musica classica o brani tribali che mi rasserenano, musiche dell’Uganda o del Congo che mi hanno fatto conoscere gli amici del bar Gilbert. Non avrei mai immaginato quanta energia in quei ritmi, in quelle voci, e nelle raffinate strumentazioni. Sul comodino sono impilati dei medicinali e degli integratori, vitamina D, magnesio, fiori di Bach e alcuni art journal dove spesso metto i fiori a seccare. I miei journal sono bellissimi. Un tempo non avevo idea di che cosa fossero, non avevo idea della loro esistenza, così sorrido pensando a quante cose sono cambiate negli anni. Un’artista italiana girovaga – una zingara pazza con i capelli viola e gli orecchini di perle giapponesi, lunghi fino alla schiena, che passava ore a dipingere farfalle o a decorare gabbie per cardellini – mi mostrò il suo journal per caso, quando ci incontrammo in un bellissimo museo nel sud della Francia. Lo teneva stretto fra le mani, lo cullava come un neonato.
«Vuoi sapere cos’è un art journal?» E scoppiò a ridere. «Difficile definirlo. Ognuno lo crea come crede, ogni artista gli conferisce un significato speciale. Il mio è un bambino, un cagnolino fedele, una fonte di ispirazione, un laboratorio che mi segue, ma è anche un assistente, ed è il luogo dove posso appuntare le mie idee prima di dimenticarle. Invecchiando dimentico con facilità ed è bello sapere che mi basta allungare una mano, prendere la penna, o il pennarello, magari un colore, e con un segno nel mio journal posso ricordare o riprendere lavori appena accennati, cose magari inutili, ma anche le cose inutili meritano riguardo, spesso sono ponti verso quelle utili. Lo sapevi questo bimba? Non sottovalutare mai le cose inutili, quello che conta è la luce che hai negli occhi quando le guardi.»
Mi allungò il suo quaderno, perché non riuscivo a spostare lo sguardo da quelle pagine spesse, con la copertina di carta e tessuto, qualcosa di grosso e sorprendente.
Lo sfogliai, la copertina era piena di disegni infantili fatti con colori cremosi, poi c’erano stencil scuri e il journal iniziava con una pagina piena di ali e di visi di donne sfumate. C’era scritto: “Qui c’è la sacra convergenza di presente, passato e futuro”.
Le sorrisi, lei stava arrotolando una sigaretta, notai un tatuaggio fatto con l’inchiostro rosso, un profilo di donna, e sotto la scritta “amore mio”. Continuai a sfogliare, in molte pagine quel profilo ritornava. Le toccavo con piacere, avevano diverse tessiture, c’erano aggiunte di carta velina, di velcro, c’erano delle piume, delle gocce di inchiostro porpora: era una raccolta di umori, di amori, di ormoni impazziti, di voglie, di follia artistica, era un insieme incomprensibile e ipnotico. Possibile mettersi a nudo così sulla pagina? C’erano pezzi di cartone rosso fuoco, buste, immagini, foto
antiche con gli occhi cancellati da una striscia nera. Non c’era una donna che non avesse gli occhi cancellati. Perché? Sapevo che non mi avrebbe mai risposto, ma le guardavo, le donne avevano vestiti color pastello, possedevano sguardi vaghi coperti di nero e bocche carnose, si finiva per notare solo le bocche. Ancora, però, non capivo. Ero molto scettica sul senso di quell’oggetto. Quello che diceva le somigliava, pensai che il journal fosse qualcosa di privatissimo. Per un po’ non ci ho più pensato, ma adesso non potrei più vivere senza, i journal mi accompagnano ovunque e so che ogni autore potrebbe spiegare l’uso in un modo diverso, ogni journal somiglia all’artista che lo crea o che ricrea quello di cui ha bisogno nel quaderno. Sono specchi, taccuini trasformati e personalizzati assemblando materiali diversi, carte e colori. Servono per scrivere, per sperimentare nuove tecniche, nuovi tipi di materiali, come tempere, colla, decorazioni, composizioni. Sono “contenitori” di memorie che altrimenti andrebbero perdute, scegli tu come costruirli, sono fatti di carta antica o di pagine candide, ci trovi fogli, buste, bigliettini, decidi di conservare foglie, pe-
tali di rosa che spesso, una volta seccati, puoi utilizzare su un collage, o su un trittico (il mio trittico delle rose, per esempio, deve al journal numero due tutti i materiali fondamentali da cui è composto). Puoi infilare la mano nel tuo journal e trovare chissà cosa avevi dimenticato, chissà quale scontrino, quale ricordo avevi messo lì per il momento, te lo ritrovi fra le dita e dal journal ritorna e rinasce. Sono occhi magici sul tuo passato e spesso sul futuro.