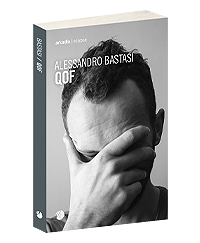“Stato di famiglia” su La poesia e lo spirito
Alessandro Zannoni
Stato di famiglia
Un autoreverse ripetuto che è un intercity nello stomaco. Così ho percepito fin dall’inizio Stato di famiglia di Alessandro Zannoni, una raccolta di racconti imperniati sul tema (ahinoi attualissimo) della violenza più estrema, bieca e strisciante: quella che si annida in seno alla famiglia. Attraverso questa struttura a ritroso, con capitoletti interni che partono dall’ultima, terribile scena e risalgono progressivamente agli atti preparatori, alle premesse mentali e fattuali di quell’esito conclusivo, Zannoni spiega magistralmente la genesi dell’orrore, che inizia da dettagli banali nella loro “normalità” e poi, in un attimo, spiraleggia selvaggiamente verso la tragedia.
Sì, perché questi racconti sono intrisi di quel senso del tragico classico che si fonda sul dramma di una scelta nell’impossibilità di scegliere, sulla tendenza dell’uomo a diventare cieco nella e della sua tracotanza (ybris), arrivando al punto di sfidare e violare ciò che è giusto (dike). Che si tratti della dipendenza di una giovane madre dal demone del gioco, della gelosia di un poliziotto per una moglie provocante, dell’ossessione di una ragazzina per un coetaneo conosciuto in chat o della voglia di soldi e droga di uno sfaccendato, il movente del male compiuto è sempre una passione distorta, alterata; un attaccamento morboso, un senso del possesso deviato. Insomma, tutto ciò che appiattisce, annullandola, la tridimensionalità dell’essenza dell’uomo, ovvero, alla base, il libero arbitrio.
In questo senso, Zannoni riprende ma, per così dire, modifica sottilmente il senso greco del tragico, perché ipotizza un campionario di situazioni in cui l’uomo (o la donna, ché questo è un libro assolutamente bipartisan in tema di genere) crede di scegliere liberamente, ma in effetti è fin dall’inizio privo di qualunque libertà, costretto da una ananke (“necessità”) superiore alle sue stesse facoltà di comprensione. La sequenza “eschilea” degli eventi è predeterminata a partire dalla primissima scintilla di attaccamento/dipendenza, per cui non vi è la tipica sequenza “sgranata” di koros (appagamento-sazietà-arroganza), ate (cecità-errore) e ybris, ma un vorticante precipizio che, nella maggior parte dei casi, conduce rapidamente all’omicidio.
Si può dunque dire che i protagonisti siano esenti da responsabilità o scevri da qualunque possibile riscatto? La scrittura scabra e spietata di Zannoni esclude la prima possibilità, in quanto la loro distruzione (degli altri) e autodistruzione è di per sé condanna senza appello. Quanto al riscatto, ça va sans dire, è escluso. Ve ne potrebbe essere ove nel primo momento i personaggi avessero avuto la capacità di dire “no”. È il tema della tentazione, che seduce e solletica, attaccandosi (verbo che non torno a usare a caso) agli istinti più bassi, alle emozioni più disarmoniche, saturando gli spazi (versione riveduta del koros greco), accecando (ed ecco ate) e innescando la violazione del limite (e qui abbiamo la ybris).
Possiamo dunque affermare che Zannoni ha reinterpretato il tragico in chiave postmoderna sottintendendo una (sia pur non dichiarata) sensibilità cristiana, che si innesca nella concezione dell’unico istante (il primo) in cui il personaggio potrebbe rifiutare di compiere il male. In questo momento “primigenio”, però, è come bloccato da una forza superiore a lui, e che pur prende corpo dentro di lui. La visione eschilea, dunque, cede il passo a una viscerale ineluttabilità di stampo sofocleo, territorio nel quale, “cristianamente”, va a innestarsi il tema della scelta di non compiere il male, che però qui risulta sostanzialmente impossibile, a causa di un sistema di pressioni combinate che sono frutto della saturazione di stimoli e gravami propria della contemporaneità.
Tuttavia, in definitiva, la contemplazione di questi spaccati di orrore produce un inaspettato effetto catartico (quello che, per tornare ai classici, Aristotele riconosceva alla tragedia). Rimaniamo infatti tramortiti e sconvolti, ma, paradossalmente, svuotati e ripuliti. Forse perché, in alcuni casi, ci sentiamo diversi dai protagonisti di queste storie; forse, in altri, perché riconosciamo, in certi loro attaccamenti, i nostri stessi difetti e, specchiandoci in loro, li individuiamo junghianamente (ovvero, ne prendiamo coscienza), e così li scongiuriamo, o almeno – noi sì – possiamo provarci.
Un libro terribile e devastante, che lascia il segno. Da leggere per imparare ad andare oltre i nostri blocchi esistenziali più radicali e pericolosi.
Giovanni Agnoloni