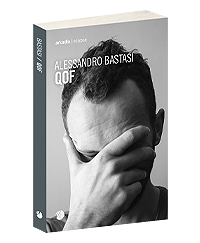Caribe
I contrabbandieri
Il mare si avventava con violenza sugli scogli e arrivava oramai ammansito alla caletta dove il gruppetto di uomini stava mettendo in mare la grande canoa fatta di un solo tronco d’albero scavato a fuoco, alla maniera indigena. La formidabile mole della nave ancorata a poca distanza dalla costa occupava col suo oscuro profilo l’orizzonte notturno che si confondeva col mare. I cannoni, le spingarde, i petrieri e i falconetti risaltavano alla luce di una mezzaluna che si rifletteva tremolante sull’oceano e sui fianchi metallici delle armi.
Alle spalle degli uomini riuniti sulla costa, si potevano ascoltare i rumori della notte antillana: sussurri, uno sfiorarsi di foglie, grida inarticolate, gemiti raccapriccianti, e tutta la gamma dei suoni che compongono la sinfonia della vita silvestre tropicale. Ma erano suoni inoffensivi. In quell’isola, oltre all’uomo, c’era un solo animale davvero pericoloso: il coccodrillo. E prima che arrivassero gli europei, gli uomini che vivevano lì erano innocui quasi come gli animali della selva.
La nave corsara stava sul chi vive, in attesa dei “mercanti di riscatto”, pudico eufemismo per ciò che, davanti alla legge dell’Impero Spagnolo, era puro contrabbando, violazione dei decreti reali emessi dalla Cancelleria del Reale Alcázar di Madrid, o a San Lorenzo de El Escorial, o al Palazzo Reale di El Pardo, o in una qualunque delle tante residenze reali. In quelle sedi, i membri del Consiglio delle Indie si affannavano a persuadere il re di turno e i suoi ministri ad aumentare le tasse sul commercio indiano, che tanto oro procurava ai mercanti della Casa de Contratación di Siviglia e ai suoi soci – clero e nobiltà – lasciando la maggior parte dell’impero a bocca asciutta.
Il contrabbando era la risposta degli indios più coraggiosi, disposti a sfidare i poteri di uditori e inquisitori pur di vendere i loro prodotti a un prezzo redditizio e sentirsi più liberi eludendo la minaccia della forca o del rogo. Il commercio “di riscatto”, il più delle volte, aveva gli eretici come controparte: luterani, calvinisti, ugonotti, e perfino inglesi antipapisti. Ciò significava ribellarsi non soltanto al governo di Madrid ma anche ai precetti della Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica e Romana.
Su tutto questo meditava il più anziano degli uomini, mentre con la piroga oramai in acqua remavano allegramente verso la nave che pareva aspettarli come se anch’essa, oltre al suo equipaggio, guardasse nervosamente all’eventualità di uno scontro con la Real marina spagnola.
Un altro gruppo di isolani era rimasto di guardia, spiando ogni indizio. La spedizione poteva andare male, e anche gli affari con gli onorati corsari – o privati imprenditori olandesi – potevano finire a coltellate. Poteva capitare di tutto: certi coloni erano tornati con le pive nel sacco; altri, saliti a bordo pensando di fare fortuna, erano spariti nelle sentine delle navi ed erano stati venduti come schiavi. A quei tempi ce n’erano bianchi e neri, senza troppe distinzioni. Soprattutto se la nave si dirigeva verso il Mediterraneo e vendeva il suo carico di ingenui ad Algeri o a Tunisi. Quando c’era di mezzo il denaro succedevano cose incredibili.
Se gli uomini appostati sulla spiaggia avessero sentito provenire dalla nave il minimo suono sospetto, l’avrebbero circondata sparando dalla costa e avrebbero chiuso l’ingresso della rada con una catena disposta da un capo all’altro, appoggiata sul fondo marino e pronta a essere tesa per impedire alla nave corsara di prendere il largo se avesse mancato ai patti.
Per gli stessi motivi di cautela l’uomo che stava in barca, con la pelle olivastra, tante rughe scavate nella cute indurita del volto e i capelli completamente canuti, era protetto da un doppio corsetto di cuoio di bufalo, come quello usato dai portatori di picca nei famosi tercios della fanteria spagnola, indossato sopra una fine cotta di maglia, e nella cintola teneva due pistole a miccia, di quelle moderne, fabbricate da armaioli italiani, col calcio d’avorio intarsiato. Aveva anche un pugnale, flessibile come un giunco, che non avrebbe nascosto le sue origini a un conoscitore di questi strumenti: veniva da Toledo. Al fianco sinistro portava una scimitarra damascena, del tipo a gladio, con la lama curva, più larga di una vera scimitarra, col filo su un solo lato e il controfilo sull’ultimo terzo del dorso. Il suo armamento era completato da un coltello nascosto nello stivale destro, se non vogliamo considerare come arma l’affilata fibbia che chiudeva il cinturone adorno di monete d’oro e d’argento di ogni paese: zecchini turchi, scudi spagnoli, e il cosiddetto dollaro del leone, che su una faccia aveva un cavaliere armato con uno scudo che mostrava in primo piano l’immagine di un leone rampante. Ma c’erano anche talleri tedeschi, pistole francesi, dinari, dracme, e un’infinità di altri scintillanti denari di quasi tutti i regni che battevano moneta. Qualcuna di quelle monete aveva strani simboli impressi sui due lati di oro brunito o d’argento lucido, e i profili di re, imperatori, sultani, papi, rajah. Su quel largo cinturone di foggia orientale era incollata una piccola fortuna.
In verità si trattava di uno strano vezzo in quei tempi e in quelle zone, dove la gente nascondeva i soldi e ostentava povertà per sfuggire ai ladri e agli esattori. Don Valdés doveva essere un irresponsabile esibizionista o avere una enorme sicurezza di sé per pavoneggiare in pubblico un simile cinturone. Chissà: forse voleva impressionare i suoi visitatori con lo sfolgorio dell’oro lucente e con la qualità dei suoi ornamenti, che denotavano l’uomo d’arme. Ciò non era affatto frequente in un negro o meticcio delle colonie spagnole: era molto più comune fra le genti d’Oriente, dove i potenti impiegavano negri di alta statura come guardie del corpo o guardiani del serraglio in cui tenevano mogli e concubine. Ma per custodire e convivere con le donne dei potenti dovevano rinunciare alla virilità e diventare eunuchi.
L’arsenale del meticcio era tutt’altro che ordinario fra i pacifici contrabbandieri e i piccoli agricoltori che dovevano sudare per ricavare discreti raccolti. Abituati alla zappa e all’aratro, gli abitanti dell’isola fuggivano i pericoli del mare e poco se la facevano con le navi proibite, che battevano le bandiere dei regni nemici di Spagna. Evidentemente, chi esibiva tali e tante armi non era un qualsiasi bracciante.
I suoi compagni non erano armati così bene e così riccamente. Solo alcuni, dalla faccia feroce e piena di cicatrici, avevano armi da professionisti, intarsiate, affilate e di buona fattura, ben più pericolose degli antiquati spadini e dei tromboni dei paciosi contadini. Armi che, peraltro, non dovevano essere sconosciute all’equipaggio della nave forestiera.
Dai tempi della conquista, centocinquant’anni prima, l’armamento era cambiato. Archibugi e moschetti sparavano sempre più precisi. Le frecce si usavano sempre meno, comprese quelle da balestra, che pure qualche decennio prima erano stimate più affidabili delle armi da fuoco. Oramai c’erano corpi specializzati di moschettieri, come il reggimento del re di Francia, che facevano parte della sua guardia del corpo personale.
Erano queste le cose a cui pensava il canuto comandante ricordando le infernali battaglie a cui aveva preso parte, e i viaggi verso zone incerte, mai raggiunte dall’uomo bianco. Nel frattempo, dalla sua posizione avanzata sulla piccola imbarcazione, prendeva nota di ogni movimento sulla nave all’ancora in mezzo alla baia, una delle tante che si aprivano sul lato nord dell’Isola di Cuba per la gioia dei pirati e dei corsari che brulicavano in quelle acque. Per i guardacoste reali era un difficile impegno, come del resto era difficile pattugliare le coste spagnole del Mediterraneo per respingere gli attacchi dei turchi e dei pirati barbareschi. Dunque, i mercanti stranieri che arrivavano sui litorali di Cuba senza permesso, e cioè tutti a quei tempi, dovevano prendere ogni genere di precauzioni per non farsi scoprire, inseguire, affondare o, Dio non voglia, essere catturati e torturati dal Sant’Uffizio. La riuscita degli scambi, evitando l’intervento delle autorità, dipendeva dalla loro previdenza.
La sagoma del vascello ingigantiva a ogni colpo di remo. L’occhio esperto di Valdés l’aveva classificato come una orca olandese, molto utilizzata per questo tipo di commercio. Galleggiava su uno specchio d’acqua profonda e a portarcela dovevano essere stati dei marinai in gamba, dato che vascelli di quel tipo, a differenza delle caravelle, pescavano parecchio e i marinai prudenti cercano ancoraggi solo in acque profonde e ben note. Quasi certamente, prima di entrare nella rada, avevano mandato in avanscoperta una scialuppa a esplorare i fondali, per non urtare scogli o inca- gliarsi nelle secche.
Oramai avevano affiancato la nave dalla quale, dopo aver dato la parola d’ordine, sarebbe scesa la scala di corda. Gli uomini di vedetta spiavano la linea della costa e i segnali con cui altre vedette nascoste, appostate al largo della baia, potevano annunciare la comparsa di un galeone o di qualunque natante in grado di dare l’allerta ai vascelli di Sua Maestà.
Sulla coperta che rollava, per Valdés un piacevole ricordo d’altri tempi, li aspettava un comitato di benvenuto, tutti armati, come d’uso negli affari di quattrini, che fanno nascere la sfiducia nel genere umano. Un odore conosciuto solleticò le sue narici mentre accennava a salutare il gruppo di ufficiali che lo aspettava in coperta e che lo ricevettero con onori e gentilezze: «Come state? Come va? Sta bene la sua famiglia?», e altre cortesie tradotte in castigliano da un interprete o traduttore che parlava le due lingue. Il capo degli isolani lasciava parlare gli altri e intanto ispezionava discretamente la dotazione di armi del vascello, la loro di- sposizione, le armi della gente in coperta, l’alberatura e gli altri indizi sulle capacità del comandante.
Il capitano portava un’armatura filigranata di una bellezza rara per queste zone delle Indie Occidentali, dove le corazze e gli altri accessori guerreschi facevano sudare di brutto chi si intestardiva a indossarli per far figura (tra l’altro, bisognava pulirli bene quasi tutti i giorni, per via del caldo e dell’umidità). Il calore, soprattutto, poteva quasi uccidere chi stava ingabbiato in un’armatura europea di sessanta o settanta libbre. Si chiamava “colpo di calore” ed era ben noto sui campi di battaglia del Vecchio Continente, soprattutto nei paesi del sud o sulle galere del Mediterraneo. In questo modo ignobile erano morti molti più guerrieri che per le armi dei nemici saraceni.
Nei Caraibi, i neri e gli europei naturalizzati seguivano l’esempio degli indios – che usavano abiti di cotone contro le armi di pietra dei loro simili, armi poco pericolose – e cercavano di vestirsi il più possibile leggeri; al massimo usa- vano, come don Valdés, una pettorina di cuoio duro o una cotta di maglia. Osservando la pesante armatura, il riccone cubano dalla pelle scura dedusse che il capitano era nuovo da quelle parti, novizio nel Mare delle Antille, delle Lenticchie, dei Cannibali o Caraibi, da cui prendeva il nome una bellicosa tribù che non si faceva scrupoli a mangiare un bianco o un nero o un indio: per loro erano tutti carne arrosto, lo sapeva per esperienza.
Improvvisamente, con stupore dei presenti, Valdés si rivolse al capitano parlando in fiammingo.
«Het Geachte», disse all’alto ufficiale, chiamandolo “vostra signoria”, «vorremmo sapere quali mercanzie trasporta il vostro vascello. Ve lo domando perché qualche settimana fa una nave inglese ci ha fornito molte delle cose di cui avevamo bisogno.»
L’uomo biondo gettò uno sguardo sorpreso sul meticcio che si azzardava a interrompere una conversazione tra uomini bianchi, valutò di buon panno i suoi vestiti e notò che alcune delle sue armi avevano ornamenti d’argento, cosa poco comune per uno schiavo. In effetti, per un uomo di razza negra era singolare il semplice fatto di andare in giro armato. Come se non bastasse, il cinturone pieno di monete confermava che non si trattava di un uomo qualsiasi. Il corsaro olandese si sarebbe detto soddisfatto di andarsene con quel bottino. Ma si rendeva conto che intorno alla sua nave, in ogni cala, in ogni spiaggia, c’erano isolani in quantità che tenevano l’imbarcazione sotto tiro e l’uscita verso l’alto mare era controllata dai compagni di questo meticcio dall’aria sorniona, che non era certo un tipo da lasciarsi defraudare impunemente.
Era altrettanto sorprendente che gli avesse rivolto la parola in ottimo olandese, quando tutti gli altri isolani dipendevano dalle traduzioni di un fiammingo che conosceva la lingua di Lope de Vega per essere stato prigioniero degli spagnoli durante la guerra di Fiandra.
Il capitano si riebbe dallo stupore, vide che gli isolani non avevano rimproverato né il meticcio per la sua audacia né si erano sorpresi per la sua insolenza, e capì che era lui la sua controparte.
Era il suo interlocutore.
Gli rispose in olandese: «Mi par di capire che siete voi al comando in questo affare. Siete anche uomo di mondo, visto che parlate più di una lingua. Siete stato in Europa?»
«In effetti, signore, parlo cinque lingue; anzi: sette, se contiamo l’idioma degli indios cannibali e un po’ di latino. Le altre lingue sono inglese, portoghese, francese e arabo, oltre al castigliano, ovviamente. In questo affare sono, per così dire, il più anziano. Mi chiamo Valdés, per servirvi, voi e il re di Spagna, che Dio lo conservi.»
Il capitano non mancò di cogliere l’ironia verso il re di Spagna, visto che l’affare da discutere consisteva appunto nel frodare il governo e il tesoro del re, che oltretutto era anche nemico dei Paesi Bassi.
«Ma veniamo al dunque», suggerì Valdés. «Facciamo i nostri scambi, in modo da beneficiarne sia la vostra repubblica sia i miei conterranei.» E si sedette su uno sgabello di cuoio, di quelli che si possono aprire e chiudere, che una delle sue guardie del corpo gli aveva messo a disposizione. Con un gesto, accennò ai suoi seguaci di accomodarsi sui banchi di legno sparsi sulla coperta. Riordinò le sue armi in modo che non dessero fastidio, e il capitano notò che i movimenti erano quelli di un uomo abituato a portare addosso e a maneggiare quella ferraglia micidiale.
Tutti si sedettero, tranne i cinque dallo sguardo duro, che – come in una manovra militare ben collaudata – rimasero a protezione del capo, uno esattamente dietro, gli altri appoggiati al bordo per fare in modo che nessuno potesse passare alle sue spalle.
Intanto lui, Valdés, aveva preso nota del fatto che la nave aveva due ordini di cannoni, montati su affusti all’inglese, con ruote piccole, per non disturbare il combattimento. Così si poteva ricaricare l’arma dalla bocca senza intralciare il cannone del lato opposto, anche quando si trattava di ricaricarli contemporaneamente. Molte navi europee usavano gli affusti da campagna, con ruote grandi e un palanchino sul retro, il che, dopo il primo sparo, ostacolava la ricarica. Sulla nave c’erano forse quattro cannoni da 16 libbre, più alcuni falconetti e petrieri. Non avrebbe potuto cavarsela contro una nave di linea dell’Armata Reale. Solo sfruttando leggerezza e velocità gli olandesi sarebbero potuti uscire indenni dallo scontro con un galeone, il tipo di navi con cui la Corona pattugliava acque e coste delle sue colonie americane.
Dopo aver discusso e concordato i dettagli dello scambio di prodotti europei proibiti e mercanzie antillane, il capitano invitò Valdés a una chiacchierata più ristretta: voleva sapere come avesse imparato lingue così diverse come il latino e l’idioma dei Caraibi.
Si staccarono dal gruppo formato dagli ufficiali della nave, da qualche mercante di Rotterdam e dai rozzi contadini, mentre due o tre delle facce patibolari che accompagnavano Valdés lo seguivano, e spiccavano come un colpo di pistola durante una messa. L’ultimo rimase al comando di tutti gli altri che stavano in coperta. Anche il figlio del patriarca Valdés, Leonardo, detto Nardito, quasi bianco come l’olandese, si unì a loro.
«Mi dica dunque, señor, come ha potuto imparare tutte le lingue che ha elencato, in particolare quella della mia patria», domandò il capitano versando vino da una bottiglia. Il meticcio rifiutò gentilmente il bicchiere. A porgergli un’altra bevanda, vino di Porto, fu il suo silenzioso guardaspalle, che per un momento tralasciò di accarezzare il calcio di un pistolone mentre gli altri stavano anche più all’erta: uno sulla porta della cabina, un paio incollati a opposte pareti, e il figlio di Valdés a fianco del padre, anche lui in piedi per poter usare le armi rapidamente in caso di necessità.
«Ah, è semplice», dichiarò il vecchio, «quando ero molto giovane, nel secolo scorso, fui catturato da certi corsari europei e con loro ho navigato in parecchi mari e oceani. Una volta sono stato anche nelle Fiandre. Quanto ad apprendere le lingue, ad Amsterdam una cortigiana fiamminga mi fece da maestra. Come voi ben sapete, Amsterdam è una città cosmopolita, dove approda gente che proviene da tutto il mondo conosciuto. Ma sono stato anche in Africa e nelle isole del lontano nord, come l’Islanda, a caccia di balene, narvali, orche e capodogli. Però non ho avuto il tempo di imparare la lingua degli islandesi e dei norvegesi, che dominano l’isola, malgrado gli sforzi di una delle loro femmine che cercava di insegnarmela: c’erano altri affari in ballo e mi mancò il tempo.»